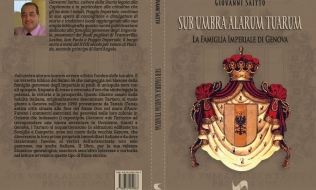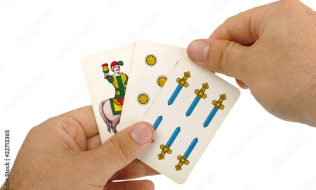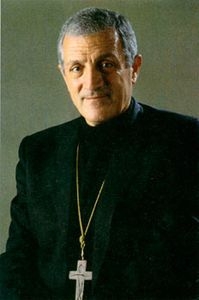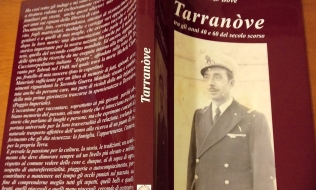L’Europa è nata in pellegrinaggio a Compostela

Su di un marciapiede, in prossimità della “Puerta” (la Porta del Cammino di Santiago de Compostela), è incisa in diverse lingue europee – tra cui l’italiano – la seguente frase: “L’Europa è nata in pellegrinaggio a Compostela”.
Un viaggio a Santiago de Compostela, che si abbia l’intenzione o meno di affrontare anche il famoso “Cammino”, vale sempre la pena di farlo, sia per la bellezza dei luoghi da visitare, sia per la spettacolarità dei monumenti e delle opere da ammirare, che paiono riemergere dal passato per offrirsi allo sguardo di coloro che si recano a visitare quella splendida località della Galizia.
Per me e mia moglie, tale meta era in programma già da un po’, si trattava solo di organizzarci e partire, vista anche l’opportunità di imbarcarci a Bergamo Orio al Serio su voli diretti Ryanair per Santiago de Compostela, impiegando non più di tre ore. Ci siamo quindi andati lo scorso mese di ottobre e ne siamo rimasti davvero entusiasti; un soggiorno in un buon hotel in centro città, a due passi dalla zona monumentale, e un senso di cordialità e di accoglienza diffuso in ogni luogo che abbiamo frequentato, oltre all’ordine e alla pulizia in genere riscontrati, nonostante il notevole e continuo afflusso di turisti provenienti da ogni parte del mondo.
Santiago de Compostela è la città spagnola che, insieme a Gerusalemme (Terra Santa), Roma e Monte Sant’Angelo (Italia), simboleggiavano un tempo i centri della Cristianità. Infatti, sin dal Medioevo i luoghi di pellegrinaggio della Cristianità, secondo l’itinerario di Redenzione Spirituale – noto come “Homo, Angelus, Deus” – prevedevano la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo a Roma e di Giacomo a Santiago di Compostela in Spagna (Homo), alla grotta dell’Arcangelo Michele a Monte Sant’Angelo sul Gargano in Puglia (Angelus), infine al Santo Sepolcro di Gerusalemme e ai luoghi sacri della Terra Santa (Deus).
La città, che conta 93.000 abitanti circa, è il capoluogo della comunità autonoma della Galizia ed è situata nella provincia di A Coruña; è sede del governo autonomo Galiziano (Xunta de Galicia) oltre a rappresentare un importante centro universitario con più di 500 anni di storia. Nell’anno 2000 è stata la Città Europea della Cultura e, nel 1985, è stata dichiarata insieme al suo “Cammino” Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Ma è conosciuta soprattutto per la sua maestosa Cattedrale dedicata a San Giacomo e per essere la tappa finale di ogni pellegrino che decide di affrontare il “Cammino di Santiago di Compostela”. Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto l’importanza dei percorsi religiosi e culturali che attraversano l’Europa per giungere a Santiago di Compostela, dichiarando i percorsi “Itinerario Culturale Europeo” e finanziando adeguatamente tutte le iniziative per segnalare in modo conveniente “El Camino de Santiago”. Un “cammino” che consente di vivere l’emozione di attraversare la storia, la cultura e – più realisticamente – paesaggi straordinari, avvertendo la serenità senza tempo di un viaggio attraverso la bellezza.
Santiago de Compostela deve la sua fama all’apostolo Giacomo il Maggiore le cui sacre spoglie, secondo la tradizione, riposano nella splendida Cattedrale, capolavoro dell’arte romanica e barocca. La tomba e il suo ritrovamento risalgono al IX secolo, anche se Giacomo è morto in Palestina, come scritto negli Atti degli Apostoli. La “Legenda Aurea” racconta che “San Giacomo il Maggiore dopo l’ascesa di Gesù al cielo iniziò la sua opera di evangelizzazione della Spagna spingendosi fino in Galizia, remota regione di cultura celtica all’estremo ovest della penisola iberica. Terminata la sua opera Giacomo tornò in Palestina dove fu decapitato per ordine di Erode Agrippa nell’anno 44. I suoi discepoli, con una barca, guidata da un angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in Galizia per seppellirlo in un bosco vicino ad Iria Flavia, il porto romano più importante della zona. Nei secoli le persecuzioni e le proibizioni di visitare il luogo fanno sì che della tomba dell’apostolo si perdano memoria e tracce. Nell’anno 813 l’eremita Pelagio (o Pelayo), preavvertito da un angelo, vide delle strane luci simili a stelle sul monte Liberon, dove esistevano antiche fortificazioni probabilmente di un antico villaggio celtico. Il vescovo Teodomiro, interessato dallo strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tomba, probabilmente di epoca romana, che conteneva tre corpi, uno dei tre aveva la testa mozzata ed una scritta:”Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé”. Per questo motivo si pensa che Compostela derivi da Campus Stellae (campo della stella) o da Campos Tellum (terreno di sepoltura). Alfonso II il Casto (789-842), re delle Asturie e della Galizia, ordinò la costruzione sul posto di un tempio e i monaci benedettini nell’893 vi fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba dell’Apostolo (Peregrinatio ad limina Sancti Jacobi), dapprima dalle Asturie e dalla Galizia, poi da tutta l’Europa. Ed ancora oggi migliaia di persone, a piedi come i pellegrini medioevali, attraverso Francia e Spagna, percorrono il lungo e faticoso cammino lungo circa 800 chilometri.
Il cammino di fede si conclude con l’ultima tappa che parte dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di San Giacomo (circa 5 km), con l’atteso abbraccio al Santo e la partecipazione alla Messa del Pellegrino (ogni giorno alle ore 12:00). “Todo se comple”; è questa la frase che più volte si può trovare scritta sui muri o da qualche altra parte nelle ultimissime tappe, e vuole semplicemente significare che “tutto si completa”. Il Monte della Gioia (Monte do Gozo), che è semplicemente un’altura, una collinetta, assume un valore simbolico, poiché rappresenta la postazione dalla quale i viandanti riescono a vedere per la prima volta le torri campanarie e le guglie della Cattedrale di Santiago. Un tempo, in quel punto, i pellegrini piangevano (di gioia) dopo mesi di privazioni e fatiche, che il lungo cammino aveva comportato, ed è lì che si immergevano nelle acque del vicino Rio Labacolla per lavarsi e prepararsi all’incontro con San Giacomo (come un vero e proprio rito di purificazione).
In cima alla collinetta c’è un monumento che è stato fatto costruire dopo la visita del Papa Giovanni Paolo II in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 1989.
Il percorso più popolare del Cammino di Santiago de Compostela comincia sui Pirenei, al confine con la Francia, e procede lungo due varianti che corrispondono a due diversi punti di ingresso: Roncisvalle (in Navarra) e Somport (in Aragona). I percorsi si unificano presso la località di Puente la Reina, per dirigersi poi verso la Galizia attraversando i territori di La Rioja e Castiglia e León.
La via che va da Roncisvalle a Estella è ancora detta, in spagnolo, Camino francés, mentre quella che passa i Pirenei a Somport si chiama Camino aragonés, ma il punto di raccolta dei pellegrini è stato sempre per tutti comunque Puente de la Reina, con le successive tappe e, poi, finalmente l’arrivo a Santiago. Ma il pellegrino che aveva (e che ha) ancora fiato, si spingeva (e lo fa ancora oggi) a guardare l’Oceano Atlantico dal promontorio di Finisterra (finis terrae: il punto più estremo dell’Europa, un tempo considerato … la fine del mondo).
Nel cammino di Santiago de Compostela, le tappe, le soste, le visite, si rifanno tutt’ora, per quanto possibile, ai vecchi percorsi e agli antichi rituali di un tempo, che conservano un incanto esclusivo. Suscita sorpresa e curiosità scoprire che esistono tuttora persone che, sebbene nel terzo millennio, si mettono in cammino da sole o in compagnia per compiere uno sforzo che ha un sapore antico, un atto di fede che comunemente si ritiene ormai da tempo superato o, forse, riservato alle sole persone credenti o pervase da una fortissima vocazione mistico-religiosa. Ma non è così; il Cammino di Santiago de Compostela è percorso da persone di estrazione più disparata, ciascuna con il proprio vissuto, cultura, fede, e ciascuna con interessi differenti, che possono spaziare dall’amore per la storia, l’arte o soltanto per apprezzare l’ affascinate patrimonio dell’umanità presente. E sono in molti quelli che si avventurano e maturano questa esperienza, proprio perchè esso mantiene intatto il suo fascino, offrendo a ciascuno l’opportunità di ritrovare se stesso in un tragitto solitario, in cui si ha l’opportunità di astrarsi dalla quotidianità e di meditare in una sorta di contemplazione ascetica.
Ma, naturalmente, non tutti coloro che si recano a Santiago de Compostela propendono per il percorso completo, che è quello più faticoso; ognuno si regola in relazione alle proprie condizioni fisiche, disponibilità di tempo e quant’altro. Alcuni percorrono solo alcune tappe; altri suddividono il percorso in diversi anni; altri infine si limitano alla sola tappa finale, quella che parte dal Monte della Gioia e termina alla Cattedrale di San Giacomo.
Però vi è anche il cosiddetto “Cammino di Santiago Urbano”, che permette di percorrere, più semplicemente, l’ultimo tratto del “Cammino” verso la Cattedrale attraversando la “Puerta” del Cammino, la Via Sacra, Calle de Azabacheria e, finalmente, la vista della Plaza del Obradoiro con la Cattedrale, dove solo 33 gradini separano il pellegrino dal Portico della Gloria.
Ma Santiago de Compostela merita comunque una visita del suo interessante centro storico, dichiarato – come già detto – Patrimonio dell’Umanità.
Nel corso della nostra permanenza a Santiago, abbiamo anche noi percorso (in pullman) l’ultima tappa del “Cammino”, partendo dal Monte do Gozo fino alla “Puerta” (del Cammino), percorrendo poi a piedi il tratto finale (Cammino Urbano) fino alla Cattedrale.
Particolare attenzione abbiamo nondimeno riservato alla visita e all’approfondimento di tutta la parte monumentale della città.
Ecco una panoramica dei luoghi visitati.
Piazza dell’ Obradoiro
La Piazza dell’Obradoiro è il centro monumentale di Santiago de Compostela. Il suo nome galiziano sembra che provenga dalle botteghe degli scalpellini che lavorarono nella costruzione della facciata barocca della Cattedrale, che domina la piazza e sembra dare il benvenuto alle migliaia di pellegrini che raggiungono la località.
Gli edifici che circondano la piazza (la Cattedrale, l’Hostal de los Reyes Católicos, oggi albergo monumentale nazionale e prima ostello per pellegrini, il Colegio di San Xerome, sede del rettorato dell’Università ed il Palazzo di Raxoi, sede del Comune di Santiago) sono la rappresentazione dei principali poli della vita della capitale galiziana: la religione, l’educazione universitaria, l’attenzione al pellegrino ed al viaggiatore, e l’amministrazione pubblica.
Questa piazza ha, quindi, la peculiarità di riassumere gli usi e la storia millenaria della città: un giro di 360° permette di riconoscere a prima vista la presenza di diversi stili architettonici, sorti in più di 700 anni.
Al centro della piazza dell’Obradoiro vi è una lastra in granito, considerata dai pellegrini il “chilometro zero” ovvero il punto di arrivo di tutti i “cammini” che conducono all’Apostolo; su di essa è inciso il riconoscimento con il quale il Consiglio d’Europa ha dichiarato nel 1987 il Cammino di Santiago “Itinerario Culturale Europeo”.
Cattedrale dell’Apostolo Santiago
Sorge maestosa in piazza dell’Obradoiro, proprio sul luogo del rinvenimento del sepolcro dell’Apostolo, l’attuale Cattedrale romanica costruita a partire dal 1075.
Facciata dell’ Obradoiro
Quella dell’Obradoiro, ubicata ad ovest, rappresenta la facciata della Cattedrale maggiormente fotografata. Essa fu anteposta all’edificio tra i secoli XVII e XVIII come un grande telone decorativo; fino ad allora, un arco permetteva di vedere dalla piazza il Portico della Gloria, adesso protetto all’interno.
I 74 metri di altezza delle torri si raggiunsero a metà del secolo XVIII quando l’architetto Fernando Casas y Novoa, continuando la ristrutturazione iniziata nel 1670 da Peña de Toro, aggiunse le finiture barocche alle torri medievali. In mezzo, mise un grande retablo in pietra [Il retablo è una struttura complessa e fortemente scenografica, caratterizzato da grandissima varietà di materiali e stili figurativi, generalmente in legno, ma può essere anche in pietra o marmo] e grandi finestroni che danno luce all’interno, così come riflettono sugli ornamenti della facciata – scudi, volte, colonne, capitelli, pinnacoli – per creare un gioco di ombre. Il tutto è presieduto dalla figura di San Giacomo con abbigliamento di pellegrino, cappello, mantello e bastone.
Le scale di struttura doppia sono degli inizi del secolo XVII, e permettono di ssuperare il dislivello del terreno tra la piazza e la pianta della Cattedrale.
Entrando dalla porta della piazza dell’Obradoiro, prima di tutto si vedrà il Portico della Gloria e, dietro la colonna divisoria è probabile vedere persone che compiono il curioso rituale di battere tre volte la testa (delicatamente) sulla statua che rappresenta il Maestro Mateo, artefice dello straordinario Portico. L’abitudine pare provenga dagli studenti universitari che lo facevano come segno augurale (o scaramantico!) per avere intelligenza e successo negli esami. Un’altra versione assicura che se si esprimono tre desideri, uno di essi sarà esaudito.
L’imperativo della tradizione vuole che durante il percorso all’interno della Cattedrale si passi dalla cripta dove riposano i resti dell’Apostolo e poi salire sull’Altare Maggiore per abbracciare la statua di Santiago e contemplare la Cattedrale da una prospettiva diversa.
Passando dal deambulatorio si vedrà la Porta Santa, che si apre solo durante l’Anno Santo (quando il 25 luglio – ricorrenza della festività di San Giacomo – cade di domenica).
L’attuale struttura della Cattedrale romanica di Santiago de Compostela è il quarto edificio, in ordine di tempo, che viene eretto sul mausoleo dell’Apostolo San Giacomo. Infatti, dopo il ritrovamento nel secolo IX delle sue reliquie, si costruirono una prima cappella e successivamente una chiesa preromanica che fu distrutta nel 997 dall’invasione musulmana guidata da Almanzor. Nel secolo XI esisteva già una nuova basilica, ma nell’anno 1075 si decise di erigere una Cattedrale capace di ospitare le migliaia di pellegrini che giungevano sul posto, che è quella attuale.
Portico della Gloria
Concepito come atrio o nártex della Cattedrale, questa complessa struttura scolpita dal Maestro Mateo in soli 20 anni consta di tre archi. Più di 200 figure in granito compongono un messaggio teologico centrato nell’idea della salvezza. Nell’arco centrale, la visione apocalittica della Gerusalemme Celeste: Cristo risuscitato, circondato dai quattro Evangelisti e su di loro, nell’archivolto, i 24 anziani conversano tra loro mentre affinano gli strumenti con i quali intoneranno il canto della Gloria.
L’arco laterale sinistro è destinato a scene dell’Antico Testamento, e si appoggia su colonne che mostrano i profeti. Tra loro spicca la figura di Daniele, il quale mostra un sorriso che fece storia, in quanto la sua naturalezza ed espressività, insoliti nel Romanico, vengono considerati precursori di nuovi tempi artistici. Erano i primi passi del gotico a Compostela, annunciati anche dalla volta a doppia crociera. Il sentire popolare tuttavia sostiene che il profeta Daniele sorride di fronte alla bellezza della regina Esther, la figura femminile che ha di fronte. L’arco destro è invece dedicato al Giudizio Finale, e si appoggia su figure degli Apostoli Pietro, Paolo, Giacomo e Giovanni.
Il Patrono della Cattedrale, San Giacomo Apostolo, riappare nella colonna centrale di marmo. Questo spartiluce, plasmato con una rappresentazione dell’Albero di Jesé o genealogia di Cristo, mostra a mezza altezza le profonde orme delle mani pellegrine. Dietro alla colonna, il già citato Maestro Mateo inginocchiato, che è passato ad essere conosciuto come il “Santo de los Croques” (Santo dei Crocchi). La tradizione popolare infatti gli attribuisce il potere di trasmettere il suo talento a coloro che danno tre “crocchi” o testate.
Navate, Altare Maggiore e Cappelle
La Cattedrale conserva perfettamente il suo stile romanico originale; si tratta della tipica pianta a croce latina delle chiese di pellegrinaggio, con tre navate nel senso longitudinale e tre nella crociera. La navata centrale misura circa 97 metri ed è coronata da un triforio che circonda tutto il tempio. Questa galleria risultava un elemento molto utile nel Medioevo, quando molti pellegrini si vedevano obbligati a pernottare nella Cattedrale in attesa del primo ufficio religioso. Inoltre, imprime eleganza allo spazio interno la sua elevazione fino a 24 metri.
Alla navata maggiore si aprono quattro delle 16 cappelle della Cattedrale, che diventano 18 se si contano quella della cripta ed il chiostro. Quelle a sinistra sono la cappella della Comunione, di stile neoclassico, e quella del Santo Cristo di Burgos; le due cappelle a destra ospitano le collezioni di Reliquie, il Panteon Reale ed il Tesoro (e rientrano nel circuito delle specifiche visite del Museo della Cattedrale).
L’Altare Maggiore mostra il fasto dell’intervento dell’architettura barocca nello spazio romanico. Il Baldacchino di colonne salomoniche, che protegge l’altare d’argento e la cappella dell’Apostolo, è un’opera del secolo XVII. Domingo Andrade completò, con legni dorati, marmi, diaspri e argento, smisurati angeli ed uno splendore che arriva fino agli organi situati nei primi tratti della navata centrale, decorati da Miguel de Romay. In mezzo all’ abbondante decorazione hanno luogo i riti che compendiano le massime aspettative dei pellegrini (Messa del Pellegrino, abbraccio alla statua di San Giacomo, visita alla cripta dove riposano in un’urna i resti mortali del Santo).
Il percorso per i ‘bracci’ della crociera e l’absidiola permette di ammirare le architetture e le opere artistiche di diverse epoche. Un esempio è la cappella del Pilar, all’estrema destra del deambulatorio, decorata con motivi relativi al pellegrinaggio, come le conchiglie e la croce di San Giacomo. Vicino si trova la citata Porta Santa, seguita dalla cappella centrale dell’absidiola chiamata del Salvatore, punto di inizio della costruzione romanica nell’anno 1075.
L’uscita dal lato nord della crociera permette di dare un’occhiata alla cappella della Corticela, un antico oratorio benedettino del secolo IX (ristrutturato nel secolo XIII) unito al braccio nord della crociera, che conserva il suo carattere di parrocchia indipendente dalla Cattedrale.
Messa del pellegrino e il botafumeiro
La Messa del pellegrino si celebra in Cattedrale tutti i giorni alle 12:00 e durante la cerimonia si dà il benvenuto a tutti i pellegrini che hanno concluso il Cammino di Santiago, menzionandone il luogo di provenienza. Durante tutto l’Anno Santo si può vedere in funzione anche il famoso botafumeiro (un immenso incensiere o turibolo azionato con corde collegate a grandi argani). Il rito è molto emozionante e spettacolare: ci vogliono varie persone per far oscillare il grande incensiere e l’aroma che diffonde è particolarmente intenso. Per vedere tutto bene e non perdere i dettagli, la cosa migliore è trovarsi nel transetto. Quando funziona il botafumeiro (che è il turibolo più grande del mondo) la celebrazione della messa è affollatissima e bisogna quindi recarsi in chiesa in anticipo per trovare posto a sedere. Nei periodi in cui non entra in funzione, il botafumeiro rimane esposto nel museo della Cattedrale. Oltre che nell’Anno Santo, il botafumeiro viene fatto funzionare il 25 luglio di ogni anno (festa del Santo), durante le ricorrenze religiose più importanti ed in occasioni particolari.
Durante il nostro soggiorno a Santiago, alla fine della celebrazione della messa in Cattedrale delle ore 12:00 di giovedi 9 ottobre 2014, abbiamo avuto l’inaspettato ed immenso piacere di assistere al rito del grande incensiere in funzione; una vera sorpresa che abbiamo accolto con molta gioia. L’oscillazione del botafumeiro è spettacolare e lascia i presenti col fiato sospeso.
Chiostro e Museo della Cattedrale
La verticalità della facciata principale della Cattedrale rompe il peso orizzontale degli edifici laterali: a sinistra il Palazzo arcivescovile di Xelmírez, a destra il Chiostro gotico – rinascimentale della Cattedrale. Questo è uno dei più grandi della Spagna, costruito tra il 1521 ed il 1590 dai migliori architetti castigliani del tardo gotico e l’entrante Rinascimento – Gil de Hontañón e Juan de Alava – per sostituire un Chiostro romanico. Il luminoso spazio, dedicato alla Vergine Maria, viene culminato da pinnacoli e merlature.
Il Chiostro è parte del Museo della Cattedrale, visita imprescindibile per meglio comprendere la storia della Cattedrale stessa nonchè della città di Santiago. Resti archeologici, arazzi, immagini, libri, reliquie e tanto ancora, offrono l’opportunità di ammirare ed apprezzare tesori unici al mondo, che pongono quasi in secondo piano sia il Chiostro che le due sopra citate cappelle della Basilica nonché la Cripta e il Palazzo Arcivescovile.
Palazzo Arcivescovile di Xelmírez
Il primo arcivescovo di Santiago, Diego Xelmírez, si fece costruire questa residenza dal 1120, dopo la distruzione del suo palazzo in una rivolta popolare sorta a causa degli scontri con le prime assemblee cittadine. Il risultato è uno straordinario esempio dell’architettura civile del romanico. La facciata attuale, aggiunta nel secolo XVIII, protegge un palazzo medievale con cucina, scuderia, cortile fiancheggiato dalla Cattedrale e sale ristrutturate nei secoli successivi. Tra queste spicca il salone sinodale del secolo XII, la cui immensa volta mostra scene di un banchetto medievale.
Hostal de los Reyes Católicos
L’Hospital Real, Ospedale Reale, fu costruito dal 1501 su ordine dei Re Cattolici, che avevano visitato Santiago nel 1486, constatando poca attenzione sanitaria verso i cittadini ed i pellegrini. L’architetto Enrique de Egas costruì l’ospedale in uno stile che saluta il tardo gotico e da’ il benvenuto ai primi venti del Rinascimento. La facciata retablo mostra una decorazione plateresca incorniciata dai grandi scudi reale ed imperiale, simbolo del potere della monarchia che sfidava la Cattedrale ed il Palazzo Arcivescovile. All’interno, attorno alla cappella gotica, si trovano quattro cortili sullo stile dei chiostri: i due anteriori sono del secolo XVI, quelli posteriori, del secolo XVII.
Le installazioni originali – un gran numero di sale per malati distribuite per sesso e classe sociale, camerate collettive per pellegrini sani ed un’ala per i bambini abbandonati nella “Ruota” – si ampliarono progressivamente per rispondere alle necessità sanitarie della città, fino al 1954, quando passò ad essere Parador Nacional, “Albergo monumentale dello Stato”. L’avvicinarsi alla terrazza dell’Hostal, proprio all’estremità che lo separa dal Palacio de Raxoi, permette di scoprire la Chiesa di San Fruttuoso, decorata dalle quattro virtù cardinali (anche se la gente le conosce come “i fanti delle carte”), in contrasto con il verde degli orti urbani, il Parco dell’Alameda a sinistra e, a destra, il vicino Monte Pedroso.
Colegio de San Xerome
Il rettorato dell’Università di Santiago de Compostela occupa oggi il Colegio di San Xerome, nel lato sud della Plaza dell’Obradoiro. Eretto nel secolo XVI dal vescovo Fonseca per accogliere studenti più bisognosi, questo edificio rinascimentale mostra un portale tardo gotico che appartenne in origine all’ospedale dei pellegrini dell’Azabacheria. Nei suoi stipiti spiccano le figure di San Domenico di Guzmán, San Giovanni Evangelista, San Giacomo, San Pietro, San Paolo e San Francesco d’Assisi e, nel timpano, la Vergine con il Bambino.
Palazzo di Raxoi
Questo edificio neoclassico, che prende il nome dall’arcivescovo fondatore, permise di completare definitivamente, nel secolo XVIII, quella che un tempo veniva denominata “Plaza del Hospital” (Piazza dell’Ospedale) e che, a partire da allora, fu poi chiamata “Plaza Mayor” Piazza Maggiore).
Fu eretto dall’ingegnere francese Charles Lemaur tra il 1767 ed il 1787 per servire come seminario di confessori e residenza dei bambini del coro della Cattedrale, oltre a carcere civile, ma divenne in seguito sede del Comune di Santiago. Oggi è anche sede della Presidenza della Xunta della Galizia. Il suo timpano è decorato dal rilievo della Battaglia di Clavijo, quel primo scontro in cui, secondo la leggenda, apparse la figura dell’Apostolo guerriero, per aiutare nel combattimento dall’invasione musulmana. San Giacomo, rappresentato come patrono della “Reconquista”, appare in cima alla costruzione.
Nella tradizione popolare e nell’iconografia di San Giacomo – soprattutto ispanica – è potente la figura del “Matamoros” (San Giacomo a cavallo con la spada sguainata nella mano destra e lo stendardo in quella sinistra, che schiaccia gli infedeli), alfiere celeste, intercessore e vessillo della ribellione della Spagna al dominio islamico.
Piazza della Inmaculada
La Plaza dell’Immacolata si trova incorniciata tra il Monastero di San Martìn Pinario e la facciata della Cattedrale sul lato dell’Azabacheria, che deve il suo nome alla tradizionale presenza di botteghe dedicate al taglio del “giaietto” (azabache, in spagnolo, è una varietà di lignite, durezza 3-4 scala di Mohs, quindi un materiale abbastanza fragile, di colore nero, un tempo utilizzato per i gioielli da lutto). Lì sbocca l’ultimo tratto urbano dei Cammini Francese, Inglese e del Nord, che entra nel centro storico per la Porta del Camino. La precedente facciata Nord della Cattedrale appare descritta nel Codice Callistino del secolo XII come “la Porta del Paradiso”, non soltanto per la sua bellezza, ma anche perché rappresentava la storia di Adamo ed Eva, il peccato originale e la redenzione. Di fronte si trovava la Fons Mirabilis, fontana oggi spostata al Chiostro, in cui i pellegrini si lavavano prima di entrare nella Cattedrale. L’ambiente medievale si completava con i tavoli dei cambiavalute, uniti ai venditori di scarpe, pelli e spezie, e locandieri che offrivano alloggio. Oggi la facciata della Cattedrale mostra tracce barocche e neoclassiche, in quanto fu totalmente rinnovata nel secolo XVIII.
Chiesa e Monastero di San Martín Pinario
All’interno della Chiesa di San Martín Pinario (oggi pregiato museo) è possibile ammirare, tra l’altro, l’antico “Coro in noce della Cattedrale” restaurato di recente, un vero gioiello della scultura rinascimentale in Galizia. Gli spazi accolgono le collezioni di arte sacra, il gabinetto scientifico, l’antica farmacia e la raccolta di libri antichi a stampa costituisce un prezioso compendio di arte e scienza tra i secoli XVI e XIX. Il Monastero de San Martìn Pinario fu fondato nel secolo X per ospitare un gruppo di monaci il cui compito era proteggere il culto alle reliquie dell’Apostolo. La sua estensione di più di 20 mila metri quadrati lo fa diventare il secondo più grande della Spagna, superato soltanto dall’ El Escorial. Nel 1494 passò a dipendere dalla congregazione benedettina di Valladolid ed un anno più tardi partecipava nella fondazione dell’Estudio Viejo, che diede origine all’Università. Già allora era il più importante monastero del territorio, e le sue rendite, provenienti da tutta la Galizia, permettevano nel secolo XVIII di dare elemosina ad un centinaio di poveri, un giorno agli uomini, un altro a donne e bambini. Fino alla sua soppressione, avvenuta nel 1837, possedeva la maggiore biblioteca della Galizia ed uno degli ostelli più grandi del paese.
L’edificio attuale mostra una facciata barocca che fu conclusa nel 1738 con una chiusura centrale barocca. Sul grande scudo di Carlo V si può vedere l’immagine equestre del Santo titolare, San Martín di Tours, che condivide il suo mantello con un povero. Al suo interno, che è parte del Seminario Mayor – ed apre altresì le porte come ostello in estate – si trovano tre imponenti chiostri dei secoli XVII e XVIII.
Piazza de la Quintana
“Quintana” è l’equivalente di “praça” (piazza), ed entrambe le parole indicavano nella terminología medievale gli spazi aperti di uso pubblico. La Quintana lo fu per eccellenza, delimitata dall’absidiola della Cattedrale, il monastero della fondazione, il cimitero dei canonici ed il primo palazzo comunale. La piazza sembra divisa in due piani; la parte inferiore, la Quintana de Mortos, fu luogo di sepoltura fino al 1780, quando per ragioni sanitarie e mancanza di spazio si optò per il cimitero di San Domingos de Bonaval, e più tardi, per l’attuale cimitero di Boisaca. La parte superiore della piazza, in contrapposizione, la Quintana de Vivos.
Ad est, le imponenti mura del Monastero di San Paio di Antealtares, fondato nel secolo IX da Alfonso II per custodire il sepolcro dell’Apostolo, compito che nel secolo XI venne poi assunto dal Capitolo della Cattedrale. I monaci benedettini furono sostituiti nel secolo XV dalle benedettine di clausura che oggi abitano questo edificio, ristrutturato nei secolo XVII e XVIII. Nella sua chiesa si può ammirare un interessante Museo di Arte Sacra che custodisce l’altare trovato assieme al sepolcro di San Giacomo. E, alle 20:30 di tutti i giorni (19:30 la domenica), si possono ascoltare i Vespri cantati dalle religiose del convento.
Dalla piazza è visibile la torre dell’Orologio della Cattedrale, orologio denominato con il curioso nome di Berenguela, in onore dell’arcivescovo Berenguel de Landoira che nel secolo XIV ordinò la costruzione della torre (all’epoca un robusto cubo difensivo in cui i merli non superavano l’attuale posizione dell’orologio), successivamente arricchita dall’architetto Domingo de Andrade, il quale aggiunse il coronamento e la decorazione barocca che circonda la maggiore delle campane della Cattedrale, chiamata anch’essa Berenguela, di 14 tonnellate di peso, la cui nota in “do grave” si può sentire allo scandire delle ore.
Ancora dalla piazza, sono visibili le lunghe mura barocche che proteggono l’absidiola romanica della Cattedrale verso la Porta Santa, meta dei pellegrini che arrivano a Santiago de Compostela nell’Anno Santo. Il suo atrio è fiancheggiato da figure in pietra romaniche provenienti dal meraviglioso “Coro in pietra” della Cattedrale, opera del secolo XII del Maestro Mateo, la cui ricostruzione è visitabile nel Museo della Cattedrale. Nella parte superiore dominano le figure barocche di San Giacomo e i suoi discepoli, Atanasio e Teodoro.
Gli estremi sud e nord sono occupati da due case barocche. Nella Quintana de Mortos, la Casa de la Conga o de los Canonigos, insieme formato da quattro case costruite nel 1709 da Domingo de Andrade e concluse da Casas y Novoa. Di fronte, la Casa de la Parra, che deve il suo nome ai frutti in pietra – viti e tralci – che lasciò il Barocco nella sua porta principale. Costruita da Andrade per il Capitolo della Cattedrale nel 1683 occupa il luogo del primo ufficio notariale ed il primo palazzo comunale di Santiago, abbattuto nel 1588. Oggi è un’attiva sala di esposizioni.
Centro storico
Il cuore pulsante turistico di Santiago è tra le strade Rúa do Franco e Rúa do Villar del centro storico; qui si trovano numerosi negozi di artigianato, souvenir, abbigliamento, e anche piccoli mercatini di libri e oggetti antichi. Sono molto tipici l’argento e il giaietto (una pietra di colore nero), oltre a tutto quanto è riconducibile al Cammino di Santiago e all’Apostolo (botafumeiros, gusci di capesante simbolo del pellegrinaggio, bastoni, cappelli, ecc.). E, ancora, ceramica, cuoio, le classiche cornamuse galiziane e le bambole delle meigas (nome che indica le streghe in Galizia). Parallelamente a queste vie se ne trovano altre due commerciali: la Rúa Nova e la Rúa Calderería che sono frequentate dagli abitanti di Santiago per i loro acquisti abituali.
Nella Rúa do Franco è interessante una breve sosta per entrare a vedere il chiostro rinascimentale del Collegio Fonseca, sede della biblioteca dell’Università di Santiago (Vedi sopra, Colegio de San Xerome).
In questa zona ci sono anche numerosi bar e ristoranti. Alcuni piatti tipici sono il polipo lesso con patate e paprika dolce (pulpo a feira), la spalla di maiale con cime di rapa o patate galiziane (lacón con grelos o cachelos), la empanada (torta salata), la zorza (macinato di maiale), i calamari, i peperoni di Padrón, cozze al vapore, zuppa di pesce, minestre (pote), pesce e frutti di mare; il tutto accompagnato da vino della Galizia (ad esempio Ribeiro o Albariño). Fra i dessert, due classici: torta di Santiago e liquore di Orujo (quello tradizionale è bianco, ma c’è anche alle erbe, alla crema, al caffé… ). Durante il giorno è interessante fare qualche sosta nei localini del centro per consumare le tipiche tapas (tipo stuzzichini), accompagnate da una bevanda di proprio gradimento (il nostro aperitivo).
Il Parco dell’Alameda, che si estende oltre le strade do Franco o do Villar, offre l’opportunità di una serena passeggiata tra viali alberati, fontane, sculture e costruzioni (cappella di Santa Susana, tempietto della musica, colombaia…). Inoltre, trovandosi a una certa altezza, è possibile ammirare un panorama fantastico sulla città, soprattutto della zona nuova, ove vive e svolge la propria vita la popolazione locale (qui sorgono i palazzi, gli uffici, i negozi, le boutique, gli alberghi,ecc.).
Il parco è collegato ai giardini del campus universitario attraverso una scalinata.
Sempre in centro, interessanti i Mercati Generali, che aprono di mattina e i giorni più importanti sono il giovedì e il sabato. Durante la permanenza a Santiago bisogna assolutamente visitarli: qui si trovano tutti i tipi di alimenti freschi, prodotti tipici, salumi, fiori, carni, pesci, formaggi, ecc.; attirano l’attenzione le venditrici che si trovano all’esterno del mercato: di solito sono signore che vengono dai paesi vicini per vendere i prodotti dei loro orti.
Notte
Vale veramente la pena fare un giro di notte nel centro storico partendo dalla Porta del Camino, la piazza di Cervantes, la via dell’Azabachería e subito dopo da San Martín Pinario a piazza Obradoiro, dove si potranno contemplare gli edifici monumentali illuminati che la circondano: la Cattedrale, il Parador dei Re Cattolici, il palazzo di Rajoy e il collegio di San Jerónimo. Non è raro trovare gruppi folcloristici locali che si esibiscono in canti e spettacoli tradizionali. E, poi, cercare un tipico ristorante per degustare un ricco piatto di frutti di mare, pesce, paella e quanto più si preferisce.
Santiago e l’Europa
Che l’Europa sia nata o meno “in pellegrinaggio a Compostela”, come riporta l’incisione sul marciapiede presso la “Puerta” (del Cammino), non è dato sapere; certo è che l’atmosfera che si respira a Santiago de Compostela è di quelle che non ti fa sentire affatto in terra straniera, ma che, al contrario, regala al visitatore la sensazione di trovarsi in un luogo piuttosto familiare, sebbene in presenza di una molteplicità di persone provenienti da nazioni diverse, ognuna con la propria lingua e i propri usi e costumi, ma ove tutti si sentono – al di là dei Trattati e delle fonti ufficiali ai quali far risalire la fondazione dell’Europa – accumunati da un unico e condiviso proposito.
I troccoli foggiani … ovvero “i ‘ndòrcele tarnuìse”

Ricorre oggi, 16 ottobre, la “Giornata mondiale dell’alimentazione” e desidero contribuire anch’io alla campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi e le sofisticazioni alimentari, rivolgendo il pensiero alle popolazioni ancora oggi malnutrite o che soffrono addirittura la fame.
E voglio farlo in maniera lieve ed estemporanea, parlando di un piatto tipico pugliese antico, sano, genuino ed elementare nella sua preparazione, semplicemente per rimarcare com’era bello un tempo, quando ci si accontentava di poco per star bene, in salute ed anche in spirito.
I troccoli foggiani … ovvero “i ‘ndòrcele tarnuìse”.
Quando si parla di pasta pugliese, il pensiero della stragrande maggioranza della gente corre istantaneamente alle orecchiette, soprattutto associate alle cime di rapa, un piatto divenuto il vero emblema della Puglia.
In verità sono tanti i tipi di pasta che il nostro territorio ha saputo plasmare nel tempo ed altrettanti sono gli abbinamenti possibili nella loro preparazione, per lo più con i prodotti locali e a seconda delle stagioni. Ma è soprattutto l’estensione della Regione pugliese che ha reso possibile (o necessario) variegare l’alimentazione, circostanza che oggi diventa opportunità di offerta culinaria per l’intera nazione e, perché no, anche per il resto del mondo.
La Puglia si estende dal Comune di Chieuti, a nord, fino alla punta più estrema della penisola salentina (Santa Maria di Leuca), a sud, per una lunghezza di oltre 400 chilometri; dal Mare Adriatico allo Jonio, facendo da contraltare a vari paesi e culture che si trovano sulle sponde opposte; dal Tavoliere ai rilievi appeninici, confinando con il Molise a Nord e con la Campania e la Basilicata ad Ovest.
In particolare, il Tavoliere delle Puglie (la seconda pianura più grande d’Italia, dopo quella Padana), la Daunia, la Capitanata, sono denominazioni di un unico territorio della Puglia, in provincia di Foggia, la patria del “grano duro”, ove sin dall’antichità si è sviluppata l’arte della preparazione della pasta fatta in casa e del buon pane, impastati con quella speciale semola rimacinata di grano duro, che qui sviluppa a pieno le sue pregiate ed esclusive proprietà nutrizionali.
Nell’impasto della pasta di semola rimacinata di grano duro non c’è bisogno di aggiungere le uova; il giallo naturale della semola, così come la sua intrinseca elasticità, consentono di preparare un prodotto genuino senza la necessità di incorporare ulteriori elementi, all’infuori dell’acqua.
Secondo l’opinione più diffusa, il nome Foggia deriverebbe dal latino fovea, cioè “fossa”, e tante erano le “fosse granarie” che riempivano le piazze dei nostri paesi della Capitanata, fino alla metà del secolo scorso. Ora le “fosse granarie” sono sostituite da moderni silos tecnologicamente attrezzati per la conservazione, il carico e lo scarico del grano; operazioni – queste – che un tempo venivano fatte a mano da esperti facchini. A Poggio Imperiale era fiorente un’apposita Cooperativa di facchini, detta dei “Carlentini”.
Il Tavoliere ha dunque rappresentato, nei secoli, una fonte di ricchezza per la produzione del grano, soprattutto quello cosiddetto duro, che veniva trasformato in farina, attraverso i suoi molteplici Mulini, ma anche esportato in altre località italiane e nel mondo.
Sorsero anche pastifici che cominciarono a portare nelle case la pasta già pronta (bella e fatta), contribuendo così ad alleviare il lavoro delle massaie … in attesa che arrivassero – molto tempo dopo – anche la lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere!
Ma la pasta fatta in casa o comunque la pasta fresca, magari preparata oggi con l’ausilio di moderni elettrodomestici che impastano, frullano, sbattono, ecc., resta un vezzo degli italiani in genere e c’è sempre qualcuno che ogni tanto ci riprova.
I “troccoli” sono una qualità di pasta tipica foggiana, molto gustosa e versatile (i truccule, in dialetto foggiano).
Vengono preparati passando sulla sfoglia dell’impasto, fatto semplicemente di semola rimacinata di grano duro ed acqua, l’apposito mattarello trafilato in bronzo, detto per l’appunto “trucculature”.
Vengono comunemente utilizzati anche “trucculaturi” in legno, ma sicuramente la trafilatura in bronzo consente alla pasta di assorbire meglio i sughi e i condimenti, esaltandone la qualità e il sapore.
I “troccoli” hanno una forma simile ai tagliolini, di consistenza un po’ più spessa, e con un profilo che va fra il tondo ed il quadrato.
Spesso i “troccoli” vengono confusi con la “pasta alla chitarra”, che viene invece preparata con la cosiddetta “chitarra”; un attrezzo antichissimo in legno munito di sottilissime corde di acciaio che tagliano la sfoglia in lunghe striscioline. Si adagia la sfoglia sopra le corde e si esercita su di essa una leggera pressione con un normale mattarello in legno, rullando avanti e indietro fino alla fuoruscita verso il basso delle striscioline di pasta (alla chitarra).
A Poggio Imperiale, i “troccoli” vengono comunemente chiamati “’ndòrcele”, termine probabilmente derivato da torcere, attorcigliare, ecc., così come chiamiamo “turcenelle”, quegli squisiti involti di budelline di agnello attorno alle sue delicate interiora, fatti rosolare sulla brace sfavillante, in una nuvola di profumo esclusivo che stuzzica le papille gustative. Si racconta che a Poggio Imperiale, tanto tempo fa, quando la fame era una cosa seria, un tal Cenzo Padredije (si dice che fosse un omone grosso e forzuto) abbia divorato non so quante pagnotte di pane pugliese casereccio, con il solo odore di “turcenelle”.
Ma torniamo alla nostra specialità di pasta fatta in casa, “i ‘ndòrcele tarnuìse”, un piatto povero d’altri tempi, che si arricchiva nei giorni di festa con la classica “brasciole”, l’involtino tipico delle nostre parti, di vitello o anche di cavallo, rigorosamente cucinato al ragù, con la salsa di pomodori locali, fatta in casa e conservata nei barattoli di vetro dopo il rito del “bagnomaria”.
Oggi si trovano in commercio, già pronti, anche i “troccoli”, e come per le orecchiette, cicatelli, fusili e le tante altre paste, anche i “troccoli” stanno vivendo nuovi connubi di vario genere, soprattutto con crostacei, frutti di mare, ecc., sulla scia di un tipo di pasta similare di origine campana, gli “scialatielli”, molto adatto a tali tipi di condimento.
Un tempo, “carne e maccarune” (pastasciutta con la carne) era sinonimo di abbondanza, di festa, di soddisfacimento del proprio bisogno nutrizionale e di felicità. Ma era anche un antitodo per la pacificazione della gente poiché, con la pancia piena, meno erano le occasioni di astio e di litigio.
Oggi che c’è il superfluo, lontana tuttavia resta l’idea del pacifico vivere comune, e assistiamo giornalmente ad una continua conflittualità in tutti i campi, a cominciare dalla famiglia per finire ai problemi di natura sociale, economica, politica, religiosa e quant’altro. E gli scenari si stanno facendo sempre più nebulosi anche in campo internazionale.
La “Giornata mondiale dell’alimentazione”, che ricorre proprio nella giornata odierna, deve aiutarci dunque a riflettere maggiormente al riguardo.
L’evento promosso dalla FAO e dall’ONU, a partire dal 16 ottobre 1981, ha lo scopo di mantenere alto il livello di sensibilizzazione nella lotta per debellare la fame e la povertà nel mondo.
Perché è stato scelto il 16 di ottobre?
Al 16 ottobre 1945 risale la fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
Il tema di questa edizione è dedicato all’Agricoltura familiare: nutrire il mondo, preservare il pianeta, scelto per valorizzare l’attività svolta dall’agricoltura familiare e dai piccoli agricoltori all’interno dell’economia locale e mondiale. Un tema che sembra essere l’anticipazione della motivazione che darà stimolo e impulso all’Esposizione Universale “EXPO Milano 2015”: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Ospitare Expo 2015, rappresenta per l’Italia un’opportunità davvero unica; un’occasione di confronto con il problema del nutrimento dell’Uomo e della Terra ed un momento di dialogo tra gli attori che maggiormente influenzano la comunità internazionale intorno alle sfide più significative dell’umanità.
Foto: Lorenzo Bove 2014
Cantate popolari dei cafoni della Capitanata

Seguendo il filone della tradizione popolare e del dialetto poggioimperialese, riporto in questo articolo i versi di una cantata popolare dei contadini della nostra terra di Capitanata, che l’amico Giuseppe Castellano mi ha fatto gentilmente pervenire.
E-mail del 21 agosto 2014 da Giuseppe Castellano
Ciao Lorenzo
Ti invio delle strofette sui mesi dell’anno; me le raccontava mia madre fin da quando ero piccolo, le ho scritte così come le ho sentite. Ne ho delle altre che ti invierò ……
Nel frattempo tanti cordiali saluti a Te ed Elvira.
Giuseppe e Angela
Giuseppe Castellano è un estimatore del dialetto tarnuése, vuoi perché è nato a Poggio Imperiale, vuoi perché abita da tanti anni in Lombardia e, quindi, maggiormente sente il bisogno di rifugiarsi in qualcosa di personale, che più gli appartiene, e che gli consente di mantenere forte il rapporto con la sua terra natìa e la sua gente.
Abbiamo avuto occasione di rievocare insieme la parlata, gli usi, i costumi e le tradizioni del nostro amato paesello della Daunia, soprattutto nel corso dei nostri periodici incontri lombardi, essendo Giuseppe, con sua moglie Angela Fusco, uno dei più assidui animatori del gruppo “Amici de Tarranòve“. Ma ciò accade anche a Poggio Imperiale, quando ci incontriamo nel periodo estivo.
Qui di seguito la cantata popolare (dei ricordi d’infanzia di Giuseppe Castellano):
Strofette sui mesi dell’anno
Iennare
Iennare che lu ‘ncine ‘mane
Cèche l’occhie a tutte i pecurale
Cèche l’occhie a tutte i putature
Chi iastème u mèse de iennare
Febbraie
Ie so Febbraie e febbrarèlle me chiame
So’ u cape de la primavère
Se li iurne miie sarriene tutte
Facèsse ilà u vine ntà li vutte
Sel i iurne miie sarriene pare
Faciarrie cose de tremà
Marze
Ie so marze che la mia zappètte
Zappe e pure li facce li diune
Nte ne profumà de mie fumètte
Ca ie faccie i quarte de la lune.
Aprile
Ie so aprile cu ramagliètte
Fiurisce che muntagne e vallune
Magge ce la iode la giuvenètta
Die ce fa na bella lune
Magge
Ie so maggie chiu maggiore de tutte l’alemènte
Pentune pe pentune ce sone e cante
Sole i ciucce stanne allegramente
Giugne
Ie so Giugne che la mia sarrechie
La tielle la tiane e lu cuperchie
Addò truvarriie na donna vecchie
Schaffarcele vurriie nta li rècchie
Luglie
Ie so luglie cu carre rutte
È rutte lu carre è rutte la maiese
Tocche cumpagne miie ca è tempe asciutte
Se vè chiove ce perdime i spèse.
Auste
Ie so Auste che la malatie
U mèdeche mè urdenate la ialline
U mèdeche mè urdenate na chemposte
Lecènziie Signore a faccia vostre
Settèmbre
Ie so Settèmbre che la fichera mosce
Tutte u moscatelle me fenisce
Se l’annata miie va de presce
De pèrseche e de prechoche me la lisce
Ottobre
Ie so ottobre bone vennignatore
Mo me li a fa na vedegnate
Mi a stepà na votte de vine curdèsche
Mi a fa na donne che lu lètte frèsche
Novèmbre
Ie so novèmbre bone sumentatore
Sumènte nu poche pe mè e pe i vucèlle
Nate u poche pe li puverèlle
Dicèmbre
Ie so dicèmbre che la voce suprane
A i cinche iè Sante Nicole
A u vinticinche nasce u Rèdèntore
Mazze u porce senza avè delore.
I versi della cantata raccontano con estrema durezza il dramma di una civiltà contadina, presente da noi fino a meno di un secolo fa, facendo trasparire la differenza delle classi sociali che all’epoca discriminava le popolazioni, tra possidenti e cafoni (contadini in stato di vera indigenza, sfruttati fino all’inverosimile; condizione, questa, raccontata con maestria, nelle sue canzoni, dal nostro cantastorie apricenese Matteo Salvatore).
Ma si fa anche dell’ironia, peraltro neanche molto velata, là dove si dice, ad esempio, …”con licenza di Vossignoria, alla faccia Vostra”, riferito naturalmente al Signore, ovvero al Padrone.
E non mancano neanche riferimenti di natura allegorica, di costume ed anche argomenti un po’ più spinti, come nei versi ove si dice …
“ Sono Ottobre, un buon vendemmiatore,
ora me la voglio fare una vendemmiata (!),
voglio fare una botte di vino rosato,
e una moglie per un letto fresco (!)”;
ed ancora …
“Sono Novembre, un buon seminatore,
e mi voglio fare una buona seminata (!),
un getto per me e per l’uccello (!),
e un altro per le donne belle (!)”.
A buon intenditor, poche parole.
Ma qual’è l’origine di questa cantata?
Ho provato a fare delle ricerche accurate, al riguardo, risalendo ad una antica cantata, denominata “A chènzóne di mise”, attribuita ad un anonimo del secolo XIX, alla luce di alcuni studi portati avanti, presso la cittadina di Serracapriola (Foggia), da Giulio Gentile (1904-1998) e successivamente rielaborati da Giuseppe Gentile.
(Per approfondimenti: http://serracapriola.net/costumi/dizionario/accessori/radici/mesi.htm).
Qui di seguito la cantata popolare di Serracapriola, con relativa traduzione in lingua italiana:
I dodici mesi
A chènzóne di mise (la canzone del mese)
anonimo, sec.XIX
ricerca di Giulio Gentile (1904-1998)
rielaborazione di Giuseppe Gentile
Jennère
Jennère sònghe e jennère me chjème,
vaje è cacc’é occhje èi putèture
vaje è cacc’é occhje èi pequerère
e me fàcce chjèmè ‘u mèse de jennère.
Febbrère
Febbrèrèlle curte curte
o mégghje o pèje de tutte,
sì jurne mì fussene tutte
fècèrrì jelè ‘u vine ‘ntè li vutte.
Màrze
Sònghe Màrze che li mije zèppétte
‘ntè bùsanne dà mijè pumétte;
quanne fàcce ‘u quarte da lune,
è pèn’e vine fàcc’u dijune.
Bbrìle
Sònghe Bbrìle ch’i réme spèrte,
mò’ sciurìscene vèllune, mònte e vèllète
‘bbrile ce fè ‘u rèmègliétte
e màgge ce góde ‘a giuvenétte.
Màje
Sònghe Màje cchiù ‘rósce de tutte
l’èlemènte je ‘duc’ è tutte quante
è ógne pentóne ce sóne e ce cànte
pur’i ciucce stànne cuntènte.
Giugne
Sònghe Giugne c’à fèvecétte
trèntètré chèrète nu vèrelòtte,
ntè bbusànne da fémmenè vécchje,
chè se nnò te sture ‘na récchje.
Luglje
Sònghe Luglje ch’’u càrre rótte
rótte ‘u càrre e rótte ‘a mèjése,
tòcche cumpagne mì, mò ch’è jè sciutte
ch’è se vé è chjòve ce buzzèrème tutt’i spése.
‘Uste
Sònghe ‘Uste che na mmèlètì,
‘u mèdeche m’è urdenète ‘na ghèlline
m’è urdenète pure ‘na cumpòste
lecénz’è ‘ssegnurì, a faccè vostre.
Settèmbre
Sònghe Settèmbre c’a fiquerè mósce,
tutt’u muschètèlle mò ce fenisce,
’a nnèt mije vè de présce,
pèrzeche, precóche e méle lisce.
‘Ttòbre
Sònghe ‘Ttòbre, nu bóne velegnètóre,
mò m’a vóje fè na velegnète,
voje fè na vótte de vine mmesckète
e ‘na mugghjère pe nu lètte frésche.
Nuvèmbre
Sònghe Nuvèmbre, nu bbóne sumentètóre
e me vóje fè na bbóne sumentète
nu itt pe mé, pe l’evucèlle
e n’avete pe lì fémmene bèlle.
Decèmbre
Sònghe Decèmbre, c’a néve e senzè sóle,
èlli sei Sèn Necóle,
‘u vinticinche nasce ‘u Rédéntóre,
c’èccide ‘u pòrche, sènzè delóre.
Traduzione in lingua italiana
Gennaio
Gennaio sono e gennaio mi chiamo
rendo la vita amara ai potatori,
rendo la vita amara ai pastori
e mi faccio chiamare il mese di gennaio.
Febbraio
Febbrarello corto corto
o meglio o peggio di tutti,
se i miei giorni fossero tutti
farei gelare il vino nelle botti
Marzo
Sono Marzo con le mie zappette
non abusarti della mia pumétte [NdA: cagnolina];
quando faccio il quarto di luna
a pane e vino faccio il digiuno.
Aprile
Sono Aprile con i rami vaganti
ora fioriscono valloni, monti e vallate,
aprile si fa i suoi lavori
e maggio si gode la giovinetta.
Maggio
Sono Maggio più rosso di tutti
alimento porto a tutti,
a ogni angolo si suona e si canta
anche gli asini sono contenti.
Giugno
Sono Giugno con la falcetta
trentatré carati un barilotto,
non approfittarti della donna vecchia
altrimenti ti stappo un orecchio.
Luglio
Sono Luglio con il carro rotto,
rotto il carro e rotta la maggese,
vai compagno mio ora che è asciutto,
altrimenti se viene a piovere ci consumiamo tutte le spese.
Agosto
Sono Agosto con una malattia
il medico mi ha ordinato una gallina,
mi ha ordinato anche una marmellata
con licenza di vossignoria, alla faccia vostra.
Settembre
Sono Settembre con il fico appassito
tutto il moscatello ora finisce,
l’annata mia va di fretta
persiche, pesche e mele lisce.
Ottobre
Sono Ottobre, un buon vendemmiatore
ora me la voglio fare una vendemmiata,
voglio fare una botte di vino rosato
e una moglie per un letto fresco.
Novembre
Sono Novembre, un buon seminatore
e mi voglio fare una buona seminata
un getto per me e per l’uccello
e un altro per le donne belle.
Dicembre
Sono Dicembre, con la neve e senza sole
il giorno sei San Nicola
il venticinque nasce il Redentore
si ammazza il maiale senza dolore.
Che la cantata possa essere nata a Serracapriola, un comune a poche decine di chilometri di distanza da Poggio Imperiale, e poi diffusa nelle campagne limitrofe, è un fatto abbastanza verosimile, considerando anche la circostanza che le maestranze (i cafoni) erano soliti spostarsi a seconda delle stagioni e delle esigenze di manodopera nell’ambito del territorio.
Ma v’è di più. Alla formazione della popolazione del nuovo borgo di Tarranòve contribuirono, tra l’altro, anche famiglie provenienti dai paesi viciniori, tra cui Serracapriola, di origini ben più remote del nostro paesello.
Ma, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, positivo è da considerare il fenomeno di diffusione dei messaggi trasversali che un tempo – anche in mancanza di mezzi di diffusione di massa – riuscivano a penetrare nelle popolazioni, proprio attraverso le cantate popolari. Esse rappresentavano dei potenti megafoni che amplificavano i messaggi cantati dai cafoni nei campi verso i villaggi, le valli e le montagne, tentando, a loro modo, di formare nuove coscienze orientate per lo meno al rispetto minimale dei più elementari diritti umani.
Grazie a Giuseppe Castellato per l’opportunità che ci ha offerto di poter approfondire un ulteriore aspetto del nostro passato.
Dalle opere di Matteo Salvatore:
Lu soprastante
Preambolo:
Gente, io ci sono stato nei campi di grano a mietere sotto lo sguardo vigile del sorvegliante, sotto il sole cocente, curvo dall’alba al tramonto e lì a due passi la fiasca dell’acqua fresca sotto i covoni e non potermi dissetare. No, qui non si può bere, non si può parlare, si deve solo lavorare, lavorare, lavorare, chi non lo farà verrà licenziato, credetemi io ci sono stato.
Quanne mettèmme lu rénö a lä campagnä
tenèmme nna sétë ca nü cë murèmme
dicèmme a lu soprastantë,
“Vulìmme vévë, mann’a pigghjá lu cúcume sotte li mennòcchje”
“Vuje n’avita vévë,
n’avita vévë,
avita fatijá.
Vuje n’avita vévë,
n’avita vévë,
avita fatijá”
Uno de li fatijatórë c’alluntanéve
a jjá ngappä lu cúcume cë në jéve.
L’allucchève lu soprastantë:
“Túrnete addréte
se nun të turne addrétö si licenzjéte”
Qua nun cë pò vévë,
nce pò parlá,
cj adda sòle fatijá
Qua nun cë pò vévë,
nce pò parlá,
cj adda sòle fatijá
Qua nun cë pò vévë,
nce pò parlá,
cj adda sòle fatijá
Qua nun cë pò vévë,
nce pò parlá,
cj adda sòle fatijá
Nu nnà avima vévë,
nnà avima vévë,
avima fatijá.
Nu jòrne addá arrevá
lo pòrce (*) accise l’amma magná.
Nu nnà avima vévë,
nnà avima vévë,
avima fatijá.
Nu jòrne addá arrevá
accise e arròstute (*) l’avima fä.
Traduzione in lingua italiana
IL SORVEGLIANTE
Quando abbiamo mietuto il grano alla campagna
avevamo una sete da morire
dicevamo al sorvegliante
“Vogliamo bere, manda a prendere l’anfora sotto i covoni”
“Voi non dovete bere,
non dovete bere,
dovete lavorare”
Uno dei lavoratori si allontanava
e vicino all’anfora se ne andava.
Lo guardava il sorvegliante
“Torna indietro
se non torni indietro
sei licenziato.
Qui non si può bere,
non si può parlare,
si deve solo lavorare.”
Non dobbiamo bere,
non dobbiamo bere,
dobbiamo lavorare.
Un giorno deve arrivare, il porco (*) ucciso dobbiamo mangiarlo.
Non dobbiamo bere,
non dobbiamo bere,
dobbiamo lavorare.
Un giorno deve arrivare, ucciso e arrostito (*) dobbiamo farlo.
(*) Riferito, con ironia, al sorvegliante (NdA)
Matteo Salvatore, nato ad Apricena (FG) il 16 giugno 1925 e deceduto a Foggia il 27 agosto 2005, è stato compositore e cantante di musica popolare, oltre che un interprete di massimo livello dei canti tradizionali della terra di Capitanata e del Gargano.
Foto: La Masseria Petrulli in agro di Torremaggiore (http://www.sanseveresi.com/tutte-le-notizie/7-ultime/217-le-masserie-di-ferrigno-petrulli-e-monachella-patrimonio-della-civilta-contadina-e-della-memoria)
La Terza Guerra Mondiale, combattuta “a pezzi”!

Sale la preoccupazione in tutto il mondo occidentale dopo la terza decapitazione, in meno di un mese, di ostaggi da parte dei miliziani islamici dell’Isis(1), avvenuta nei giorni scorsi. E, non di meno, da noi, cresce l’apprensione per la sorte dei tre italiani rapiti dai jihadisti e tenuti ancora prigionieri. Si tratta di Padre Paolo Dall’Oglio, scomparso oltre un anno fa a Ragga e delle due giovani cooperanti Vanessa Marzullo e Greta Ravalli, rapite lo scorso 31 luglio alla periferia di Aleppo.
In casi del genere, l’Italia ha dimostrato sempre la sua propensione a non abbandonare nessuno dei propri connazionali, facendo tutto il possibile per la loro liberazione.
Circolano voci tendenziose (è risaputo che i mass media a volte non risparmiano proprio nessuno) di pagamenti di riscatti, nell’ordine di milioni di dollari, pagati dal Governo Italiano ai terroristi, attraverso lunghe e complesse operazioni e trattative segrete. E, pare che anche la Francia faccia altrettanto. E forse non solo la Francia.
Ma, se così fosse, non c’è il rischio che il business dei riscatti, avendo la finalità di finanziare proprio il terrorismo islamico, finisca con l’innescare una spirale di violenza di massa senza fine?
Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dal canto loro, hanno sempre scelto la linea dura nei confronti dei terroristi, con tentativi di blitz spesso non andati a buon fine e un bilancio di cittadini americani e britannici uccisi, che cresce di mese in mese. L’ultima vittima dell’orrore jihadista era, infatti, un cittadino britannico, al quale è stata riservata la medesima sorte delle due precedenti vittime di nazionalità statunitense; nel video dell’esecuzione sono state espresse minacce anche per il secondo britannico rapito e ancora nelle loro mani.
E, dunque, cosa conviene fare: usare il pugno di ferro o trattare?
“La violenza porta violenza”, dice il nostro Papa Francesco, affermando pure che la Terza Guerra Mondiale è già in corso, sebbene “combattuta a pezzi, con crimini, massacri e distruzioni” e, che, “la guerra è una follia, il suo piano di sviluppo è la distruzione: volersi sviluppare mediante la distruzione”. Ma dice anche che è forse meglio attivare processi di apertura al dialogo tra i popoli di estrazione, cultura e religione diverse, evitando per quanto possibile di inasprire gli animi.
Tuttavia, le maggiori potenze occidentali hanno deciso di partire subito con le maniere forti e, tra esse, anche l’Italia parteciperà ai bombardamenti fornendo armi e munizioni (per ora, niente aerei, è stato detto).
Ma, non è il caso di fare qualche riflessione, partendo dal presupposto che taluni fenomeni non si verificano mai solo per puro caso? E’ risaputo che sono sempre le circostanze a creare le opportunità e talvolta anche alcuni errori di leggerezza e sottovalutazione. E, quando meno te l’aspetti, ecco che la pietanza ti viene servita bella e pronta!
Ora siamo veramente in un mare in tempesta, se consideriamo anche l’ulteriore fronte di crisi aperto in Ucraina con la Russia, e la nave fa acqua da tutte le parti.
Forse vanno ripensati i princìpi che hanno ispirato i governanti (soprattutto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna), alla fine della seconda guerra mondiale, a costituire la NATO; un organismo forse non più in grado di assicurare il necessario equilibrio tra gli Stati, perché nata in piena “Guerra Fredda” soprattutto per arginare il pericolo di avanzata militare della Russia (guarda caso, la Russia ancora oggi non è membro della Nato).
Ma ne è passata di acqua sotto i ponti ed è trascorso un bel po’di tempo dalla caduta del Muro di Berlino: ora, se un pericolo c’è (e non possiamo più far finta di ignorarlo), viene esclusivamente dall’area islamica.
Invece noi vogliamo fare la guerra alla Russia … orsù, cerchiamo di ragionare, per favore!
Con la Russia dobbiamo fare discorsi di collaborazione e non perderci in chiacchiere sterili e futili, essendo indispensabile ed ineludibile la sua entrata, a pieno titolo, nella NATO. Gli effetti che ne discenderebbero sarebbero senz’altro positivi, non foss’altro che per il delinearsi di nuovi processi di stabilità in ambito mondiale.
Lo spunto offerto da Francesco Alberoni, che ha trattato l’argomento in un suo articolo pubblicato su “il Giornale” di lunedi 15 settembre 2014(2), e che riporto qui di seguito, è molto interessante. Ma si tratta di una voce solitaria che si perde nell’universo dei discorsi dei soloni in campo planetario e delle strategie degli Stati, i cui interessi reconditi non è dato conoscere, ma solo immaginare.
Sarà un caso che il Santo Padre, in visita al Sacrario di Redipuglia, qualche giorno fa, ha affermato che dietro le quinte di tutti i conflitti “ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, e c’è l’industria delle armi, che sembra essere tanto importante! E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: ‘A me che importa’? È proprio dei saggi riconoscere gli errori, provarne dolore, pentirsi, chiedere perdono e piangere”.
(1)L’Isis è l’acronimo di “Stato Islamico dell’Iraq e della Siria”. Un gruppo jihadista attivo in Siria e in Iraq il cui leader, Abu Bakr al-Baghdadi, ha unilateralmente proclamato la rinascita del califfato nei territori caduti sotto il suo controllo. La posizione dell’ ONU in merito alla legittimità di questo autoproclamato Stato Islamico è stata quella di dichiarare il più alto livello di emergenza sotto il profilo umanitario ed invitare il governo iracheno a formare un governo il prima possibile entro i limiti della Costituzione irachena, senza riconoscere alcuna legittimità all’Isis (che si trova anche sul territorio dello stato iracheno, membro riconosciuto dell’ONU e facendo riferimento ad esso come “gruppo terroristico”.
(2) “La Nato è morta e la Russia non è più un nemico” di Francesco Alberoni, “il Giornale” di lunedi 15 settembre 2014. “La Nato è nata nel 1948 e fra i suoi Paesi mèmbri oggi abbiamo Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Norvegia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania; a sud e a est Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Turchia. In sostanza un semicerchio che stringe la Russia a occidente, a nord e a sud. Anche solo guardandone la forma geografica si capisce che è stata creata in funzione anti Urss all’epoca della Guerra fredda, però continua a esistere anche ora che l’Urss non esiste più e i principali pericoli militari non ci vengono dalla Russia ma dall’area islamica, mentre la più pericolosa competizione economica è quella della Cina. La Nato è tenuta in vita dagli Usa e dal Regno Unito che ci fanno litigare con la Russia per impedirci di stabilire con essa una profonda integrazione economica, e invece spingerci ad acquistare petrolio e gas dai Paesi del Golfo controllati da loro. Tutti i Paesi europei sono danneggiati da questa politica e la Russia viene spinta a integrarsi con la Cina. E’ venuto il momento di domandarci perché dobbiamo continuare a fare parte di una organizzazione che ci reca solo danno. La Russia per noi non è un nemico, ma un amico, appartiene alla cultura europea, è un partner economico ideale, combatte l’integralismo islamico che invece gli americani hanno favorito con la loro politica in Afghanistan, in Irak e in Siria. È stata la Nato ad abbattere Gheddafi dando la Libia in mano agli islamisti e inondando l’Italia di immigrati. E non dimentichiamo che il presidente Obama voleva bombardare l’esercito di Assad aiutando le forze che hanno poi creato il califfato. Oggi la Nato dovrebbe essere riorganizzata con nuovi scopi e con nuovi mèmbri. E per prima cosa dovrebbe farne parte la Russia, per costituire un fronte comune contro l’integralismo islamico e la immensa potenza militare che fra poco sprigionerà la Cina. Oggi la Nato, che guarda a nemici del passato, dovrebbe pensare al futuro. Magari facendo anche qualcosa per il presente per esempio mettere fine alle emigrazioni nel Mediterraneo da essa stessa provocate”.
Clamorosa svolta in Ferrari!

A quanto pare, l’avventura di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari è proprio giunta al capolinea.
Nei giorni scorsi circolavano voci tendenziose, prontamente smentite dagli addetti ai lavori, fino all’epilogo del dramma che si è consumato la scorsa domenica (7 settembre u.s.), quando la scuderia di Maranello ha concluso la competizione di Formula 1 presso il circuito di Monza con un ennesimo flop.
Forse è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso o – molto più verosimilmente – i piani di FCA (il nuovo Gruppo automobilistico internazionale Fiat – Chrysler) erano già stati definiti, e si attendeva proprio l’esito della gara di Monza (in Italia) per mettere Montezemolo alle strette.
Sta di fatto che, la conferenza stampa congiunta nella sala del museo Ferrari a Maranello, in diretta televisiva di ieri, non lascia dubbi in proposito: Luca Cordero di Montezemolo abbandona la presidenza della Ferrari a metà del mese di ottobre prossimo ed al suo posto subentra direttamente Sergio Marchionne, l’attuale Amministratore Delegato del Gruppo FCA.
Marchionne sostiene che la priorità è tornare a vincere in F1 nel minor tempo possibile, facendo tornare la Ferrari ai vertici e che per il posto da presidente del Cavallino Rampante si considera il degno erede di Montezemolo, avendo negli ultimi dieci anni condiviso con lui tutto lo sviluppo dell’azienda Ferrari.
Montezemolo si è detto onorato di essere stato in Ferrari per 23 anni ed orgoglioso, nel contempo, di aver contribuito al notevole successo mondiale della Scuderia, prendendo atto che si è giunti ora “alla fine di un’epoca”. Ma si è anche augurato che, dopo di lui, cominci una nuova era, un periodo di ulteriore sviluppo e di più significativi successi.
John Elkann, presidente di FCA, ha fatto diramare il seguente comunicato: “Desidero ringraziare Luca a nome della mia famiglia e a titolo personale per quanto ha fatto per la Fiat e la Ferrari. A Luca vanno i miei auguri per il suo futuro professionale e imprenditoriale, con la speranza, certamente condivisa, di vedere presto la Ferrari tornare a vincere”.
Va detto che Montezemolo ha portato la Ferrari a un livello tecnologico e organizzativo di eccellenza e ha ottenuto importanti risultati sotto ogni aspetto, ma d’ora in poi la Ferrari avrà un ruolo importante all’interno del Gruppo FCA e nella quotazione a Wall Street. Si aprirà quindi una fase nuova e diversa, senza tuttavia ipotizzare minimamente un trasferimento della casa automobilistica da Maranello. “L’indipendenza della Ferrari non verrà mai messa in discussione, il successo è legato alla sua esclusività”, ha assicurato Sergio Marchionne.
Qualche stoccata non è comunque mancata nel corso della conferenza stampa. Quando l’ormai ex presidente (dal 13 ottobre, lo stesso giorno in cui è prevista la quotazione di FCA a Wall Street) ricorda la chiamata nel 2000 dell’Avvocato Agnelli e il suo pianto al telefono, commosso per la vittoria del mondiale di Schumacher, non riesce a trattenere il suo sfogo: “perché erano vent’anni che non vincevamo, non i sei di adesso…”. Questo per rispondere a qualche insinuazione che Marchione aveva fatto nei giorni scorsi a proposito della Ferrari che “ non sta vincendo da parecchi anni”.
Ma, alla fine, Marchionne, ribadisce: “Voglio ringraziare personalmente Luca per quanto ha fatto per la Fiat, per la Ferrari e per me”.
Dulcis in fundo. Si dice che Montezemolo percepirà un’indennità di fine rapporto di circa 27 milioni di euro, di cui 13,25 milioni per l’impegno a non svolgere attività in concorrenza con il gruppo fino al marzo 2017.
Foto di repertorio (Corriere della sera 11 settembre 2014)
E … sette!

Giacomo Fina è giunto al suo settimo libro; anche quest’anno non ha deluso le attese e, puntualmente, in agosto, ha presentato il suo ultimo lavoro: una nuova raccolta di poesie accompagnata da alcuni brani di prosa.
“Il respiro della memoria e altre storie”, questo il titolo dell’ultima fatica dell’Autore, pubblicato dalle “Edizioni del Poggio”, la Casa Editrice del Dott. Giuseppe Tozzi di Poggio Imperiale, che si va sempre più affermando, soprattutto per il suo “Premio Letterario” giunto quest’anno alla sua VI Edizione.
La presentazione si è svolta a Poggio Imperiale il giorno 13 agosto 2014, alle ore 19,30, presso i locali della Scuola Elementare, in via Oberdan.
Le letture poetiche di Fabio Gemo, attore e regista teatrale, hanno nell’occasione appassionato gli intervenuti, mettendo in risalto gli aspetti più toccanti dei versi del Fina.
“Il tema dominante del pensiero del poeta” – come sostiene nella Prefazione la Prof.ssa Maria Rosaria Matrella, docente della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Foggia – “è rappresentato dalla memoria che respira nel ricordo di gioie passate, di illusioni svanite, di lacrime versate nel silenzio dell’anima”.
La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Poggio Imperiale, Assessorato alla Cultura.
Presenti il Sindaco, il Consigliere delegato alla Cultura ed il Parroco, che hanno portato i loro saluti.
Relatore: la Prof.ssa Maria Rosaria Matrella.
I dipinti in copertina e nel testo sono di Giacomo Fina.
Dello stesso Autore:
– Dialogo postumo del 2007;
– Viaggio d’autunno del 2009;
– Il Viandante del 2010;
– Come le onde del 2011;
– Io e il Principe del 2012;
– Il vecchio e il Principe, una vita del 2012.
A quanto pare, dunque, Giacomo Fina, per gli amici Mimì, alla luce delle opere sin qui realizzate, non può essere considerato una semplice meteora occasionalmente transitata nell’infinito universo della poesia e della prosa, non foss’altro che per la costanza e l’impegno dimostrati in questi anni.
E tutto fa presagire che Mimì non si fermerà qui, ma che continuerà a dipingere e a scrivere poesie, offrendoci ulteriori opportunità per condividere con lui nuove emozioni.
Il sito archeologico di Saepinum – Altilia in Molise

Tra i tanti ricordi della mia infanzia, mi riaffiorano alla mente alcuni periodi estivi trascorsi con la mia famiglia a Sepino, in provincia di Campobasso, nel Molise.
Ci si andava per “cambiare aria” – come si diceva allora – ma soprattutto perché a Sepino sgorgava dalle sue rocce un’acqua straordinaria che pareva curasse e prevenisse l’insorgenza di ogni specie di malanno. Sicuramente la località, posta a 702 metri di altitudine, su di un colle boschivo alle propaggini del Massiccio del Matese, non poteva che offrire – nel corso dell’estate – refrigerio e benessere.
Ed erano parecchie le famiglie di Poggio Imperiale, il mio paese di nascita ubicato in terra di Capitanata, in provincia di Foggia e confinante con quella di Campobasso, che sceglievano all’epoca proprio Sepino come località di relax, prima o subito dopo il periodo di balneazione al mare a Torre Fortore (ove oggi è insediato il centro turistico di Lesina Marina).
Ricordo le belle passeggiate e soprattutto le mattinate e i pomeriggi trascorsi alle “Tre Fontane”, le Terme che si trovavano un po’ fuori dal centro abitato, dove gli adulti “facevano la cura delle acque” e noi bambini giocavamo e ne combinavamo di tutti i colori, fino all’ora di pranzo e di cena.
E poi, la sera, tutti in piazza: bancarelle, luminarie, concerti bandistici, cantanti di musica classica e musica leggera; ogni sera, qualcosa di nuovo e di interessante.
Nel corso della vacanza, una visita culturale agli scavi archeologici di “ Saepinum – Altilia” era obbligatoria, anche se noi piccoli non facevamo altro che correre e rincorrerci tra le colonne e i resti di capitelli sparsi qua e là tra le antiche strade romane.
Nei giorni scorsi, nel corso di un giro in Molise, io e mia moglie in compagnia delle mie due sorelle e i rispettivi mariti, abbiamo voluto ripercorrere anche quei luoghi, per ricercare spunti dei nostri ricordi di oltre mezzo secolo fa.
E come spesso succede, qualche delusione te la devi pure aspettare.
Le Terme non ci sono più: chiuse già da tempo! E, quindi, niente “Tre Fontane”, ma anche il paese, nel suo insieme, ci è apparso alquanto dimesso.
Abbiamo però recuperato con la visita dell’area archeologica, che rimane pur sempre una tappa interessante, anche se si percepisce l’insussistenza di un adeguato livello di attenzione da parte degli “addetti ai lavori”, rispetto all’inestimabile valore del sito: accessi aperti a chiunque e carenza di sorveglianza in tutto il perimetro. Solo i due Bar/Ristoranti presenti in loco davano segni di vita.
Ma, al di là di questo, è comunque sempre interessante fare una capatina a Sepino, sperando che la località venga maggiormente valorizzata a livello universale, perché si tratta di un museo a cielo aperto che ci parla del nostro passato.
Sepino (da saepio, in latino recingere, forse perché circondata da monti o forse perché l’antica Saepinum era cinta da mura) è un comune di poco più di 2.000 abitanti della provincia di Campobasso e fa parte del circuito dei ”Borghi più belli d’Italia”.
Nel centro cittadino sorge la chiesa di Santa Cristina, probabilmente costruita quando la popolazione, alla fine dell’Alto Medioevo, abbandonò Saepinum per fondare l’odierna Sepino. All’interno della chiesa si trovano la “grotta di Santa Cristina” con i Misteri, la Sala del Tesoro, un coro ligneo ottocentesco e l’archivio storico parrocchiale, che conserva anche pergamene del XII secolo.
Meritano attenzione anche il campanile romanico della Chiesa di San Lorenzo, le chiese di Santa Maria Assunta e del Purgatorio, nonché l’ex Chiesa di Santo Stefano, oggi adibita a teatro e a sala conferenze. A poca distanza dal centro, in località Petrilli, si trova il convento della SS. Trinità. Ne decorano l’interno alcuni dipinti, statue e fontane. Dal piazzale del convento è possibile giungere alle rovine del convento Santa Maria degli Angeli, oggi abbandonato.
Il centro abitato di Sepino conserva le tipiche caratteristiche medievali; un’ampia piazza alla quale confluisconto un certo numero di stretti vicoli.
Vi si trovano numerose fontane, come quella ubicata nella piazza principale, i cui rubinetti indicano i punti cardinali, o quelle della Canala e del Mascherone. Degno di nota è infine il Ponte San Rocco, da cui prende nome l’omonima località.
L’abitato medievale era circondato da una cintura muraria a forma quasi ellittica, con quattro porte, munita di torri sulle quali spiccava il castello. Tuttora sono conservate alcune torri e tre porte: la porta Meridionale, la porta Orientale, la porta di Corte o porta Borrelli. Il castello fortemente danneggiato dal terremoto del 1805 fu progressivamente abbattuto.
Vicino al centro abitato si trova il complesso delle Terme “Tre Fontane”, le cui acque hanno caratteristiche oligominerali adatte alla cura della calcolosi renale. Attualmente le Terme sono chiuse
A poca distanza dall’abitato si trovano gli scavi archeologici di Saepinum.
Saepinum sorge nella zona archeologica di Altilia, attraversata dall’antico Tratturo Pescasseroli-Candela ed è possibile ammirare i resti dell’abitato romano, come il Foro, la Basilica, Porta Bojano, le Terme, il Teatro, il Cardo e il Decumano e le Mura.
La zona archeologica è meta di turisti italiani e stranieri ed è altresì inserita nel calendario di manifestazioni estive, che propongono spettacoli di teatro e danza di livello internazionale.
I resti della città romana di Saepinum sono venuti alla luce con gli scavi iniziati a partire dal 1950. Fra le rovine romane si trovano numerose case coloniche costruite con pietre di spoglio sin dal XVIII secolo ed oggi adibite a sede di un lapidario e degli uffici dei custodi.
La pianta di Saepinum è quella tipica delle città romane anche se gli scavi si sono concentrati sul Decumano maggiore e sul Cardo massimo. Le porte sono di conseguenza quattro (tre delle quali con l’arco ancora conservato): Porta Benevento; Porta Terravecchia; Porta Bojano; Porta Tammaro.
Il Foro, a pianta rettangolare, è ancora oggi pavimentato con lastroni in pietra lavorata. Su di esso si aprivano gli edifici pubblici: la Curia, il Capitolium e la Basilica. Quest’ultima possiede ancora le venti colonne circolari di ordine ionico ed a fusto liscio che circondavano un peristilio. Alle spalle della Basilica era il Macellum (mercato). In fondo a destra, prima della Porta Bojano, vi sono i resti di una delle tre Terme.
Ben conservato è il Teatro, scavato solo in parte negli anni settanta del secolo scorso e costituito dalla scena e dalla platea, entrambe in pietra locale lavorata. Capace di contenere 3.000 posti circa, è cinto da alcune ex case coloniche che seguono anche l’andamento semicircolare della platea. Intorno c’è un corridoio alle cui pareti sono presenti numerose lapidi, resti di colonne e di capitelli e che aveva lo scopo di far defluire gli spettatori verso l’esterno della città al termine degli intrattenimenti. Della palestra esistente fra il Foro e la strada oggi restano solo pochi ruderi.
Nella parte meridionale del Foro (quella che guarda verso Porta Benevento), sotto una copertura in ferro, si possono notare cospicui resti di una pavimentazione marmorea, mentre a destra vi è un pozzo coperto costruito con materiale di spoglio. Proseguendo verso Porta Benevento si notano a sinistra i resti di una casa con impluvio sannita in pietra lavorata e subito dopo i resti di un edificio industriale con diverse vasche sotterranee ad imbuto ed una ruota di un mulino fedelmente ricostruita. Segue la fontana del Grifo, costruita dagli edili Ennio Gallo ed Ennio Marso a cavallo fra il I ed il II secolo d.C. e chiamata così perché l’acqua fuoriesce da un altorilievo raffigurante un Grifo.
Poco distanti dalla città, rispettivamente vicino alle porte Bojano e Benevento, sono posti due mausolei, il primo intitolato ai Numisi ed il secondo a Caio Ennio Marso.
Il sito archeologico di Saepinum – Altilia è stato insignito nel 2010 dello “Scudo blu internazionale” (ICBS International Commitee of the Blue Shield), fondato nel 1996 a protezione dei Beni Culturali, per la difesa dei quali vengono promosse azioni di protezione, prevenzione e sicurezza in tutte le situazioni rischiose, come i conflitti armati e le calamità naturali; esso prende il nome dal simbolo specificato nella Convenzione de L’Aja del 1954.
Antecedentemente alla nascita della città romana di Saepinum, in località Terravecchia (a monte, poco distante) era insediato un villaggio sannita denominato Saipins, dall’osco saepo “recinto” per la vendita di mercanzie e animali.
La costruzione di Saipins/Terravecchia da parte dei Sanniti fu dettata dalla posizione strategica e dal controllo delle vie d’accesso mercantili tra due forre o burroni che mettevano in comunicazione l’Apulia a sud ed il Sannio Pentro a nord e la costa adriatica molisana ad est e la costa tirrenica campana ad ovest.
Il villaggio era situato tra i fiumiciattoli Magnaluno a nord e Saraceno a sud, a 950 metri sul livello del mare.
Alla fine II secolo a. C. sono datate un gruppo omogeneo di abitazioni private e alla stessa epoca risale lo smercio di terrecotte con incisioni osche.
Dopo la guerra sociale la città divenne un centro amministrativo romano.
Fra il II secolo a. C. ed il IV secolo d. C. avvenne la costruzione di mura difensive, nel primo impianto in opera reticolata, con torri poste ad intervalli regolari sopra le porte. Queste avevano i nomi dei luoghi dove terminavano le strade diramantesi dal centro storico.
A Castelvecchio (nei pressi di Terravecchia) vi sono resti delle mura megalitiche lunghe 500 metri con 3 porte dette “Postierla del Matese”, “dell’Acropoli” e “del Tratturo”, quest’ultimo collegava la pianura con gli scavi di Saipins.
I “Sabbuleche” del Corpus Domini di Poggio Imperiale

La Processione del Corpus Domini di domenica 22 giugno scorso a Poggio Imperiale ha rappresentato, per me e per mia moglie che viviamo nel Nord Italia da molto tempo, l’occasione per rivivere, a distanza di cinquant’anni, un momento mistico e tradizionale al tempo stesso.
E, così come allora, durante la processione serale lungo le vie del paese, si è ripresentata ai nostri occhi l’antica tradizione degli “altarini”, che ai nostri tempi venivano chiamati i “sabbul(e)ch(e)”, termine dialettale che deriva probabilmente dall’alterazione di “sepolcro”, voce popolare che indica il luogo della deposizione di Gesù dopo la sua morte.
Si tratta di “altarini” speciali approntati con i capi più belli e più preziosi, ricamati a mano, dei corredi delle nostre mamme e delle nostre nonne: “cuperte”, “apparate”, “panneggjie”, utilizzati eccezionalmente, solo nelle occasioni più importanti della loro vita.
I “sabbul(e)ch(e) vengono allestiti in case private ubicate al piano terra lungo il percorso della processione del Corpus Domini, mentre dai sovrastanti balconi addobbati con drappi e coperte, vengono sparsi petali profumati di fiori variopinti.
Questo è uno scorcio di Poggio Imperiale, il nostro paese natìo, che raccolto in preghiera celebra la festività del Corpus Domini (espressione latina che indica il Corpo del Signore), chiamata più propriamente solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, e che costituisce una delle principali ricorrenze dell’anno liturgico della Chiesa cattolica
Una tradizione, quella dei “sabbul(e)ch(e), che si perde nella notte dei tempi, ma che si rinnova ogni anno con tocchi di sobria novità, senza stravolgere tuttavia l’usanza e la consuetudine.
Sono diverse le località italiane ove, nel corso di ricorrenze ed eventi popolari, si incontrano e si fondono la religiosità con il folklore, miti e storia, antiche tradizioni e moderne passioni. Una di queste tradizioni popolari che si intreccia con una ricorrenza religiosa è rappresentata proprio dall’allestimento a Poggio Imperiale degli “altarini” il giorno del Corpus Domini, dove fa una breve sosta e viene esposto il Santissimo Sacramento, racchiuso nell’ostensorio e portato in processione dal sacerdote, con i paramenti sacri di rito, sotto un baldacchino sorretto da uno dei fedeli lungo tutto il percorso, accompagnato dal Sindaco con fascia tricolore, dalle autorità civili e militari e seguito da tutta la popolazione credente, in fervente orazione.
Nel corso della processione viene adorato Gesù vivo e vero presente nell’Ostia consacrata ed esposta alla pubblica devozione.
Il culto dell’adorazione del Santissimo Sacramento (Ostia consacrata) nacque in Belgio nel 1246 o 1247, quale festività della Diocesi di Liegi, ed il suo scopo era quello di celebrare la reale presenza di Cristo nell’Eucaristia, soprattutto come reazione alle tesi di Berengario di Tours, secondo il quale la presenza di Cristo non era reale, ma solo simbolica. Fu poi papa Urbano I che, con bolla Transiturus de hoc mundo dell’11 agosto 1264, da Orvieto dove aveva stabilito la residenza della corte pontificia (non andrà mai a Roma), estese la solennità a tutta la Chiesa universale.
Tutti a casa … abbiamo scherzato!

Poco fa è terminato per l’Italia il Mondiale di calcio 2014 del Brasile.
La sconfitta sul campo inflitta questa sera alla nostra nazionale di calcio, per una rete a zero, dall’Uruguay, ha fatto il paio con la precedente sconfitta dello scorso venerdi con la Costarica, sempre per una rete a zero, vanificando così la bella vittoria italiana sull’Inghilterra nella partita di esordio.
Niente ottavi di finale e niente di niente.
E, dunque, nessun commento, abbiamo perso e ce ne torniamo a casa con le pive nel sacco, cercando almeno di prendere spunto da questa debacle per una profonda meditazione al riguardo.
Comincia bene l’Italia ai Mondiali di calcio 2014 del Brasile

Ai Mondiali di calcio del Brasile l’Italia inizia nel modo migliore, battendo l’Inghilterra per 2 reti ad 1 nello stadio di Manaus.
La nazionale italiana è al suo diciottesimo Mondiale di calcio ed è stata sorteggiata in un girone non particolarmente morbido (Gruppo D); dopo la partita della notte scorsa contro l’Inghilterra, dovrà infatti incontrare l’Uruguay e il Costarica.
Ma tutto lascia ben sperare, visto che nella partita di esordio, gli azzurri, guidati da Cesare Prandelli, hanno dato prova di essere in ottima forma.
La nostra nazionale di calcio è riuscita, con una solida prestazione, a battere gli inglesi che all’inizio erano partiti molto meglio di noi.
La prima rete italiana è stata segnata al 35’ da Marchisio e la seconda al 5’ della ripresa da Balotelli; la rete avversaria è stata messa a segno invece dall’inglese Sturridge.
Questo il calendario delle prossime partite che interessano l’Italia:
– Seconda gara: giorno 20 giugno 2014, incontro Italia-Costarica con orario d’inizio alle 18 (ora italiana).
– Terza gara: giorno 24 giugno 2014, incontro Italia-Uruguay, sempre alle 18.00 (ora italiana).
E, poi, chissà, se la scia delle vittorie continuerà, potremo proseguire con gli ottavi di finale, i quarti di finale, semifinali, finale per il 3° e 4° posto e , addirittura, con la finale per il 1° e 2° posto.
Mai dire mai!
La Cerimonia inaugurale della XX edizione dei Mondiali di calcio si è tenuta allo stadio “Itaquerao” di San Paolo, giovedi scorso 12 giugno; uno spettacolo animato da 660 figuranti, una finestra per raccontare agli spettatori sugli spalti e a quelli della televisione la cultura e la storia del Brasile. Primo simbolo ad essere raffigurato è stata la natura che caratterizza il Brasile: mare, fiumi e la Foresta Amazzonica. Si è passati poi a una sezione dedicata ai popoli che compongono il Paese, e successivamente alla danza, con ballerini che hanno mostrato alcuni balli popolari. Al centro della scena un globo luminoso formato da led che ha preso i colori del “brazucà”, il pallone ufficiale dei Mondiali, per poi replicare le bandiere dei 32 paesi partecipanti. L’attenzione si è quindi focalizzata su un giovane paraplegico che, grazie a una struttura di supporto, ha tirato un calcio al pallone, dando di fatto avvio al Mondiale. Magicamente il globo luminoso si è aperto diventando un palco su cui si sono esibiti nell’inno ufficiale della manifestazione, “We are onè”, il rapper Pitbull, vestito con la maglia gialla del Brasile, e le cantanti Jennifer Lopez vestita di verde e Claudia Leitte di azzurro, i colori della bandiera brasiliana, assieme agli Olodum.
Il Mondiale di calcio, alla stessa stregua delle Olimpiadi, rappresenta un momento di incontro e di fratellanza tra i popoli di tutto il mondo, impegnati in una competizione sportiva serena e leale. L’esatto opposto di quello che, purtroppo, continua a verificarsi ancora in diverse parti del mondo, ove persistono focolai di guerra, soprusi e tirannie.
Foto di repertorio da siti internet