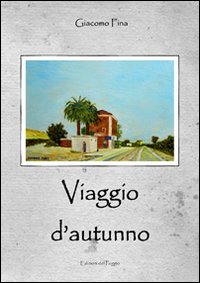Category Archives: Blog
La 7^ Edizione della “MicroEditoria” di Chiari 2009 dedicata alla memoria della poetessa scomparsa Alda Merini.
Anche quest’anno, nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2009, nella splendida cornice di Villa Mazzotti di Chiari (Brescia), si è tenuta la consueta “Rassegna della MicroEditoria”, giunta alla sua settima edizione.
Più di 100 gli Editori intervenuti, tra i quali le EDIZIONI DEL POGGIO www.edizionidelpoggio.it del Dott. Giuseppe Tozzi di Poggio Imperiale (Foggia), già presente lo scorso anno; 50 gli Eventi programmati oltre ai Laboratori scientifici e letture per bambini.
Stand Edizioni Del Poggio
L’edizione 2009 è stata dedicata alla memoria di Alda Merini, madrina della manifestazione.
Alda Merini, prima ospite importante della Microeditoria durante la prima edizione, è stata colei che ha consentito di far conoscere e far decollare la manifestazione, così come è stata colei che, partecipando alla conferenza stampa dell’anno successivo, ha fatto sì che, dopo il lancio, anche il proseguimento dell’evento si consolidasse, sotto le sue ali, che sapevano volare davvero alto.
In questa edizione è stata ricordata come un “inno alla vita”, con l’affetto e la riconoscenza dovuti per la grande poetessa e soprattutto per la grande donna, da sempre capace di cantare la bellezza e l’afflizione, di camminare su linee sospese tra quelle che la gente chiama ragione e follia, di parlare a piccoli e grandi, indifferentemente.
Tra gli ospiti invitati quest’anno all’evento:
– Margherita HACK astrofisica;
– Vittorio MESSORI autore di “Ipotesi di Gesù”;
– Sergio RIZZO autore de “La Casta”;
– Enzo DE CARO attore;
– Vittorio PRODI eurodeputato, Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Ambientale.
Numeroso il pubblico ed i visitatori affluiti.
Tema dell’anno: “Il desiderio di uscita dalla crisi e la voglia di alzare lo sguardo al cielo, celebrando anche l’Anno internazionale dell’astronomia”.
Ecco allora l’editoria attenta, che si muove con supporti modernissimi, offrendo soluzioni innovative come gli audiobook, da ascoltare, oltre che da leggere e toccare, come l’opera Siddartha di Herman Hesse, letta dall’attore Enzo De Caro.
In omaggio alla madrina Alda Merini, a cui l’associazione «L’impronta» ha dedicato la settima edizione, Enzo De Caro (sala Zodiaco) e Antonella Barina (sala Morcelli) hanno letto poesie della poetessa recentemente scomparsa.
Organizzazione:
L’associazione culturale “L’Impronta” e il Comune di Chiari, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, della Provincia di Brescia e dell’Universita’ Cattolica di Milano, in collaborazione con il Parlamento Europeo, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, la Fondazione Cogeme Onlus e il Centro Giovanile 2000, hanno voluto promuovere questa rassegna per valorizzare la produzione della piccola editoria italiana e perche’ il pubblico avesse l’opportunita’ di conoscere questa realta’ attraverso i volti dei suoi protagonisti.
La “Villa Mazzotti” di Chiari (Brescia)
La Villa Mazzotti Biancinelli sorge in un parco di circa 10 ettari. Fu commissionata dal conte Ludovico Mazzotti Biancinelli all’architetto Antonio Vandone di Torino, che la realizzo’ fra il 1911 ed il 1919 con la collaborazione dell’architetto Citterio.
L’aurora
Nella scorsa primavera, in aereo, nel corso del viaggio di ritorno dagli Stati Uniti d’America, complice l’insonnia che solitamente accompagna me e mia moglie in tutti i trasferimenti, di qualsiasi tipo, abbiamo avuto modo di goderci l’aurora di un nuovo giorno che pian piano cominciava a delinearsi.
Uno spettacolo unico nel suo genere.
La luce dell’aurora assume inizialmente tonalità di colore lilla-lavanda per poi passare ad un più surreale pesca-arancio.
In quota, dal finestrino dell’aereo, dal buio più profondo della notte abbiamo iniziato a scorgere le prime lievi note di luce; un momento affascinante in cui le ombre della notte lentamente si diradano e comincia ad avanzare un chiarore che illumina lentamente e sempre di più il cielo.
L’aurora è stata nei secoli molto amata dai poeti e dai pensatori, e continua ad esserlo tuttora, perché rappresenta un momento magico e misterioso al tempo stesso.
Omero magnifica la dea Aurora, sia nell’Odissea che nell’Iliade, attribuendole “dita di rosa”, circa venti volte nei suoi versi: “ Quando, figlia di luce, brillò l’Aurora dita rosate …”.
A questa dea era attribuito il dono di aprire le porte del Cielo al carro del Sole semplicemente con il tocco delle dita color di rosa.
Quella che i romani chiamavano Aurora era la dea Eos della mitologia greca.
Appartiene alla prima generazione divina, quella dei Titani.
E’, infatti, figlia di Iperione e di Teia e sorella di Elio e di Selene; secondo altre tradizioni, era figlia di Pallante.
Con Astreo, un dio della stessa stirpe, generò i Venti: Zefiro, Borea e Noto, e così la “Fiaccola dell’Aurora” e gli Astri.
La sua leggenda è totalmente costellata dei suoi amori: un tempo, si racconta, si era unita ad Ares, attirandosi così la collera di Afrodite, che l’aveva punita facendone un’eterna innamorata.
Amò e portò con sé numerosi giovani noti per la loro straordinaria bellezza, come Orione, Cefalo e Titone, che divenne suo sposo.
Ovidio la chiama infatti “sposa di Titone”, mentre Dante nomina Aurora nel canto II e nel canto IX del Purgatorio , dove è citata come “la concubina di Titone antico”.
Anche nella musica l’Aurora ha sempre ispirato compositori classici e moderni.
Dell’Aurora ritroviamo “le rosee sue dita” nella “Mattinata” di Ruggero Leoncavallo, scritta per Enrico Caruso nel 1903 e successivamente cantata anche da Luciano Pavarotti e da Al Bano (nella sua versione rivisitata).
L’aurora di bianco vestita
Già l’uscio dischiude al gran sol;
Di già con le rosee sue dita
Carezza de’ fiori lo stuol!
C’è anche una splendida opera lirica sulla riconquista del Santo Sepolcro, di Andrea Arnaboldi tratta dalla “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso, intitolata: “ L’Aurora di Gerusalemme “.
Ed ancora, Eros Ramazzotti così canta nella sua canzone dal titolo “L’Aurora”:
. … sarà sarà l’aurora
per me sarà cosi
sarà sarà di più
ancora tutto il chiaro che farà…
Il “grano dei morti”.
Le tonde zucche arancioni e i primi freddi autunnali annunciano la prossima festa di “Halloween” che da qualche tempo sta prendendo piede anche nel nostro paese.
Una zucca di Hallowen
Negli Stati Uniti d’America è in uso mettere in giardino, la sera del 31 ottobre, sulla finestra o davanti alla porta di ingresso, grandi zucche arancioni svuotate della polpa in cui sono intagliati occhi accigliati, nasi satanici e bocche senza denti nel cui interno vengono infilate grosse candele accese.
La luce delle candele, penetrando dalle cavita’, crea effetti singolari e sinistri e questa sorta di “teschi” che originariamente avrebbero dovuto allontanare le occulte presenze, oggi acquistano un valore di “festoso” invito.
“Halloween” diventa quasi una gara tra chi possiede piu’ zucche e tra chi riesce a creare le facce piu’ originali, terribili e spiritose.
I giovani, travestiti da fantasmi, scheletri e streghe, si riuniscono in gruppi girando di casa in casa mimando il ritorno dei defunti e ripetendo “Trick or Treat”, che significa “Inganno o Offerta”; “Scherzo o Dolce”.
Pure da noi è ormai un classico, tra bambini, ragazzi e giovani, ripetere il motto: “Scherzetto o Dolcetto?”, “omologandosi” di fatto ai loro coetanei statunitensi.
E, questo, pare che si registri non solo in Italia, ma via via in ogni parte del mondo!
Le nuove usanze vanno così a sostituire le vecchie e consuete tradizioni che, in ogni paese, caratterizzavano un tempo la “festività dei morti”.
Nella tradizione “foggiana”, ad esempio, il “grano” faceva parte delle celebrazioni rituali “dei morti”.
Si usava mangiarlo in novembre in suffragio dei morti e rappresentava uno dei cibi rituali che scandivano il tempo della festa e del lavoro nella civiltà contadina.
E tale tradizione continua ancora oggi.
Una ciotola di “grano dei morti”
Il grano viene cotto ed amalgamato al mosto cotto, arricchito con chicchi di melograno e cioccolato fondente spezzettato, e quindi servito in ciotole individuali per essere gustato a fine pasto come dolce al cucchiaio, in abbinamento a un vino da dessert.
La tradizione del “grano dei morti” è presente, oltre che in Puglia, anche in altre regioni meridionali come la Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.
E sono tante le varietà degli ingredienti che in ogni località vengono aggiunti al grano cotto; si va dalla cannella alle noci o mandorle sgusciate, zucchero, cedro candito, uva passa ed altro.
E’ una specialità che si tramanda da generazioni nel “foggiano” per la ricorrenza dei morti.
Ingredienti per la preparazione del “grano dei morti” nel foggiano
Nell’area salentina questo dolce è detto “colva” o “coliba”, termine preso in prestito dal bizantino “kolba” che, a sua volta, deriva dal greco “koliva”; in altre parti della Puglia e’ conosciuto col termine dialettale di “cicc cuott”.
Nell’antica Grecia gli ingredienti di questo particolare dolce, grano e melograno combinati insieme, erano offerti a Demetra, dea dell’agricoltura e alla figlia Kore che, rapita da Fiutone, nell’Ade aveva assaporato i chicchi rossi.
Ancora oggi, in qualche parte della Grecia, fino a quaranta giorni dopo un decesso, si consuma grano cotto sulla tomba del defunto.
A partire dal neolitico, in area egea, il culto dei morti appare in tutta evidenza collegato con i riti stagionali della fertilità, e del ciclo del grano in particolare, nei quali il rifiorire della vita in primavera era messo in relazione con la resurrezione dalla tomba.
La dimensione magico-religiosa che accompagnava il lavoro agricolo era parte di un più complesso universo mitico-rituale.
Con le feste della “mietitura” si conclude il ciclo della spiga. Un ciclo che ha avuto inizio 7/8 mesi prima, al momento della semina, quando i chicchi sono stati introdotti nel seno della terra e affidati alle sue forze sotterranee.
La spiga, dal momento in cui si è alzata e irrobustita sullo stelo (aprile-maggio), si è tratta fuori dall’influenza delle potenze sotterranee. Anche esse però vanno ringraziate per quanto hanno fatto.
Se infatti la Commemorazione dei defunti apre il mese di novembre e la semina, i riti della rinascita primaverile, del periodo marzo-aprile, sono le ultime feste dei morti. In esse si saluta la vita nuova mentre si esprime gratitudine alle entità che hanno sostenuto il processo generativo.
Questo passaggio è nel Cristianesimo riassunto ed esplicitato dalla stessa vicenda del Cristo.
Il Risorto, non a caso, reca in mano un mazzo di spighe: egli è il Signore delle spighe.
La Settimana Santa è pertanto il luogo e il tempo del ritorno e del passaggio; è l’ultima festa della Terra e dei Morti.
La semina è dunque indissolubilmente correlata al culto delle divinità sotterranee e dei morti.
La coltivazione del grano risale a 5000 anni fa e sin dall’antichità ha rappresentato un alimento principale, semplice e nutriente.
Il grano è un cereale che si distingue in “grano duro” a frattura vitrea idoneo per la trasformazione in semola e pasta e “grano tenero” a frattura farinosa per la farina, per farne pane e dolci.
Tra prodotti tipici pugliesi più famosi figura il pane di Altamura, l’unico pane in Italia in grado di fregiarsi del marchio DOP.
Dal grano duro coltivato in Puglia non si produce solo pane, ma anche pasta fresca, come le orecchiette, il cui formato si erge a simbolo della Regione nel mondo intero.
Il “tartufo”… questo prezioso tubero!
Si svolge ad Alba in questi giorni la consueta fiera del tartufo.
La “Fiera del Tartufo” di Alba nacque nel 1929 con il nome di “Fiera-Mostra campionaria a premi dei rinomati tartufi delle “Langhe”, come prosecuzione dell’Esposizione agricola e industriale che si svolgeva ad Alba fin dall’inizio del secolo. Si era intuito che il tartufo, se opportunamente promosso, poteva diventare trainante per tutta la produzione agricola e artigianale locale.
E migliaia furono negli anni i visitatori che si recavano ad Alba per assistere alla sfilata dei carri allegorici e per assaggiare il tartufo.
Negli anni la Fiera ha cambiato il proprio volto, allungando i tempi di svolgimento e arricchendosi di aspetti culturali, come mostre d’arte, e di appuntamenti come il Palio degli asini e la Giostra delle Cento Torri.
La “Fiera del Tartufo” di Alba è la principale manifestazione che riguarda il prezioso tubero, a livello mondiale. Ogni anno sono veramente tante le persone che, da ogni parte del mondo, invadono letteralmente Alba per degustarlo nei ristoranti del posto, accompagnandolo con un buon bicchiere di Barolo. Ma anche per acquistarlo, scegliendo fra le varie ed infinite pezzature proposte, e portarlo a casa propria per consumarlo in famiglia con tutta calma, su un buon risotto alla parmigiana o anche su dei tagliolini fumanti (tajarin).
In cucina il tartufo è un mito prezioso.

Tartufo bianco in esposizione ad Alba
Il mondo del tartufo, per letteratura e per tradizione, è sempre stato avvolto da un alone di mistero, che ne ha creato il mito. I protagonisti, i semplici cercatori e coloro che lo hanno commercializzato ne hanno dato un’interpretazione soggettiva, legata alle lune, alle astuzie e agli accorgimenti del “mestiere di trifolao”, allo scenario delle colline, delle valli e delle brume ottobrine.
Il tartufo è una delle massime espressioni della cucina italiana e non solo. Profumatissimo, inebriante, coinvolgente, per molti addirittura afrodisiaco, il Tartufo Bianco d’Alba dà un tocco di nobiltà a ogni portata, conferendo un tono a piatti semplici (anche ad un semplice uovo all’occhio di bue) e originalità alle ricette più sfiziose.
Il suo impiego è ormai universale. Entrato quasi defilato nella cucina piemontese, grazie ai cuochi savoiardi cresciuti nelle cucine nobili parigine, il tartufo ha fatto il giro del mondo conquistando le tavole che fanno tendenza nei quattro angoli del pianeta. La voluttuosa versatilità, la capacità unica di rendere grande ogni piatto contribuisce in modo determinante a rendere assolutamente speciale il “Tuber magnatum Pico”.

Tartufo bianco in esposozione ad Alba
Come conservarlo?
Il tartufo dopo la raccolta dal terreno può conservarsi allo stato fresco per un tempo assai limitato, variabile in relazione alla specie, al grado di maturazione, alla presenza di larve e al metodo di conservazione impiegato; quando il tartufo accenna a perdere consistenza e si ammorbidisce esso è al limite massimo di conservazione e quindi va consumato subito. I metodi di conservazione domestica dei tartufi possono consentire di mantenerli freschi per qualche settimana in più. Si presuppone l’impiego del frigorifero (con temperatura ottimale da 0°C a 2 °C ed umidità relativa dell’ 80%-85%) o del surgelatore.
Conservazione nella carta : si prendono i tartufi freschi senza lavarli nè pulirli e si avvolgono uno per uno in carta porosa ed assorbente, (carta paglia). Dopo averli messi dentro contenitori di vetro ermetici, avendo cura che non stiano troppo stretti, si ripone il vaso in frigorifero negli scomparti più bassi dove è meno freddo; una volta al giorno va sostituita la carta inumidita con altra asciutta ed anche il contenitore va asciugato interamente dalla condensa. Così facendo si possono mantenere i tartufi freschi anche per una quindicina di giorni.

Un piatto di tajarin al tartufo bianco di Alba
Per saperne di più
Il Tartufo è conosciuto fin dall’antichità nonostante non si possa essere sicuri che gli storici dell’antichità parlassero di questo o di altri funghi ipogei. Si narra che il tartufo comparisse nella dieta di Ebrei e Sumeri intorno al 1700-1600 a.C. Le prime notizie certamente attribuibili al tartufo compaiono nell’opera di Plinio il Vecchio Historia Naturalis (79 d.C). Si racconta che il tubero era molto apprezzato dai Romani. Tra le molte leggende che aleggiano intorno all’Araba Fenice della gastronomia internazionale, il tartufo appunto, c’è quella secondo la quale il tartufo nasce dall’azione combinata dell’acqua, del calore e dei fulmini. Da questa diceria molti poeti trassero ispirazione per alimentare il mito del tartufo fino a Giovenale che spiegò l’origine di questo strano e raro fungo come frutto di un fulmine scagliato da Giove nei pressi di una quercia (albero consacrato al Padre degli Dei). Dal momento che Giove era famoso per la prodiga attività sessuale al tartufo sono state da sempre attribuite qualità afrodisiache. Riguardo al tartufo per molto tempo si è fatta molta confusione anche a proposito della sua classificazione. Alcuni naturisti lo definivano una pianta, altri una escrescenza del terreno alcuni, addirittura, un animale. In Italia la patria del tartufo è sicuramente il Piemonte e in particolare modo un ristretto territorio della Langa Roero e, in parte, del Monferrato. Il tartufo negli anni ha acquistato una fama mondiale essendo particolarmente raro. Sfuggente, misterioso, irraggiungibile il tartufo è capace con il suo profumo di risvegliare i sensi in una sorprendente varietà di toni e di sfumature delle piante con cui il tartufo vive in simbiosi: pioppi, salici, noccioli. Ogni tartufo ha la sua storia e ogni pianta ha il suo tartufo. Se l’ambiente naturale non viene violato il tartufo rimane fedele alla sua pianta crescendo sempre alla sue radici. E’ per questo motivo che il “trifolao” annota gelosamente su un registro le coordinate del luogo per tramandarle, insieme ad altri segreti del mestiere, ai propri figli. Nonostante una storia gastronomica molto antica la consacrazione di questo tubero è avvenuta negli ultimi due secoli alla corte dei nobili nonostante la cucina povera non abbia mai disdegnato una bella insalata con il tartufo. La ricerca del tartufo vede coinvolti, in un binomio inscindibile, l’uomo e il suo cane. L’olfatto di quest’ultimo è reso finissimo da uno speciale addestramento i cui successi sono premiati ogni volta da un tozzo di pane, da una carezza o da un pezzo di tartufo. Il Tartufo bianco di Alba (Tuber magnatum Pico) è giudicato da tutti gli esperti il migliore in assoluto. La specie La determinazione delle diverse specie di tartufi è basata sulla forma, sulla dimensione, sul colore, sulle ornamentazioni del peridio, sull’aspetto della gleba, sul profumo e sul sapore. Qualora queste caratteristiche non siano sufficienti, è necessario l’esame microscopico degli aschi e delle spore che possono essere reticolate, alveolate o spinulate. Attualmente è possibile determinare i tartufi in tutte le fasi del loro sviluppo mediante esami biomolecolari. In Italia si raccolgono una decina di specie di tartufi, tra queste la più pregiata è il: Tuber magnatum Pico (tartufo Bianco d’Alba o d’Acqualagna o Bianco pregiato) che ha sempre mantenuto il primato, oltre che sulla tavola, anche sui prezzi. Seguono il T. melanosporum Vitt. (tartufo nero di Norcia e Spoleto o Nero pregiato) che a tutt’oggi, in Italia, non è stato ancora apprezzato come merita. Il T. borchii Vitt.(Bianchetto o Marzuolo), il T. aestivum Vitt. (Scorzone) con la sua varietà uncinatum Fischer oggi riportata come specie nella legge italiana, il T. brumale Vitt. (tartufo Invernale) con la sua varietà moschatum Ferry e il profumato e saporito T. macrosporum Vitt. (Nero liscio). Di importanza trascurabile sono il T. rufum Pico (Rossetto), il T. mesentericum Vitt.(tartufo di Bagnoli), il T. nitidum Vitt., Il T. ferrugineum Vitt. ed infine il T. excavatum. Altre specie di funghi ipogei comunemente raccolte, ma di nessun pregio gastronomico, appartengono ai generi Terfezia, Delastria, Picoa, Genea, ecc. Merita qui ricordare che non esistono tartufi tossici, ma che alcuni riconoscibili dall’odore nauseante o dalla assoluta mancanza di odore, possono provocare lievi disturbi gastrointestinali. Alcuni di questi, definiti “falsi tartufi”, appartengono ai generi Balsamia e Choiromyces. Nel nostro Paese trova gli ambienti ottimali sull’Appennino centrale (Umbria e Marche), dove Norcia è uno dei centri più rinomati di produzione. Ambienti di raccolta non mancano in Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria e al sud in Campania (da poco anche in Molise). Il tartufo invernale si trova prevalentemente nelle aree di diffusione del “nero pregiato”. Il tartufo di Bagnoli, pur essendo presente in tutte le aree tartuficole, ha la sua zona di maggior produzione in Campania. Il Bianchetto è probabilmente il tartufo con maggiore diffusione, ma le maggiori raccolte sono localizzate nelle pinete dei litorali. Alcune specie, quali il T. brumale, il T. mesentericum, il T. aestivum e il T. borchii vengono raccolti in piccole quantità anche in Germania, Svizzera, Cecoslovacchia e Inghilterra. In Asia, Africa, America e Australia, vengono raccolte specie di tartufi di poco pregio.
E’ necessario ricordare che l’aroma dei Tuber varia a seconda del grado di maturazione dei corpi fruttiferi. Tra le molte specie di tartufi identificate, le specie più pregiate si trovano solo in Italia, Francia, Spagna e nel nord dell’ex Jugoslavia. In particolare va sottolineato che il tartufo bianco pregiato è stato finora trovato solo nel centronord dell’Italia e nell’ex Istria. Le zone tipiche di produzione si trovano nel Piemonte meridionale e precisamente sulle rinomate e caratteristiche colline di Torino, delle Langhe e del Monferrato.
La città di Alba vanta il più vecchio mercato che, per la qualità del prodotto trattato, ne determina il prezzo“ufficiale”.
E che prezzi … veramente prezioso questo tubero !!!
Tartufo nero (più a buon mercato) in esposizione ad Alba
Padre Pio “si congeda” a San Giovanni Rotondo
Si è conclusa nei giorni scorsi a San Giovanni Rotondo l’ostensione delle spoglie di Padre Pio.
Dopo 17 mesi nei quali i resti mortali sono stati esposti alla venerazione dei fedeli, il corpo del santo riposa in un sarcofago che è stato definitivamente chiuso nella cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo.
La cittadina di San Giovanni Rotondo si trova ad una cinquantina di chilometri da Poggio Imperiale.
Fu fondata nel 1095 sulle rovine di un preesistente villaggio del IV secolo a.C., e di questo borgo restano ancora dei segni visibili, come alcune tombe ed un battistero circolare (“rotondo”, dal quale trae il proprio appellativo) che anticamente era destinato al culto di Giano, Dio bifronte, e in seguito fu consacrato a San Giovanni Battista.
Qui dal 4 settembre 1916 al 23 settembre 1968 visse e morì Padre Pio da Pietrelcina.
Il giorno 24 settembre scorso è giunto a conclusione il periodo di esposizione pubblica dei resti mortali del Santo da Pietrelcina, e così Padre Pio si “congeda” dopo 17 mesi di ostensione iniziata il 24 aprile dell’anno scorso e che ha richiamato milioni di fedeli.
Il corpo del Santo è stato prelevato dalla teca trasparente dove è stato ammirato in questi mesi da folle di fedeli ed è stato riposto in una nuova teca in plexiglass, adagiato su un materasso realizzato in modo da mantenere inalterato il tasso di umidità.
E’stata rimossa la maschera in silicone (che tante polemiche aveva destato) ed il volto è stato coperto semplicemente da un velo.
L’urna è stata quindi riposta all’interno di un sarcofago, con finiture in argento, non trasparente, realizzato da Guy Georges Amachoukeli, detto Goudji, orafo della Georgia, naturalizzato francese.
Il frate cappuccino stringe tra le mani un crocifisso.
Le operazioni sono durate in tutto circa 11 ore ed ora le spoglie riposano nella nuova collocazione, sempre all’interno della cripta del santuario della Madonna delle Grazie.
Non è stata infatti stabilita alcuna data per la traslazione nella nuova chiesa di San Pio.
I dintorni di Poggio Imperiale
Il Lago di Lesina
Il Lago di Lesina ha un’origine simile a quella del vicino Lago di Varano: un antico golfo “chiuso” dai sedimenti marini, separato dal Mar Adriatico da un cordone sabbioso largo circa 800 metri, detto Bosco Isola. Rappresenta una delle più grandi lagune del Mediterraneo meridionale e deve la sua fama alla pescosità delle acque, ricche soprattutto di anguille. La laguna è collegata al mare attraverso due canali artificiali, denominati Acquarotta e Schiapparo, e riceve acque dolci da piccoli fiumi e canali di bonifica. Nei periodi di bassa marea, a poca distanza dal centro abitato di Lesina, affiora nel lago l’isoletta di San Clemente.
Punta Pietre Nere
Si tratta di elementi geologoci dalle caratteristiche davvero singolari e rare, che emergono dalla spiaggia di Lesina Marina in prossimità della foce del canale Acquarotta, e si presentano come un ammasso di scurissimi affioramenti di formazione geologica, costituito da rocce vulcaniche risalenti al Triassico; dunque a ben 245 milioni di anni fa. Le “pietre nere” di Lesina Marina potrebbero forse essere le più antiche rocce di tutta la Puglia e dell’Italia.
L’oasi “Duna di Lesina”
In prossimità del canale Acquarotta, tra il lago di Lesina e il Mare Adriatico si trova l’oasi “Duna di Lesina, che si estende per circa 25 ettari. Si tratta di un interessante sito che costeggia il canneto e gli specchi d’acqua della riserva naturale istituita nel settore orientale del bacino. E’ uno dei tratti costieri italiani più intatti dal punto di vista naturalistico. Presenta, infatti, una ricca varietà di specie faunistiche, quali il fenicottero rosa, l’airone bianco e rosso, il cormorano, diverse specie di anatre selvatiche, il pettirosso, l’airone cinerino, il falco di palude, il martin pescatore. Tutta la parte orientale del lago costituisce, dal 1981, “Riserva Naturale per il ripopolamento animale”.
Il Bosco Isola
Il Bosco Isola è un cordone litoraneo che separa la laguna di Lesina dal mare e costituisce la più interessante testimonianza di macchia mediterranea in una striscia di terra che percorre 18 km lungo un terreno sabbioso: boschi di leccio e pino, frammisti a carpino ed olmi, odorosi di mirto, alloro e rosmarino, circondato da vaste distese di cisto ed eriche tra cui si elevano, a macchia, ginepri ed olivastri.
Le Torri (Torre Fortore – Torre Scampamorte – Torre Mileto)
Si tratta di torri costiere di avvistamento e difesa, volute già in epoca aragonese e poi dagli spagnoli fino ai “Borbone”, e costruite per infittire la difesa della costa garganica contro temute incursioni.
Torre Fortore: la sua origine risale al 1485, quando Ferdinando d’Aragona conferiva a Riccardo Orefice la facoltà di costruire una torre di difesa del porto e della spiaggia di Fortore.
Torre Scampamorte: risale all’epoca del viceregno spagnolo, secolo XVI, e venne eretta dov’era un tempo la foce del canale S. Andrea, oggi interrata.
Torre Mileto: è la stazione balneare del comune di San Nicandro Garganico ed è situata sulla fascia costiera tra i laghi di Lesina e Varano. Il toponimo, che impropriamente identifica anche una parte dell’istmo che separa il Lago di Lesina dal mare, è riferito invece proprio alla torre, probabilmente una delle più grandi ed antiche della costa adriatica, nonché il punto della terraferma più vicino in assoluto alle Isole Tremiti per la distanza di sole 11 miglia.
Il Parco Archeologico di Monte Elio
A poca distanza da Torre Mileto, si trova il Monte D’Elio. E’ un rilievo roccioso che divide la Laguna di Lesina dalla Laguna di Varano, coperto in buona parte da fitti boschi di leccio. L’intera area, che versava in un profondo stato di degrado, è stata valorizzata attraverso la realizzazione del Parco Archeologico e Ambientale, ove sono stati riportati alla luce i ruderi di un antico borgo medievale. Una delle testimonianze più significative è costituita dai resti della bellissima Chiesa di Santa Maria. Gli altri reperti portati alla luce dagli archeologi risalirebbero al X sec. c.a. In epoca medievale vi sorgeva l’antica città di Devia, con la Chiesa romanica di Santa Maria che, attorno all’anno Mille, risultava concessa all’abate di Santa Maria delle Tremiti, come testimonia un antico documento dell’epoca.
La Dolina Pozzatina
Al 13mo chilometro della strada provinciale che da San Nicandro Garganico porta a San Marco in Lamis, si trova la Dolina Pozzatina. E’ una sorta di grande anfiteatro naturale dalla forma ellittica, originata dall’erosione dell’acqua per circa 100 metri di profondità ed un perimetro pressoché circolare di 1.850 metri complessivi. E’ una delle maggiori doline d’Italia, nonché la più grande della Puglia. Lateralmente è ricoperta di vegetazione spontanea di leccio, alaterno, lentisco, cerro, frassino, acero e olmo. Il territorio circostante è caratterizzato da un altopiano carsico con depressioni doliniformi e substrato geologico di calcare cretacico. Le condizioni di frescura, l’umidità e la profondità del sedimento che si accumula sul fondo, creano un microclima che determina la differenziazione di vegetazione tra l’ambiente interno e quello circostante.
Il Lago di Varano
In contrada Chianca, a circa 8 chilometri da Ischitella, si trova il Lago di Varano, che si estende su una superficie di circa 53 kmq.
La sua formazione geologica è relativamente recente (1000 d.C. c.a.). Il cordone litoraneo che chiude l’ampio golfo si sarebbe formato in seguito al continuo deposito di materiale solido trasportato dalle correnti del medio-basso Adriatico. Esso possiede una ricca vegetazione di pini d’Aleppo, ginepri e lentischi, dove vi dimorano cormorari, gabbiani, cuculi e tortore. Tra le lagune italiane, la laguna di Varano è una delle più interessanti ed atipiche; infatti, le sue caratteristiche morfologiche, fatte di coste alte e a picco e la profondità dei suoi fondali di 5,5 metri, la discostano molto dalla tipologia delle altre lagune, caratterizzate da sponde ed acque basse. Il Lago è collegato al mare per mezzo delle foci di Capoiale e di Varano, che ne elevano la salinità ed evitano l’impaludamento della zona. Alcuni studiosi antichi, tra cui Strabone, Pomponio Mela e Tolomeo, si riferivano, nelle loro opere, ad un’insenatura, un ampio golfo “incastonato” nelle pareti scoscese del Gargano nord, che si estendeva da Rodi fino all’odierna Torre Mileto, denominato “Sinus Uriae”.
Ma cosa sta succedendo a “Torre Fortore – Lesina Marina“ e a “Torre Mileto” ?
Percorrendo la lingua di terra che separa il Mare Adriatico dal Lago di Lesina, si incontrano “Torre Fortore – Lesina Marina” e “Torre Mileto”, due località balneari facilmente raggiungibili in quanto poco distanti dai rispettivi comuni di Lesina e Sannicandro Garganico.
E il vicino casello dell’uscita di “Poggio Imperiale” dell’autostrada A 14 assicura il comodo collegamento con ogni località italiana ed europea.
La spiaggia, dalla finissima sabbia dorata, si allunga a perdita d’occhio e segue ininterrottamente il litorale, regalando uno scenario davvero suggestivo, evidenziato dall’azzurro intenso del mare che lambisce la costa.
E, a largo, proprio di fronte, le stupende Isole Tremiti.
L’economia di “Torre Fortore – Lesina Marina” e di “Torre Mileto” (o Maletta) è basata soprattutto sul turismo estivo e sulla pesca.
Oltre agli insediamenti abitativi, negli ultimi anni sono sorti numerosi villaggi turistici, moderne strutture di ricezione alberghiera, parchi acquatici e campeggi attrezzati.
Rara la bellezza dei paesaggi che si estendono nella selvaggia “macchia mediterranea”, conservando il fascino delle dune tra mare e lago, tra piante di mirto, rosmarino e liquirizia, cespugli di asparagina, rovi di more e rucola spontanea.
Vaste pinete, a ridosso della spiaggia, si alternano ad oliveti millenari e lussureggianti pianure, ricche di vegetazione di ogni genere, si alternano a monti frastagliati man mano che il promontorio del Gargano si fa più prossimo.
La duna, che da Torre Fortore porta a Punta Pietre Nere, fa da cornice all’insediamento turistico di Lesina Marina, con un’ampia spiaggia costeggiata da una fitta boscaglia, ricca di vegetazione e profumata di piante particolari.
A “Torre Mileto”, invece, c’è anche l’alternativa di coste rocciose che si calano a picco sul mare, offrendo agli appassionati l’opportunità di effettuare immersioni subacquee per pescare o solamente per osservare gli interessanti fondali marini.
Ma cosa sta succedendo a “Torre Fortore – Lesina Marina”, ove si parla già da qualche anno di “dissesto idrogeologico”, e a “ Torre Mileto” ove si parla di abusivismo edilizio su area demaniale?
Per “Torre Fortore – Lesina Marina” si riporta un articolo del 7 agosto 2008 tratto dal sito: www.teleradioerre.it
« Lesina Marina, case a rischio per dissesto idrogeologico. L’anno scorso di questi tempi a Lesina Marina a fare paura erano le fiamme. Quest’anno invece l’acqua del mare che, tramite il canale che la collega al lago, penetra nella falda e scioglie i tetti in gesso delle cavità , quanto basta per mettere a rischio la stabilità degli edifici sovrastanti. Tre i condomini già sgomberati. Per altre 300 case, che potrebbero diventare 450, il rischio è dietro la porta. Le oltre 30mila persone che risiedono nella località di mare, a due passi da Lesina, sono fortemente preoccupate dall’aggravarsi del fenomeno del dissesto idrogeologico del quale si è occupato anche il Prefetto ……….., che si è detto favorevole alla chiusura dell’intero villaggio. Il sindaco di Lesina ……………. cerca di non creare ulteriori allarmismi ma pare abbia chiesto ad alcuni residenti di autofinanziare i sondaggi geologici per capire quali stabili sarebbero in pericolo. Se queste risposte tecniche ai possibili rischi di crollo non arriveranno entro 20 giorni, i condomini interessati dovranno essere chiusi previa ordinanza di sgombero del Comune. La situazione è tesa e si aggrava proprio nel clou della stagione estiva, scatenando preoccupazioni negli operatori che temono la crisi. Per evitare però la situazione diventi oggetto di strumentalizzazioni, il sindaco ………….. ha convocato per domani alle 19.00 all´hotel ‘Lesina’ una conferenza per aggiornare sulla vicenda. All’incontro parteciperanno proprietari di immobili, esperti in materia, villeggianti, operatori turistici e rappresentanti del mondo politico. Marzia Campagna ».
Con decreto del 31/10/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 12 dicembre 2009 stante l’accertata grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità causata dai crolli improvvisi del suolo. Le rocce gessose sottostanti, infatti, per effetto delle infiltrazione di acqua dal canale “Acquarotta” si stanno sciogliendo. Il grave fenomeno provoca danni al demanio ed alla proprietà privata.
Il Comune di Lesina avrebbe già emanato un bando di gara pubblica per gli “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località Lesina Marina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico”, per un importo do oltre due milioni di euro, ed i lavori sarebbero in corso di esecuzione.
Per “Torre Mileto” si riporta un articolo del 12 luglio 2009 tratto dal sito:
« Legambiente: “Giù il villaggio di Torre Mileto”.
“Abbattere il villaggio di Torre Mileto”. A chiederlo con forza è Legambiente che lo ha inserito nella Top Five degli ecomostri nazionali. La notizia arriva da Bari dove questa mattina la squadra di tecnici di “Goletta Verde”, proprio a bordo dell’imbarcazione ambientalista, ha illustrato le criticità del mare e delle coste pugliesi. “Abbattere è la parola d’ordine per vincere la guerra contro il cemento illegale” , ha dichiarato …………, presidente Legambiente Puglia che ha deciso di scrivere anche al sindaco di Lesina, per chiedere che si attivino al più presto le procedure per l’abbattimento di quella cerniera di cemento illegale a Torre Mileto. Altro problema, oltre l’abusivismo, è l’inquinamento alle foci dei fiumi. In Puglia, i biologi di”Goletta verde” hanno rilevato ben 9 punti critici: quattro di questi in provincia di Foggia. Fortemente inquinate le foci dell’Ofanto, del Candelaro e del Fortore, un po’ meno quella di Varano. Per la costa pugliese i dati non sono però solo negativi. La Puglia vanta un’altissima percentuale di balneabilità (98,3%), risulta anche la più premiata dopo Sardegna e Toscana sulla Guida di Legambiente e Touring Club, con ben 36 località consigliate per paesaggi, accoglienza turistica, fondali particolarmente interessanti, luoghi di interesse storico culturale e pulizia del mare e delle spiagge. Tra queste conquista quattro vele Chieuti, in provincia di Foggia ».
Pare che siano in corso trattative per la sanatoria di alcuni immobili (abusivi) realizzati al di fuori dell’area demaniale, contro l’abbattimento delle costruzioni abusive insistenti in area demaniale, per il ripristino dei principali valori ambientali del territorio, ovvero della fascia costiera fino a ottanta metri dalla battigia.
A quando la risoluzione di tutti questi problemi?
“Viaggio d’autunno” di Giacomo Fina
Alle ore 19,30 di sabato 22 agosto 2009, alla presenza di un folto pubblico, presso la Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale è avvenuta la presentazione del libro “Viaggio d’autunno”, una raccolta di poesie di Giacomo Fina, Edizioni del Poggio.
Sono intervenuti, per il Comune di Poggio Imperiale che ha patrocinato l’evento, il Vice Sindaco Alberto Caccavo, l’Assessore alla Cultura Antonio Mazzarella e l’Assessore alle politiche sociali Maria Michela Fina, peraltro figlia dell’autore.
Relatori, la Prof.ssa Oriana Fidanza, scrittrice, il giornalista e scrittore Giucar Marcone e l’autore del libro Giacomo Fina, mentre il coordinamento e la presentazione sono stati affidati al Prof. Florindo Di Silvio.
Il libro, che fa parte di “Emozioni”, la “Collana di Poesia” diretta da Giucar Marcone delle Edizioni del Poggio, aggiunge un ulteriore tassello al variegato universo delle pubblicazioni nel quale Giuseppe Tozzi, l’Editore presente alla cerimonia di presentazione, sta dimostrando doti di grande capacità professionale e di perseveranza, visto il livello di affermazione conseguito in campo nazionale.
La perspicacia di saper offrire anche ad autori emergenti l’opportunità di esprimersi e rendere pubbliche le loro “emozioni” rappresenta forse la chiave del suo successo.
Giacomo Fina (Mimì per gli amici) è un altro “Tarnuèse” che ha vissuto per oltre vent’anni lontano da Poggio Imperiale – a Monselice, in provincia di Padova, per la precisione – ma che ha mantenuto forti legami con la propria terra ove, non appena possibile, ha sempre fatto ritorno.
Ne sono prova le poesie dedicate a Poggio Imperiale… “Così era il paese”, “Così era la festa”…ma anche “Che tristezza”…e tante altre che palesemente o solo velatamente, a volte in somma letizia ed a volte anche con profonda amarezza, localizzano l’azione in quel paesino della Capitanata, che è per l’appunto Poggio Imperiale.
<< Questa nuova raccolta di poesie di Giacomo Fina è il racconto in versi del suo vissuto sia in prima persona che come acuto osservatore delle varie stagioni della vita. Emblematico il titolo “Viaggio d’autunno”, metafora di quella fase della vita che porta alla riflessione, al bilancio di quel che si è fatto, un consuntivo sul quale meditare per affrontare con maggiore serenità l’ “inverno”. La poesia di Fina è lo scandaglio di episodi che riaffiorano dal deposito della memoria, complice una struggente nostalgia per un passato lastricato di ricordi, di speranze, di timori. Sul filo della memoria si snodano immagini care, familiari, momenti tristi e meno tristi, … amari, portati, talvolta, dalla voce del vento, ambasciatore di sentimenti mai sopiti >> (1)
Anche i disegni riportati all’interno del libro ed il dipinto di copertina sono opera del medesimo autore.
Giacomo Fina non è nuovo a queste esperienze; egli ha infatti già pubblicato nel 2007 un’altra raccolta di poesie sue e di suo figlio Gino, scomparso immaturamente in una tragica circostanza:
“Dialogo Postumo” di Giacomo Fina e Gino Fina, Malatesta Editrice.
(1) Il testo virgolettato << …… >> è tratto dalla quarta di copertina del libro “Viaggio d’autunno” di Giacomo Fina, Edizioni del Poggio.
La “Cantina Ferrazzano” a Poggio Imperiale.
La “Cantina Ferrazzano” di Poggio Imperiale è di recente costruzione e fonda le sue radici in un territorio ricco di tradizione, conciliando con i valori di un tempo le più moderne ed innovative tecniche di produzione.
Può veramente un calice di vino raccontare millenni di storia umana?
E’ grazie alla perspicacia e la determinazione di Giuseppe Ferrazzano, che dopo ben 21 anni di permanenza in Toscana, terra di grandi e pregiati vini italiani, nel 2006 è tornato al suo paese di origine, Poggio Imperiale, ed ha acquistato un podere in località “Fucicchia” per impiantarvi dei vigneti.
La passione per i vigneti e per la produzione del vino Giuseppe (Peppino per gli amici) ce l’ha nel sangue; già suo padre Michele svolgeva il mestiere di “vignaiuolo” presso i vigneti “del Conte” di Santo Spirito e di San Nazario ed ancor prima il nonno Pietro presso i vigneti e la cantina dei “Nista”.
Una passione che Peppino sta cercando ora di trasmettere anche ai suoi figli.
L’attuale varietà riguarda 3 ettari di uve “Montepulciano” dalle quali ricava un vino rosso da 13,5 gradi; 1 ettaro e mezzo di uve “Merlot” dalle quali ricava un vino rosso da 14,5 gradi ed 1 ettaro e mezzo di uve “Syrah” dalle quali ricava un vino rosso da 14 gradi.
Il sistema di “allevamento” è quello denominato “cordone speronato”, la resa è di circa 80 quintali per ettaro e la produzione avviene attraverso una diraspatura e pigiatura soffice, con maceratura di 15 giorni alla temperatura di 27 – 29° C
I vini prodotti hanno ottenuto la classificazione IGT Puglia (Indicazione Geografica Tipica Puglia) e sono venduti direttamente presso la cantina di produzione sfusi o imbottigliati, ma possono anche essere ordinati telefonicamente con consegna a domicilio in ogni località italiana od estera.
Oltre ai vini “Moltepulciano”, “Merlot” e “Syrah”, la “Cantina Ferrazzano ricava dalle sue uve due ulteriori speciali vini: il “Fucicchia” ed il “Rosè”.
FUCICCHIA
Il “Fucicchia” è prodotto da uve Montepulciano e Merlot, due vini di grande carattere che, combinati insieme, danno come risultato un gusto intenso e piacevole.
Robusto e di grande struttura, questo vino si sposa perfettamente con carni rosse, sughi e pietanze dal sapore intenso.
Colore: rosso rubino intenso
Varietà: Montepulciano 65% Merlot 35%
Classificazione: IGT Puglia
ROSE’
Il “Rosè” è ottenuto da uve Montepulciano ed è caratterizzato da un colore rosa limpido.
E’ un vino delicato, ma dal gusto aromatico e deciso, perfetto per accompagnare pietanze leggere come carni bianche o pesce.
Ottimo come aperitivo, servito ad una temperatura di 10 – 12° C
Colore: rosa limpido
Varietà: Montepulciano
Classificazione: IGT Puglia
Sull’etichetta delle bottiglie del vino rosso “Fucicchia” si legge: “Un calice di vino racconta millenni di storia umana”.
Sarà poi vero?
Varrebbe la pena togliersi il dubbio gustando di persona un buon bicchiere di vino spillato direttamente dalla botte nella cantina da Peppino.
Ma forse anche a casa propria…non è male!
La “Cantina Ferrazzano” si trova a Poggio Imperiale (Foggia) in via San Severo snc, ma è raggiungibile anche telefonicamente (TEL/FAX +39 0882 997999 – cell. +39 329 7157577) o via internet: www.cantinaferrazzano.com; info@cantinaferrazzano.com:
“www.paginedipoggio.com” compie il suo primo anno di vita!
Un luogo privilegiato di osservazione
sul passato, presente e futuro.
Sul mondo intero
(l.b.)
32 articoli pubblicati a tutto il 12 agosto 2009 e corredati per lo più di puntuale documentazione fotografica, con una media di circa 3 articoli al mese, ripartiti nelle seguenti Sezioni:
– Ddummànne a l’acquarùle se l’acqu’è fréscijche (8);
– Divagazioni (2);
– Eventi (9);
– Storia (4);
– Viaggi (8);
– Work in progress (1)
CLASSIFICA ARTICOLI
MAGGIORMENTE “CLICCATI”
(oltre 300 volte)
– YAD VASHEM IL MUSEO DELL’OLOCAUSTO DI GERUSALEMME: la didascalia contestata. Linkato 658 volte;
– A Milano “folgorati” dalla “Conversione di Saulo” del Caravaggio. Linkato 558 volte;
– QUMRAN: IL MISTERO DEI ROTOLI DEL MAR MORTO. Linkato 378 volte
-MASADA, la fortezza erodiana: il mistero del suicidio collettivo. Linkato 344 volte;
– Ma vi è anche una via Francigena del Sud? Linkato 342 volte;
– A proposito di San Placido Martire. Linkato 312 volte;
– La stella di Batlemme. Linkato 305 volte.