Category Archives: Blog
Le spoglie di Padre Pio di nuovo visibili

Anche quest’anno, come di consueto, nel corso del periodo estivo trascorso a Poggio Imperiale, abbiamo riservato una visita alla Tomba di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.
La novità di quest’anno è nota a tutti per la risonanza che ha avuto in tutto il mondo: le spoglie di Padre Pio sono di nuovo visibili ai fedeli e lo saranno per sempre.
Infatti, dallo scorso mese di giugno a San Giovanni Rotondo l’ostensione del corpo del Santo da Pietrelcina è divenuta permanente.
I devoti di Padre Pio, in visita alla sua Tomba, dal primo giugno 2013 possono dunque di nuovo osservare le spoglie del frate delle stimmate.
Già in passato, dal 24 aprile 2008 al 24 settembre 2009, il corpo dell’umile servo di Pietrelcina fu mostrato – per 17 mesi – ai pellegrini giunti numerosi a San Giovanni Rotondo nella (vecchia) cripta del Santuario di Santa Maria delle Grazie. Si parlò di cinque milioni e mezzo di persone, commosse e stregate da quel volto “racchiuso in una maschera di silicone”. Anche il Papa Benedetto XVI compì la sua visita il 21 giugno 2009.
Da allora sono passati quasi quattro anni.
Dopo quella breve ostensione, i resti mortali di San Pio vennero racchiusi in un “sarcofago” di pregiata fattura e trasferiti nella (nuova) cripta costruita sotto l’imponente Chiesa realizzata dall’architetto Renzo Piano e, più precisamente, nell’intercapedine del plinto centrale della Chiesa Inferiore.
I fedeli potevano quindi vedere, da uno “squarcio” appositamente praticato nella parete, solamente una parte del “sarcofago”.
Pare che, in questi quattro anni, moltissime siano state le richieste giunte alle Autorità Ecclesiastiche per una nuova ostensione, tant’è che la Diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ha così deciso di aderire al desiderio del popolo dei fedeli, superando ogni aspettativa, nel senso che l’ostensione accordata non sarà limitata nel tempo, ma diventerà permanente.
Il corpo di San Pio è ora custodito in un’urna di vetro, che è stata collocata nello stesso luogo di prima (intercapedine del plinto della Chiesa Inferiore), con la sola differenza che adesso è ben visibile al pubblico.
E’ stato il Prefetto della Congregazione delle cause dei santi, cardinal Angelo Amato, a presiedere la celebrazione eucaristica officiata a San Giovanni Rotondo per l’inizio dell’esposizione del Santo.
Migliaia di pellegrini hanno partecipato alla cerimonia religiosa.
Nel corso della sua omelia il cardinale ha spiegato che San Pio “vuole che lo guardiamo in faccia e lui vuole guardarci in faccia. La sua unica missione era e continua ad essere fare del bene ad altri”.
Tanti fedeli hanno seguito i Frati Minori Cappuccini nella cripta della Chiesa Nuova dove ora, e per sempre, sono custodite – in un’urna di vetro – le spoglie mortali di San Pio.
La 6^ Edizione del Premio Nazionale “Spiga d’Oro”
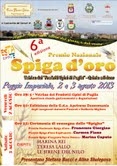
A Poggio Imperiale grandi preparativi per la 6^ edizione del Premio Nazionale “Spiga d’Oro” che si terrà il 2 e il 3 Agosto 2013.
La nota manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è promossa dall’Associazione Culturale “Terra Nostra Onlus” di Poggio Imperiale presieduta da Gianni Saitto che, dell’evento, è l’ideatore e l’organizzatore, con la collaborazione della Regione Puglia (Assessorato alle Risorse Agroalimentari), la Provincia di Foggia (Assessorato alla Cultura) e il Comune di Poggio Imperiale, ed il patrocinio dei Comuni di San Severo, Apricena, San Paolo Civitate e Lesina.
Il programma si snoda, come sempre, in due serate:
• Venerdi 2 agosto 2013
Ore 19:00 – Vetrina dei Prodotti Tipici di Puglia con stands gastronomici e degustazioni
Ore 21:00 – Esibizione della G.d.s. Apricena Dancemania degli insegnanti Antonio Pizzicoli e Raffaella Migliore
• Sabato 3 agosto 2013
Ore 21:00 – Cerimonia di consegna delle “Spighe”
– Premio Nazionale Spiga d’Oro: Francesco Giorgino
noto giornalista e conduttore televisivo RAI (TG1), pugliese di origine, nato ad Andria
– Premio Spiga d’Oro Capitanata: Carmen Fiano
nota campionessa nazionale di corsa su strada (ultramaratona) , nata a San Severo
– Premio Spiga d’Argento Terra Nostra: Marina Caputo
cantante di musica leggera poggioimperialese
La presentazione è a cura Stefano Bucci e Alina Shulepova
Gli affreschi di Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni

Fra le tante bellezze da vedere, vi è a Padova uno dei capolavori assoluti dell’arte mondiale.
Una tappa che vale la pena programmare, magari in occasione di una visita alla celebre Basilica di Sant’Antonio.
Si tratta della “Cappella degli Scrovegni”, che rappresenta un capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande maestro toscano Giotto nella sua maturità.
Colore e luce, poesia e pathos. L’uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo unico ed irripetibile le storie della Madonna e di Cristo.
Il ciclo pittorico della Cappella è sviluppato da Giotto in tre temi principali: gli episodi della vita di Gioacchino e Anna (riquadri 1-6), gli episodi della vita di Maria (riquadri 7-13) e gli episodi della vita e morte di Cristo. In basso a questi affreschi, una serie di riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù.
La Cappella sorge tra i ruderi dell’antica Arena di Padova, risalente ai secoli tra il 60 e 70 d.C. (attualmente in loco sono in corso interessanti scavi archeologici).
Nel XIV secolo l’ area fu acquistata dagli Scrovegni, ricca famiglia padovana di banchieri e usurai, che qui nel 1300 vi fecero erigere il loro palazzo. Tra il 25 marzo 1303 e il 25 marzo 1305 fu innalzata la Cappella dedicata alla Vergine Annunziata, per volere di Enrico Scrovegni in suffragio dell’anima del padre Reginaldo, collocato nell’Inferno , proprio perchè usuraio, da Dante Alighieri nella “Divina Commedia”.
La Cappella presenta un’architettura molto semplice: un’elegante trifora gotica in facciata, alte e strette finestre sulla parete sud, all’interno un unico ambiente terminante sul fondo con un presbiterio in cui si trova il sarcofago di Enrico Scrovegni, opera di Andriolo de Santi.
Non si conosce il nome dell’architetto dell’edificio: per alcuni potrebbe essere lo stesso pittore fiorentino Giotto.
Per adornare l’edificio, destinato ad accogliere lui stesso e i suoi discendenti dopo la morte, Enrico Scrovegni chiamò due tra i più grandi artisti del tempo. A Giovanni Pisano commissionò 3 statue d’altare in marmo raffiguranti la Madonna con Bambino tra due diaconi, mentre a Giotto la decorazione pittorica della superficie muraria.
Giotto era un artista già celebre: aveva lavorato per il Papa nella Basilica di San Francesco in Assisi e in San Giovanni in Laterano a Roma, ed ancora a Padova nella Basilica di Sant’Antonio e nel Palazzo della Ragione.
A Giotto venne affidato il compito di raffigurare una sequenza di storie tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento che culminavano nella morte e resurrezione del Figlio di Dio e nel Giudizio Universale, allo scopo di sollecitare chi entrava nella Cappella a rimeditare sul suo sacrificio per la salvezza dell’umanità.
Sulle pareti laterali, sopra uno zoccolo che mostra con figure allegoriche il volto dei sette Vizi e delle sette Virtù, e sotto la suggestiva volta stellata, si succedono 38 riquadri, disposti in tre fasce di affreschi, nei quali è rappresentata la storia della salvezza, a partire dalla storia di Gioacchino e Maria.
Il racconto inizia con Gioacchino cacciato dal tempio e prosegue con andamento a spirale fino al riquadro del Giudizio Universale, in cui al centro compare ritratto lo Scrovegni mentre offre a Cristo in gloria la cappella.
Sulla parete di fronte l’Annunciazione, e al centro ancora un Cristo in Gloria, dipinto però su tavola. Un tempo era appeso nel presbiterio anche un Crocifisso di Giotto, dipinto su tavola, che però ora si trova al Museo degli Eremitani.
Infine il soffitto, completamente dipinto di blu, presenta entro tondi le immagini di Cristo tra Evangelisti e Profeti. Nel Presbiterio un pittore giottesco, intorno al 1320, ha raffigurato la Dormizione e la Glorificazione di Maria. Le due Madonne del latte sono attribuite a Giusto de’ Menabuoi.
L’opera fu ultimata in tempi molto brevi tanto che, dopo 2 soli anni di lavoro, la Cappella era tutta decorata e veniva consacrata.
Il ciclo di Giotto agli Scrovegni costituisce il più alto capolavoro del pittore e della storia dell’arte occidentale, pari solamente alla Cappella Sistina di Michelangelo in Vaticano a Roma.
Con quest’opera Giotto inizia una nuova era nella storia della pittura, superando l’astrazione formale della corrente bizantina allora dominante, per proporre forme umane più naturali e realistiche e per questo fu definito anche il primo pittore moderno.
Alla Cappella si accede, per le visite, attraverso l’entrata dei Musei Civici di Padova, in piazza Eremitani, 8.
Il biglietto di ingresso comprende, oltre alla visita della Cappella, anche la visita dei Musei, anch’essi di notevole interesse.
Un banale quanto tragico incidente!

Un banale quanto tragico incidente stradale, avvenuto nella tarda serata dello scorso venerdi 7 giugno 2013 a Poggio Imperiale, si è rivelato fatale per l’amico Paolo Preziosi.
Forse un malore o, chissà, un guasto improvviso e Paolo potrebbe aver perso il controllo della propria autovettura, finendo così in una scarpata, proprio alle porte del paese ove egli stava facendo ritorno.
Inutile ogni tentativo di soccorso: il povero Paolo è morto sul colpo.
Sono in corso gli accertamenti in merito alla dinamica dell’incidente da parte dei Carabinieri.
Paolo Preziosi, di 62 anni, aveva studiato a Torino dove aveva anche conosciuto e poi sposato sua moglie Maria; professionalmente si occupava di pubblicità con la sua azienda “Publisistem” di Poggio Imperiale, ma si dedicava anche alla vita politica e sociale a livello locale.
Era un mio vicino di casa, che conoscevo sin dall’infanzia; poi il mio trasferimento a Milano, ma è sempre rimasto tra noi un cordiale rapporto impostato sul rispetto e sulla stima reciproca, a riprova della familiarità consolidata tra le nostre rispettive famiglie di origine.
Quanti bei ricordi di un tempo lontano, che oramai sembrano risalire alla notte dei tempi: le calde serate estive poggioimperalesi, in via De Cicco, seduti “fuori al fresco” a chiacchierare; Paolo, sua sorella Lucia, i nostri rispettivi genitori e le mie sorelle, poi le rispettive mogli e cognati e, ancora, i bambini …!
Ho voluto a suo tempo testimoniare a Paolo i miei sentimenti di stima con la dedica che ho apposto di mio pugno sul libro « Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche, Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse », che gli ho donato in occasione della presentazione della mia pubblicazione a Poggio Imperiale nel 2008.
E fu felice, poi, quando gli comunicai di aver rinvenuto, tramite mia cognata Gina Palmieri, sua compagna di scuola, una foto della seconda elementare, che avevo in seguito provveduto ad inserire nella “seconda edizione” del mio suddetto libro.
Mi chiese di riprodurre una copia di quella foto su di una sua chiavetta per PC; cosa che feci con vero piacere.
Ed è con la pubblicazione su questo mio Sito/Blog www.paginedipoggio.com di quella foto che voglio ricordati e renderti omaggio, caro Paolo!
Lorenzo
Nella foto in alto è ritratta una seconda classe mista alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso presso la Scuola Elementare “E. De Amicis” di Poggio Imperiale.
Paolo Preziosi è il terzo scolaro della terza fila in alto, partendo dalla destra di chi guarda.
A Caravaggio il 581° anniversario dell’apparizione di Santa Maria del Fonte

C’eravamo già stati io e mia moglie lo scorso anno e ci siamo ritornati ancora quest’anno.
Un bel pomeriggio di sole, in questa stagione alquanto bizzarra che nelle previsioni nulla di buono prometteva, ha permesso la scorsa domenica 26 maggio lo svolgimento della bella processione all’aperto della Madonna di Caravaggio (Santa Maria del Fonte), nel giorno dell’anniversario della sua apparizione.
Apparizione avvenuta il 26 maggio 1432 proprio nel luogo ove sorge oggi il famoso Santuario.
La Madonna apparve a Giannetta, figlia di Pietro Varchi di Caravaggio (Bergamo), mentre era intenta a raccogliere erba, per consolarla dei cattivi trattamenti che da tanti anni riceveva dal marito.
E le annunziò la conversione del marito incaricandola di invitare il suo popolo alla penitenza, con la promessa che quel luogo sarebbe divenuto sorgente di grazie, simboleggiate dalla fonte miracolosa (il Sacro Fonte) sgorgata improvvisamente. E, a prova dell’autenticità dell’apparizione, la Madonna fece fiorire una verga secca.
I riti del giorno dell’anniversario dell’apparizione della Madonna di Caravaggio sono semplici ma molto toccanti.
Dopo il pontificale del mattino, le funzioni sono riprese alle 14,30 con la recita continuata del Rosario e alle 16,30 si è svolta la processione, guidata dal Vescovo di Cremona Mons. Dante Lanfranconi, con le statue di Maria e Giannetta sotto i portici del Santuario.
Alle 16,40 Mons. Lafranconi ha presieduto la memoria dell’apparizione con l’aspersione dell’assemblea con l’acqua del Sacro Fonte.
L’eccezionale sole caldo del pomeriggio che illuminava il cielo sopra Caravaggio ha consentito lo svolgimento di tutto il cerimoniale previsto in calendario, e già questo è apparso un prodigio, considerati gli acquazzoni dei giorni precedenti.
Sin dalle 14.30, quando è iniziata la recita del Rosario, la Basilica era stralcoma di pellegrini; in prima fila gli ammalati in carrozzella assistiti dalle dame e dai barellieri della sottosezione di Treviglio dell’Unitalsi.
Nel resto del grande complesso mariano era un brulicare di persone; letteralmente presa d’assalto la Cancelleria per l’acquisto di candele votive o per richieste di celebrazioni di Santa Messe.
Alle 16,00 Mons. Lafranconi, in abito corale e stola bianca, si è portato dinanzi al simulacro dell’apparizione per una breve preghiera silenziosa. Poi i volontari del Santuario hanno spinto all’esterno le statue di Maria e Giannetta.
Si è formata una lunghissima processione che ha attraversato tutti i portici del grande complesso mariano. Sembrava proprio un popolo in cammino dietro Colei che per prima e in modo mirabile ha seguito Cristo sulla via della Croce e della Risurrezione. Mezz’ora di Rosario itinerante, inframezzato dai canti proposti da una parte dell'”Unione Corale don Domenico Vecchi” diretta da don Gino Assensi e accompagnata all’organo dal maestro Giovanni Merisio. Pieni di commozione gli occhi degli anziani e dei malati in carrozzina nel vedere transitare l’imponente e soave statua di Maria a pochi passi da loro.
Conclusa la processione, clero e fedeli sono tornati in Basilica per la memoria dell’apparizione.
È stato questo certamente uno dei momenti più suggestivi dell’intera giornata, in cui ciascuno ha avuto l’opportunità di immedesimarsi nel mistero di quell’evento straordinario e di portata soprannaturale avvenuto il 26 maggio del 1432 e che, proprio lì a Caravaggio, ha scritto una storia di grazia profonda.
Mons. Lafranconi con piviale, mitra in capo e pastorale in mano ha guadagnato velocemente il presbiterio seguito da altri quattro sacerdoti in piviale: il rettore emerito don Ziglioli, l’arciprete emerito di Caravaggio Mons. Amigoni, i sacerdoti cooperatori del santuario don Bini e don Gorni.
La celebrazione si è aperta con il racconto dialogato dell’apparizione. Il popolo di Dio ha nuovamente ascoltato le richieste di Maria: l’invito alla penitenza per i molti peccati dell’umanità e alla gratitudine per i tanti doni di Dio. Quindi Mons. Lafranconi ha benedetto l’acqua del Sacro Fonte. Alle 16,53 il rettore don Assensi ha invitato ad attendere l’ora benedetta dell’apparizione: per sette minuti le centinaia di persone presenti in Basilica hanno pregato personalmente. Questo lungo tempo di silenzio è stato certamente il più toccante: tutti in attesa di poter nuovamente godere della presenza di Maria; di poter, ancora una volta, vedere il Cielo aperto sull’umanità.
Alle 17,00 in punto, ora dell’incontro prodigioso tra Maria e Giannetta, tutte le campane del Santuarioi hanno iniziato a suonare a distesa, mentre l’organista Merisio dava fiato al grande organo della Basilica.
E mentre il coro intonava l’Ave Maris Stella, il Vescovo attraversava la navata centrale aspergendo i fedeli. Gli altri quattro sacerdoti in piviale compivano lo stesso gesto nelle altre zone del sacro tempio stracolma di pellegrini e nei cortili esterni ove avevano trovato posto tutti coloro che non erano riusciti ad entrare in chiesa.
La Juventus conquista il suo 29° scudetto!

Juventus campione d’Italia 2012/2013 per il secondo anno consecutivo e con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del massimo campionato di calcio italiano.
Decisiva la vittoria di questo pomeriggio in casa, per 1-0 contro il Palermo, nella 35^ giornata di Serie A, con rete di Vidal su rigore al 14° della ripresa.
I bianconeri di Antonio Conte salgono così a 83 punti, conseguendo la matematica certezza dello scudetto.
E’ il 29° scudetto conquistato dalla Juventus nella sua storia (il 31° sul campo).
Clacson, sirene e caroselli hanno immediatamente invaso Torino ed è subito cominciata la festa con migliaia di tifosi che hanno invaso il centro della città.
In campo allo Juventus Stadium, appena terminata la partita, è stato posizionato un gigantesco drappo con lo scudetto numero 31, grande più o meno quanto quello srotolato in curva Scirea.
Per la tifoseria continua in questo modo il conteggio degli scudetti della Juventus, che tiene conto anche dei due che sono stati tolti (a tavolino) all’epoca della c.d. Calciopoli.
Dopo il tricolore della rinascita dello scorso anno, la Juventus festeggia oggi quello della conferma.
Il secondo titolo dell’era Conte.
Ora possiamo davvero ripartire, anche il Governo è fatto!

Il nuovo Governo presieduto da Enrico Letta stamattina ha incassato la fiducia anche in Senato, con 233 sì , 59 no e 18 astenuti, dopo il pieno di sì ottenuto ieri alla Camera, dove i voti sono stati 453 a favore e 153 i contrari.
21 ministri, di cui 7 donne, ed un’età media molto più bassa rispetto ai precedenti governi, a partire dal Presidente che di anni ne ha 46.
Nei prossimi giorni la nomina dei vice e dei sottosegretari.
Un Governo sostenuto dal Partito Democratico (PD), Popolo Della Libertà (PDL) e Scelta Civica (SC); il diavolo e l’acqua santa, ma forse l’unica alleanza possibile per uscire dalla fase di stallo ed affrontare i problemi del Paese, a fronte dei risultati elettorali che – di fatto – non hanno indicato un vero vincitore.
Nel discorso alle Camere, Letta ha toccato i temi più importanti che assillano oggi l’Italia e gli Italiani, offrendo ragionevoli ipotesi di soluzioni. Ci sarà la forza per conseguire risultati soddisfacenti per il bene comune? Speriamo bene!
Oggi stesso il neo Presidente Letta è partito alla volta di Berlino dalla Merkel, poi Parigi da Hollande e Bruxelles da Barroso ed in seguito a Madrid da Rajoy; un primo giro di contatti per accreditarsi a livello europeo.
Nell’incontro con la Cancelliera Angela Merkel, Enrico Letta ha fatto la seguente battuta: “Chiederò alla Cancelliera una consulenza sulla Grande Coalizione”.
Una battuta non affatto marginale o banale: vuoi vedere che Enrico Letta ha intenzione di fare veramente sul serio?
Giorgio Napolitano rieletto per la seconda volta Presidente della Repubblica Italiana

Fumata bianca!
I “Grandi Elettori” hanno eletto questo pomeriggio, a grande maggioranza, alla sesta seduta comune presso la Camera dei Deputati a Montecitorio, il 12° Presidente della Repubblica Italiana.
Si tratterebbe in verità del Presidente 11 bis, poiché è stato rieletto per un ulteriore settennato il Presidente uscente Giorgio Napolitano, 88 anni a giugno.
E’ la prima volta nella nostra storia repubblicana che un Presidente della Repubblica viene rieletto.
Ciò non è mai avvenuto prima, sebbene la nostra Carta Costituzionale non ponga al riguardo alcuna preclusione.
I “Grandi Elettori” (1.007 tra Deputati e Senatori compresi quelli “a vita” con l’aggiunta di 58 rappresentanti delle 20 Regioni – 3 per ciascuna Regione ed 1 per la Valle d’Aosta) hanno attribuito a Giorgio Napolitano 738 voti; un risultato che va ben oltre i 504 voti sufficienti per l’elezione, dopo la terza votazione, del Presidente.
Del resto, la situazione di stallo che si era venuta a creare non consentiva alternative, dopo il flop di Franco Marini, ex Segretario Generale della CISL ed ex Presidente del Senato e di Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea e due volte Presidente del Consiglio. Situazione che ha peraltro avuto un pesante strascico nella compagine del partito di maggioranza (Partito Democratico), con le dimissioni del Presidente Rosy Bondi e del Segretario Pierluigi Bersani e dell’intera Segreteria.
E, ciò, senza trascurare la grave crisi che l’Italia sta attraversando. I fallimenti delle imprese sono stati 79 nella sola giornata di ieri 19 aprile 2013 e, dall’inizio del corrente anno, sono arrivati a 4.468 [Fonte: Sole 24 Ore 20/04/2013].
Solo un Presidente “condiviso a larga maggioranza” può offrire l’opportunità di uscire dal vicolo cieco nel quale la politica italiana si è purtroppo infilata, anche alla luce dei risultati dell’ultima tornata elettorale di febbraio scorso.
Auguri Presidente!
Il dialetto “tarnuése” nel contesto della lingua napoletana!
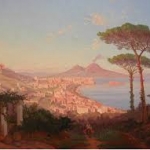
Laura Francavilla, dottoressa in Lingue e Culture moderne e attualmente laureanda specialistica in Lingue straniere per le comunicazioni internazionali all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, mi ha recentemente contattato via e-mail per mettermi al corrente del fatto che aveva avuto modo di leggere alcuni dei miei articoli, pubblicati sul sito www.paginedipoggio.com, dedicati agli ispanismi nel dialetto tarnuése e che, avendoli trovati interessanti, avrebbe voluto prenderli in considerazione come punto di riferimento per la realizzazione di uno dei capitoli della sua tesi sperimentale dedicata agli ispanismi nel dialetto napoletano, unitamente al mio libro “Ddummànne a l’acquarùle se l’acqu’è fréscijche, Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse”, Edizioni del Poggio, 2008, che sarebbe stato, allo stesso modo, menzionato nella stesura della suddetta tesi di laurea specialistica.
E, dunque, avendo la dottoressa Francavilla l’esigenza di rivolgermi alcune specifiche domande in merito al dialetto tarnuése, abbiamo concordato di realizzare – tra noi due – una colloquiale intervista sul tema.
Ne è scaturito un interessante quanto inaspettato lavoro di approfondimento, che merita senz’altro di essere portato a conoscenza dei cultori oltre che degli appassionati della materia, tant’è che abbiamo convenuto di renderlo pubblico attraverso la sua divulgazione on line.
Buona lettura!
INTERVISTA
Laura Francavilla:
Il dialetto tarnuése può essere considerato a buon diritto, degno erede della lingua (o dialetto) napoletana, da sempre ritenuta prestigiosa varietà linguistica meridionale per il suo indistinto patrimonio culturale, caratterizzato dall’influenza di molteplici culture, tra cui la cultura spagnola (e anche francese). Una sua considerazione (o un omaggio) in merito a queste due culture (napoletana e spagnola).
Lorenzo Bove:
Nel mio libro “Ddummànne a l’acquarùle se l’acqu’è fréscijche”(1) asserisco che il dialetto tarnuése risente dell’influenza di un numero considerevole di dialetti e di lingue, dovuta alla variegazione della provenienza della sua popolazione, ma che il primo posto è sicuramente riservato al dialetto o più propriamente alla lingua napoletana, non foss’altro che per la passata appartenenza del territorio al Regno di Napoli. A maggior ragione per Poggio Imperiale, ove rilevante fu lo specifico apporto del Principe Placido Imperiale (2) della Corte di Napoli e del suo entourage napoletano in tutto il processo di costituzione nel 1759 del nuovo insediamento (l’attuale comune di Poggio Imperiale, in gergo denominato “Tarranòve”, ossia terra nuova), voluto espressamente dallo stesso Don Placido Imperiale, Principe di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), divenuto proprietario il 15 febbraio 1753 del Feudo A.G.P. (Ave Gratia Plena), comprendente la già esistente città di Lesina, l’omonimo lago ed altri territori limitrofi.
E, per gli effetti conseguenti, i francesismi e gli ispanismi che avevano nel tempo influenzato la lingua napoletana sono naturalmente, e con maggior forza rispetto agli altri paesi viciniori, trasmigrati nel dialetto tarnuèse. E, con essi, alla stessa stregua, sono statitramandati ai Tarnuíse anche i relativi usi, costumi e tradizioni. Una cultura illuminata per l’epoca (3), quella manifestata dall’illustre rappresentante della Corte di Napoli, il quale, abbracciando le idee illuministe del tempo, diede inizio ad un grande esperimento di colonizzazione, offrendo gratuita ospitalità a numerose famiglie italiane e straniere. Fece disboscare una collina, denominata Coppa Montorio, situata tra Apricena e Lesina, per costruirvi una grande masseria attorniata da alcune piccole case, un oratorio rurale dedicato a San Placido con San Michele tutelare ed una palazzina per il suo amministratore; un qualcosa che aveva assunto l’aspetto di una vera e propria (moderna) azienda agricola. Vi insediò subito 15 famiglie provenienti da San Marco in Lamis, Bonefro, Portocannone, Foggia, Bari e Francavilla e, successivamente, il Principe Imperiale concordò con alcuni capifamiglia albanesi l’insediamento nel nascente paese di Poggio Imperiale di una colonia, che comunque non vi restò per molto tempo. Ed il commercio divenne fiorente in quanto i prodotti agricoli venivano trasportati a Napoli ed in altre località, grazie anche alla vicinanza del mare e del fiume Fortore. Segnali, questi, di un patrimonio culturale di alto profilo, verosimilmente conseguenza dall’influenza di molteplici culture, tra cui non possiamo escludere quelle francesi e spagnole.
Va da sé che il confronto con diverse realtà, foss’anche in regime di subordinazione a causa dell’occupazione da parte di altri stati (come avvenne per Napoli da parte dei francesi e degli spagnoli), offre comunque l’opportunità di rimettersi in discussione e guardare al di là del proprio limitato raggio d’azione, acquisendo quel quid, quella marcia in più che fa poi la differenza. E non è detto che abbiamo sempre ragione noi e che siamo noi e soltanto noi i portatori della verità. E’ proprio nel confronto con gli altri che impariamo a comprendere che “l’unione fa la forza”, come si suol dire. E questo vale anche per la cultura in generale ed è così che fioriscono le arti, le scienze ed altro ancora.
Laura Francavilla:
Nell’articolo e nel capitolo del suo testo in cui si parla in modo specifico del dialetto tarnuése, lei afferma che nonostante la naturale tendenza all’omogeneizzazione con i dialetti circostanti, il dialetto tarnuése presenta delle diversità dal parlato dei paesi viciniori (Lesina, San Nicandro Garganico, ecc.).
Tra gli ispanismi presi in considerazione nel suo libro, potrebbe scegliere pochi esempi che dimostrino la diversità?
Lorenzo Bove:
Nel mio libro sostengo che gli avvenimenti che hanno caratterizzato la costituzione del nuovo insediamento, ad opera e per volontà del Principe Placido Imperiale della Corte di Napoli, potrebbero aver “ulteriormente esaltato l’integrazione del dialetto napoletano nella parlata tarnuèse originaria, piuttosto che nei dialetti parlati negli altri paesi viciniori”.
Ed aggiungo, poi, che “ne è prova il fatto che i dialetti parlati a Lesina, Apricena, San Nicandro Garganico e San Paolo Civitate, presentano ancora oggi delle diversità rispetto al tarnuèse, nonostante la naturale tendenza all’omogeneizzazione”.
Occorre innanzitutto evidenziare che il Feudo A.G.P. (Ave Gratia Plena) aveva un suo insediamento che nel tempo si era consolidato nel territorio di giurisdizione, e ciò ancor prima di passare nella proprietà di Don Placido Imperiale. La popolazione ivi residente parlava quindi la propria lingua, frutto delle diverse trasformazioni avvenute nei secoli, fino a conformarsi con l’idioma napoletano in quanto parte Regno di Napoli; una lingua napoletana sebbene con influenze, com’è naturale che fosse, derivanti dalla stratificazione delle precedenti antiche parlate.
Il nuovo insediamento (Poggio Imperiale o Tarranòve che dir si voglia) è invece molto più recente; la sua fondazione risale solamente all’anno 1759, con una popolazione (nuova) proveniente in maggior parte dell’esterno del Feudo. E’ del tutto evidente che, su di essa, più forte si è riverberata l’influenza organizzativa ed anche lessicale del Principe Imperiale e del suo entourage napoletano, per cui la parlata che ha preso il sopravvento è stata senza dubbio quella napoletana “più pura ed attuale” (per l’epoca, s’intende). E dunque, il modo d’esprimersi tarnuèse, si svelò “un po’ più napoletano” di quello dei paesi del circondario.
E, come scrivo nel mio libro, “il napoletano si è ulteriormente affermato a Poggio Imperiale in relazione alla frequentazione dei suoi abitanti a Napoli per motivi di studi, ma anche per l’apprendimento delle arti e dei mestieri. Ragione per cui il napoletano ha cominciato con il rappresentare il modo di parlare forbito del ceto più abbiente”.
E’ dello stesso avviso anche il Prof. Alfonso Chiaromonte (4), il quale sostiene che “il napoletaneggiante puro resta la maggior parlata dialettale del comune [Poggio Imperiale, n.d.a.], perché è stato il linguaggio colto, così chiamato dal popolo, che distingueva i proprietari terrieri e i professionisti da tutto il resto della popolazione”.
Ma, francamente, stiamo parlando di due secoli e mezzo orsono; nel corso degli anni i linguaggi subiscono inevitabili mutazioni e, pertanto – come spiego anche nel mio libro – la destinazione a Poggio Imperiale di famiglie, provenienti da diverse località, “ha finito comunque con l’influenzare e dunque modificare nel tempo lo stesso dialetto napoletano”, generando in ogni caso un suo specifico idioma che caratterizza e contraddistingue, oggi, i tarnuìse rispetto agli abitanti dei paesi vicini.
Si tratta – però – di differenze riguardanti, ad esempio, un’inflessione diversa, una vocale un po’ più aperta o più chiusa pronunciata magari in maniera più lunga o più stretta oppure cantilenante, o anche una difforme cadenza (calata) nella intonazione ovvero nel lessico. Mentre i francesismi e gli ispanismi parrebbero essere uniformemente assorbiti nei diversi dialetti.
Qualche esempio:
– Cordicella => Poggio I. = Zukuléll(e) S. Nicandro G. = Zukulèdd(e)
– Lampascioni => Poggio I. = Lambascijul(e) S.Paolo C. = Vambascijl(e)
– Midollo => Poggio I. = M(e)dúll(e) Lesina = M(e)dòll(e)
– Ossa => Poggio I. = Óss(e) o anche Óss(e)r(e) Apricena = Jòss(e)
Laura Francavilla:
Una sua semplice considerazione sul futuro dei dialetti locali e nel suo caso del dialetto tarnuése.
Lorenzo Bove:
Riprendo, sempre dal mio libro, alcuni spunti.
“La tradizione consiste nel tramandare notizie, memorie e consuetudini da una generazione all’altra, attraverso l’esempio, le informazioni, le testimonianze e gli ammaestramenti orali e scritti”.
Ed ancora, “Lasciare che il tempo e l’incuria della gente permetta che le opere del passato, le gesta dei popoli antichi, gli usi e i costumi, le usanze e le tradizioni finiscano con l’essere a poco a poco coperti dalla polvere dell’oblio, fino a svanire inesorabilmente dalla mappa delle umane conoscenze, rappresenta davvero un crudele destino”.
Ebbene, i dialetti – compreso quello tarnuèse – rappresentano un patrimonio culturale inestimabile da preservare coerentemente, “non sicuramente con l’intento di erigere steccati o prefigurare divisioni – in un mondo che tende invece alla globalizzazione e dove qualsiasi forma di isolamento è da ritenere deleteria – ma, piuttosto, per valorizzare la variegazione dei dialetti come patrimonio di conoscenza e dunque come opportunità per la loro divulgazione […] soprattutto per i giovani e per le future generazioni”.
Sostiene il Prof. Giuseppe De Matteis (5) che “in tempi come i nostri, in cui l’anglicizzazione e la burocratizzazione hanno molto contaminato la lingua italiana parlata e scritta, con la triste eredità di un notevole impoverimento espressivo, il riavvicinamento al dialetto parlato e scritto […] può sicuramente rivelarsi utile per il recupero e la conservazione nei secoli futuri della creatività, della vitalità e dell’autonomia espressiva”.
Nello specifico, con riguardo al dialetto tarnuése, “ritengo, personalmente, che il culto delle tradizioni poggioimperialesi e l’amore della storia del nostro paese debbano prevalere, sempre, […] e rappresentare il vero collante nella ricerca delle nostre […] radici” (6).
Note
(1) Lorenzo Bove, “Ddummànne a l’acquarùle se l’acqu’è fréscijche, Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse”, Edizioni De Poggio, 2008.
(2) Il Principe Placido Imperiale era “Grande di Spagna di Prima Classe”, massima dignità nobiliare concessa ai fedelissimi del Re di Spagna; titolo che forniva parecchi privilegi. Era inoltre un Feudatario con tutte le sue prerogative ed amministrava il primo grado della giustizia sia civile che penale. Questo l’elenco dei suoi possedimenti: Principe della Città di Sant’Angelo dei Lombardi, Signore della Città di Nusco, e Lesina, e delle Terre dei Leoni, Andretta, Carbonara, e San Paolo, ad meno, che de Feudi inabitati di Monticchio, ed Oppido, e de’ Casali di S.Bartolomeo, S.Guglielmo, e Pontelomito, ed altri annessi, ed adjacenti alle Suddette Città, e Feudi e con l’estensione della Giurisdizione ad altre prerogative in tutto il Territorio di Sua Maestà di Ripalta (cfr. Antonietta Zangardi “Poggio Imperiale 1759 – Nuovi documenti sulle origini e sulla sua fondazione, Edizioni del Poggio, 2012).
(3) Negli ultimi decenni, a partire dal libro “Poggio Imperiale, Noterelle paesane” di Alfonso De Palma, Edizione il Richiamo, 1984, si è destato l’interesse in materia da parte di alcuni insigni poggioimperialesi, in particolare Alfonso Chiaromonte, Giovanni Saitto e Antonietta Zangardi, i quali hanno sapientemente effettuato approfondite ricerche, consentendo così di poter allargare gli orizzonti conoscitivi rispetto alle scarne e superficiali notizie esistenti precedentemente.
Interessante l’ultimo libro di Giovanni Saitto “La rivoluzione agraria di Placido Imperiale e la fondazione di Poggio Imperiale”, Natan Edizioni, 2012, un volume ricco di preziosi e inediti documenti di archivio.
Dello stesso autore, anche “Poggio Imperiale, Cento anni della sua storia: dalle origini all’unità d’Italia”, Foggia 1993; e “Poggio Imperiale, storia, usi e costumi di un paese della Capitanata”, Foggia 1997.
(4) Alfonso Chiaromonte, Dizionario del dialetto di Poggio Imperiale “U Tarnuèse”, Edizioni del Poggio, 2007, pag. 13
Dello stesso autore, anche “Da Fattoria a Poggio Imperiale”, Lucera 1997; “La Capitanata tra ottocento e novecento, Poggio Imperiale nella sua vita politica e amministrativa”, Poggio Imperiale 2002 e “Tarranòve, un ritorno alle nostre radici”, Edizioni del Poggio, 2006.
(5) Giuseppe De Matteis, Università di Pescara e Foggia, Prefazione al Dizionario del dialetto di Poggio Imperiale “U Tarnuèse” di Alfonso Chiaromonte, op. cit,, pagg. 8 e 9.
(6) Lorenzo Bove, “A proposito della fondazione di Poggio Imperiale”, Sito/Blog www.paginedipoggio.com alla pagina https://www.paginedipoggio.com/?p=3615, articolo divulgato in occasione della pubblicazione del libro “Poggio Imperiale 1759 – Nuovi documenti sulle origini e sulla sua fondazione” di Antonietta Zangardi, Edizioni del Poggio, 2012.
Habemus Papam!

A soli tredici giorni dalle dimissioni del Papa Emerito Benedetto XVI, avvenute alle ore 20,00 del 28 febbraio scorso, stasera, nel corso della seconda giornata di votazione, al quinto scrutinio segreto, i 115 Cardinali elettori riuniti nella Cappella Sistina hanno scelto il nuovo Papa.
E’ l’argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, già Arivescovo di Buenos Aires, che si è dato il nome di Francesco.
Papa Francesco: il primo Papa della storia ad assumere il nome di Francesco, il primo gesuita a diventare Papa, il primo sudamericano a San Pietro e il primo Papa extra europeo.
Sembra proprio un buon segno!
La fumata bianca alle ore 19,06 e l’annuncio dell’ Habemus Papam verso le 20,15; subito dopo il saluto di Papa Francesco alla folla dei fedeli accorsa in piazza San Pietro, alla quale ha impartito la sua prima solenne Benedizione pontificia.
Queste le prime parole del nuovo Papa: “Fratelli e sorelle buonasera, voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma e sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo alla fine del mondo…ma siamo qui”.
La gioia della gente che gremiva la piazza è divenuta incontenibile; “Francesco! Francesco!” acclamavano gli oltre centomila fedeli presenti.
La nazionalità del nuovo Papa e la scelta del nome, quello del Santo di Assisi, possono già delineare l’attenzione di Papa Bergoglio per i poveri.
“Cominciamo un cammino di fratellanza, amore, di fiducia fra noi – ha detto Papa Francesco – “Preghiamo l’uno per l’altro, per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza;Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi cominciamo sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa bella città”.
Il Conclave era iniziato soltanto ieri pomeriggio, dopo la messa del mattino “pro eligendo Pontefice” ed il preventivo giuramento dei Cardinali elettori.
