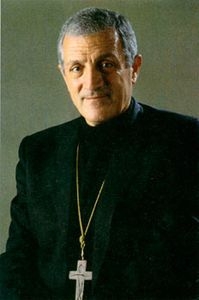IL DIALETTO “TARNUÉSE” (di Poggio Imperiale)
Il dialetto “Tarnuése” (di Poggio Imperiale) risente dell’influenza di un numero considerevole di dialetti e lingue dovuta alla variegazione della provenienza della sua popolazione.
Al primo posto viene il dialetto o “lingua napoletana”, non foss’altro che per l’appartenenza del territorio al Regno di Napoli.
Non si deve, poi, dimenticare lo specifico apporto del Principe Placido Imperiale e del suo “entourage" campano in tutto il processo di costituzione del nuovo insediamento, che ha ulteriormente esaltato l’integrazione del dialetto napoletano nella parlata “tarnuése” originaria, piuttosto che nei dialetti parlati negli altri paesi viciniori.
Ne è prova il fatto che i dialetti parlati a Lesina, Apricena, San Nicandro Garganico e San Paolo Civitate, presentano ancora oggi delle diversità rispetto al “tarnuèse”, nonostante la naturale tendenza all’omogeneizzazione.
Il “napoletano” si è ulteriormente affermato a Poggio Imperiale in relazione alle frequentazioni dei suoi abitanti a Napoli per motivi di studi, ma anche per l’apprendimento delle arti e dei mestieri.
Ragione per cui il “napoletano“ ha cominciato con il rappresentare il modo di parlare “forbito” del ceto più abbiente.
La destinazione a Poggio Imperiale di famiglie provenienti da diverse destinazioni da parte del Principe Imperiale, ha finito comunque con l’influenzare e dunque modificare nel tempo lo stesso dialetto napoletano.
Sono giunte a Poggio Imperiale famiglie provenienti dall’Albania, dalla Campania, dalla Basilicata e dalla Calabria oltre che da diversi paesi della stessa Puglia.
Già da ragazzo, mi incuriosiva la ricerca delle assonanze con il dialetto napoletano quando al “Cinema Imperiale” – una sorta di ”Nuovo Cinema Paradiso” (dal film di Giuseppe Tornatore, vincitore dell’Oscar nell’anno 1990 quale miglior film straniero, prodotto da Franco Cristalli, musiche di Ennio Morricone, Titanus Distribuzioni) – proiettavano i film di Totò, Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, Dante, Beniamino e Pupella Maggio.
Altrettanta curiosità mi destavano alcuni termini dialettali del tipo:
Accattà = comprare
Addaccià = tagliuzzare la carne
Ammarrà = chiudere, sprangare
Ammuccià = nascondere
Au mascìone = a casa
Buàtte = barattolo
Buffè = credenza
Chemò = cassettone
Retrè = divisorio
E, ciò, fintanto che non ho avuto poi modo di poter appurare che si trattava di “francesismi” che avevano in origine influenzato il dialetto napoletano e, conseguentemente, il dialetto “tarnuèse”.
Mi incuriosiva, inoltre, il fatto che i “tarnuìse” (i miei concittadini poggioimperialesi) abitualmente, nella pronuncia, non facessero molta distinzione tra la lettera “B” e la “V”.
Infatti, nomi propri di persona, come Berardo, Berardino, in dialetto "tarnuèse" venivano pronunciati rispettivamente “Velàrde” e “Velardìne”.
Così anche molti termini, aventi iniziale per “B”, che subivano la medesima sorte, come ad esempio:
Bacio = Vuàscije
Barbiere = Varevère
Barca = Vàrche
Basso = Vàscije
Basta = Avàste
Beato = Vijàte
Bilancia = Velàngele
Bosco = Vòsche
Botte = Vótte
Braccia = Vràccije
Braciere = Vrascère
Braghe = Vràche
Broccolo = Vròcchele
Boragine = Vurràijene
Borraccia = Vurràccije
Sicuramente ciò è dovuto all’influenza della lingua spagnola nel dialetto napoletano che ha a sua volta influenzato quello “tarnuèse”.
In particolare, la “B” e la “V” in spagnolo hanno, tra loro, sempre lo stesso suono, diversamente dai due corrispondenti suoni italiani che sono invece ben differenziati tra loro.
In realtà una leggera differenza di suono c’è anche nella lingua spagnola, a seconda del contesto in cui la “B” e la “V” si trovano, anche se la distinzione fonetica non risulta così marcata come nella nostra lingua.
La “b” si chiama “be” lunga o “be de buro”, la “v” invece “be” corta o “be de vaca” (pronunciata baca). In Catalogna parlano di “be” [alta] e di “be” [baixa] per “v”.
La circostanza che la pronuncia della “B” e della “V” sia identica comporta tutta una serie di problemi ortografici anche per gli stessi spagnoli.
E’ caratteristica, a questo proposito, la domanda: “¿Còme se escribe, con be o con uve”?
Peraltro la cosa rappresenta una delle maggiori difficoltà degli spagnoli nell’affrontare la lingua italiana, ove è marcata la distinzione fonetica tra la “bi” e la “vi”.
Ma l’influenza spagnola nel dialetto “tarnuèse” non si limita solo ad aspetti legati alla semplice pronuncia di alcune consonanti, ma va ben oltre. Infatti, considerevole è la presenza nel nostro dialetto “tarnuése” anche di termini di lingua spagnola.
Dal libro di Lorenzo Bove
“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche” – Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse
Edizioni del Poggio, 2008
“Dind’a ‘ndó”: la musicalità del dialetto tarnuése
Nel dialetto tarnuése, dall’unione degli avverbi “dentro” (dinde) e “dove” ("andó" o anche ‘ndó” o "addó", dallo spagnolo “donde/adonde”), si è formato “Dind’a ‘ndó” (dentro dove).
Proviamo ad assistere ad un simpatico duetto domestico ove qualcuno cerca qualcosa che non riesce a trovare.
Personaggio A:
“Pìglijme nu pòche quèlla còse”
[Prendimi per favore quella cosa…citando il nome dell’oggetto ricercato]
Personaggio B:
"Ndó stà?”
[Dov’è?]
Personaggio A:
“Dind’a lò…(buffè, chemò, ecc.)”
[E’ dentro lì…(credenza, cassettone, ecc.) vicino a te]
Personaggio B:
“Dind’a qua?”
[Proprio dentro qui?]
Personaggio A:
“Sine, dind’a lò”
[Si, proprio dentro lì]
Personaggio B:
“M’a qua ‘nge stà”
[Ma qui non c’è]
Personaggio A:
“ Allóre vide dind’a là…(a rrmàdije, u baùglije, ecc.)”
[Allora guarda in quell’altro posto…(armadio, baule, ecc.)]
Personaggio B:
"Nge sta manghe dind’a là”
[Non cè neanche là (lontano da chi parla e da chi ascolta)]
Personaggio A:
“Allóre, se ‘nge stà qua,‘nge stà lò e mànghe a là…dind’a ‘ndó stà?"
[Allora, se non è qui, non è lì e nemmeno là…dentro dove sta?]
Come si può notare “Dind’a ‘ndó” (dentro dove) possiede una musicalità assimilabile al suono di campane
<< …Din…dan…dó ! >>
Dal libro di Lorenzo Bove
“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche” – Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse
Edizioni del Poggio, 2008
QUMRAN: IL MISTERO DEI ROTOLI DEL MAR MORTO
Non poteva mancare, nell’occasione del mio viaggio in ISRAELE della primavera dello scorso anno con mia moglie, una visita a QUMRAN, in prossimità del Mar Morto, alla “scoperta” dei ROTOLI DEL MAR MORTO.
Un’avventura veramente interessante.
Il sito archeologico è ben attrezzato sia sotto il profilo del comfort che della logistica in generale.
Prima della visita vera e propria, viene proposta – in una apposita saletta dedicata – la proiezione di un filmato che ripercorre la storia di Qumran, degli “Esseni” e del ritrovamento dei famosi Rotoli.
Successivamente si passa a visitare la (ricostruzione della) grotta nella quale i Rotoli vennero effettivamente rinvenuti.
Qumran, situata ad ovest della strada Kaliah-Sodoma, a nord-ovest del Mar Morto, era abitata da Ebrei già nell’ottavo secolo a.C.
La fama di Qumram viene dagli “Esseni” che lì abitarono e studiarono nel corso di due secoli (dalla fine del periodo di Hashmonaim fino alla grande rivolta contro i romani).
Questi lasciarono nelle grotte situate nei dintorni magnifici manoscritti che conosciamo oggi come i “Rotoli del Mar Morto”
Gli “Esseni” arrivarono a Qumran verso la fine del secondo secolo a.C. e nel 31 a.C., durante il periodo Erodiano, si verificò un forte terremoto e il luogo fu abbandonato.
Circa 250 anni dopo, durante il periodo di Archelao (figlio di Erode il Grande, 4 a.C. – 6 d.C.) gli “Esseni” ritornarono a Qumran e la ricostruirono.
Nel 68 d.C. i romani conquistarono Qumran ma poi lasciarono il posto.
Le ultime tracce di abitazione risalgono al periodo della ribellione di Bar-Kochba (132-135 d.C.) quando membri del governo romano vi si insediarono nuovamente.
Allorchè anche questi ultimi lasciarono definitivamente il sito, Qumran venne complemente abbandonata e dimenticata.
Solo in epoca recente, e più precisamente nel 1947, un beduino in cerca di una pecora smarrita gettò un sasso all’interno di una grotta del luogo, colpendo casualmente alcuni antichi vasi di terracotta contenenti dei rotoli, che cominciarono poi a passare di mano senza alcuna particolare rilevanza.
Si chiamava Mohammed el-Hamed – detto “il Lupo” – l’autore della sensazionale scoperta, che avvenne in quella vallata rocciosa e inospitale nei pressi del Mar Morto, allora appartenente alla Palestina sotto mandato britannico.
Il giovane beduino udì, dopo aver lanciato il sasso, un rumore sordo, come di un vaso rotto ed il giorno dopo trovò il coraggio di inoltrarsi nella grotta e lì trovò decine di giare, alcune intere, altre spezzate contenenti rotoli scritti in lingue antiche, parole che lui non poteva comprendere.
Fu invece il Frate Roland de Vaux, venuto a sapere della scoperta, a dare inizio agli scavi nella zona dal 1951 al 1956, accompagnato da un gruppo di archeologi francesi.
Cominciò così la ricerca sull’attività degli “Esseni”.
Vennero rinvenuti altri rotoli e delle costruzioni antiche che rafforzarono la teoria che Qumran era di fatto il nucleo dell’attività “Essena”.
Le grotte sono localizzate in dirupi di difficile accesso (adatto a nascondigli per manoscritti) e le varie costruzioni servivano per i vari usi. I rotoli, trovati in vasi di terracotta, si conservarono per duemila anni (grazie al clima particolarmente arido); essi contengono brani del Vecchio Testamento, gli Apocrifi e altri scritti “Esseni”.
Una parte dei rotoli trovati sono visibili nel EICHAL HA’SEFER (museo del libro) che è parte del museo di Israele.
Gli “Esseni” erano asceti che davano grande importanza alla purità (e quindi ai bagni e alle abluzioni rituali). Conducevano vita comunitaria, ma ciò non impediva loro di costruire capanne e tende per una vita di isolamento.
Avevano sale per assemblee, refettorio, cucina comune, bagni rituali ed anche camere per lavanderia.
Non mancava infine il cimitero della comunità.
Caratteristica era la loro sala di scrittura, con tavoli e portapenne: qui gli “Esseni” evidentemente scrissero la maggior parte dei rotoli trovati nelle grotte.
I rotoli di Qumran sono pergamene scritte in aramaico, greco ed ebraico. La loro datazione viene collocata tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C.
Con ogni probabilità questi scritti di ambiente giudaico sono la migliore fonte che abbiamo per conoscere la Palestina ai tempi di Gesù.
In tutto furono scoperte 11 grotte, l’ultima nel 1956, e i frammenti rinvenuti circa 15mila appartenenti a 800-850 manoscritti.
Le autorità giordane che avevano appena guadagnato il controllo del territorio, costituirono un team di studiosi di varia nazionalità che monopolizzò lo studio dei Rotoli.
Durante tutti gli anni ’50 le migliaia di frammenti vennero ricongiunti, identificati e infine tradotti.
Nel 1967 Qumran e le terre circostanti cambiarono nuovamente di mano. Il controllo della Cisgiordania passò ad Israele e con esso anche l’intera collezione dei rotoli.
Scoppiarono diverse incomprensioni tra le autorità israeliane e alcuni membri del comitato di ricerca, la cui direzione venne interamente sostituita.
Infine l’Autorità dei Parchi Nazionali destinò il sito a Parco Archeologico aperto al pubblico.
In loco c’è un comodo parcheggio, locali di ristoro, servizi e negozietti di souvenir.
Il percorso archeologico e ben segnalato e ricco di tavole esplicative plurilingue.
La stella di Betlemme
Natale è alle porte e i convulsi preparativi che vedono coinvolti giovani, vecchi e bambini nella corsa ai regali e agli acquisti per le imminenti Festività di Fine Anno sono in dirittura d’arrivo, in un’atmosfera di consueta gaiezza e partecipazione, nonostante la crisi finanziaria ed economica che sta interessando e preoccupando il mondo intero.
Le previsioni, stando ai soloni dell’informazione, erano addirittura catastrofiche e prefiguravano un Natale senza luminarie, niente regali e tutti a casa a lume di candela.
Ma, a quanto pare, così non è!
Anche le abbondanti nevicate dei giorni scorsi fanno ben sperare per un pienone nelle località turistiche invernali e le prenotazioni di viaggi, verso le capitali europee e le altre località esotiche, sembrano mantenere il livello degli altri anni.
I centri urbani dei paesi e delle città sono festosamente illuminate di luci scintillanti e tanti alberi di Natale sono stati issati nelle piazze e nelle case, in molte delle quali offre la sua testimonianza il Presepe, con la sua grotta, i pastori, le pecorelle, i Magi, ecc.
Ma c’è un simbolo che accomuna tutte queste manifestazioni esteriori natalizie: è la “stella cometa”.
E la troviamo nelle luminarie, sugli alberi di Natale e naturalmente nei Presepi.
Ma cos’è e cosa simboleggia la “stella cometa”?
Il Vangelo di Matteo è l’unica fonte del Nuovo Testamento che parla di questo oggetto, indicandolo col nome di «stella». Il testo completo riporta che «Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo”. All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele”. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese […]. Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi» (Mt 2,1-12.16).
Quindi per “Stella di Betlemme”, impropriamente detta “stella cometa”, si intende il fenomeno astronomico che, secondo il racconto del Vangelo di Matteo, guidò i Re Magi a fare visita a Gesù appena nato.
Il fondamento storico del racconto è discusso. Storici laicisti e alcuni biblisti cristiani lo vedono come un particolare leggendario. Altri biblisti cristiani ne ammettono la veridicità, e in particolare sarebbe da identificare con una triplice congiunzione di Giove e Saturno verificatasi nel 7 a.C. Il particolare ha comunque avuto una straordinaria fortuna artistica, in particolare nelle rappresentazioni della Natività e del Presepe.
La comune denominazione di “stella cometa” risale al fatto che Giotto, a inizio XIV secolo, la disegnò appunto come una cometa, impressionato dal recente passaggio della Cometa di Halley.
Ho avuto l’opportunità di visitare con mia moglie in Terra Santa, in primavera dello sorso anno, a Betlemme, il luogo dove è nato Gesù.
Il punto preciso della “Natività” è contrassegnato da una “stella”.
Dopo i vangeli, la più antica testimonianza sul luogo della nascita di Gesù è del filosofo e martire Giustino, originario di Flavia Neapolis, odierna Nablus, in Palestina: “Al momento della nascita del bambino a Betlemme, poiché non aveva dove soggiornare in quel villaggio, Giuseppe si fermò in una grotta prossima all’abitato e, mentre si trovavano là, Maria partorì il Cristo e lo depose in una mangiatoia, dove i Magi, venuti dall’Arabia lo trovarono”.
Questa medesima grotta fu circondata dalle magnifiche costruzioni dell’imperatore Costantino e di sua madre Elena non molto dopo il 325 d. C., come narra lo storico Eusebio di Cesarea, contemporaneo ai fatti.
Nel 386, san Girolamo si stabilì nei pressi della basilica, con la nobile matrona romana Paola e altri seguaci, vivendo vita monastica, dedicandosi allo studio della Bibbia e producendo la sua celebre versione latina (Vulgata), che divenne poi ufficiale nella chiesa d’Occidente. Il suo sepolcro, così come quello dei suoi compagni e compagne, fu scavato nelle immediate vicinanze della grotta medesima.
La basilica del IV sec. fu sostituita nel VI sec. da un’altra di dimensioni maggiori, che è quella ancora oggi in piedi.
In epoca crociata (XII sec.) le pareti furono abbellite di preziosi mosaici dai fondi incrostati d’oro e di madreperla, dei quali rimangono ampi frammenti con scene del nuovo Testamento (nel transetto, con iscrizioni latine) e la rappresentazione simbolica di concili ecumenici (nella navata, con iscrizioni greche). Al di sopra delle colonne della navata in una fila di medaglioni sono raffigurati gli antenati di Gesù (con diciture latine). Uno degli angeli adoranti della parete sinistra ha ai piedi una iscrizione (in latino e in siriaco) con il nome dell’artista, il pittore Basilio.
Scavi fatti negli anni 1934-35 (dal governo mandatario inglese) hanno riportato alla luce considerevoli resti dei mosaici pavimentali della basilica costantiniana, alcuni dei quali sono visibili tanto nella navata che nel transetto della basilica.
I francescani, che dimorano a Betlemme dal 1347, posseggono accanto alla basilica della Natività il proprio convento e una chiesa (dedicata alla santa martire Caterina) che serve principalmente per le necessità della comunità cristiana cattolica locale di rito latino.
La nostra visita a Betlemme si è conclusa con un pranzo preparato da frati francescani.
La gastronomia “tarnuèse” (di Poggio Imperiale)
I piatti della tradizione paesana “tarnuèse” (di Poggio Imperiale) sono quelli tipici della cucina pugliese in generale, ma risentono molto dell’influenza molisano-abruzzese dovuta, non solo alla vicinanza del paese alla Regione Molise, ma anche agli antichi rapporti che intercorrevano tra i due popoli ai tempi della “transumanza” delle pecore dalle montagne abruzzesi alle pianure pugliesi e viceversa.
Si tratta di piatti semplici preparati per lo più con i prodotti locali che fanno esaltare la genuinità dei cibi.
All’elencazione che segue deve essere attribuito un semplice valore indicativo e non esaustivo, poichè molteplici sono i modi di preparare, a Poggio Imperiale, verdure, pesce, carne, dolci, ecc.
– U cavedélle (bruschetta condita con olio, sale ed eventuale aglio e peperoncino); una varietà particolare è rappresentata dallo scijcàtta muglijere che viene bagnato e rimesso sulla graticola;
– Pane e pemmedòre (pane, pomodoro, olio, sale e origano);
– A fellàte (antipasto di salsiccia, soppressata, prosciutto, caciocavallo, ecc.);
– Cozzel’a nere e cozzel’a bianche (cozze, vongole in tutte le salse);
– Cuchijglie (telline) crude o a zuppa (ciavedèlle de cuchijglie);
– Zuppe di pescije (zuppa di pesce preparata con i prodotti locali);
– Mulagname o scarcioffele a rrechijene (melanzane o carciofi ripieni);
– Menèstre d’anguille (zuppa di anguilla con verdure di campo selvatiche);
– Panecotte (pane raffermo cotto con verdure di campo selvatiche);
– Fave e cecorije (purea di fave secche con cicoria di campo);
– Recchijetèlle, cecatèlle, laine, past’a la chitarre, ‘ndorcele o trocchele, tagliuline (pasta fatta rigorosamente a mano: orecchiette, cavatelli, pappardelle, pasta alla chitarra, troccoli, tagliolini);
– U brudétte (è il piatto di Pasqua e si prepara con agnello o capretto, asparagi selvatici locali, formaggio e uova; alcune varietà ammettono anche cardi selvatici “carducce” e finocchi);
– U jallucce a rrechijne (è il piatto di ferragosto e si prepara imbottendo accuratamente il galletto ruspante con uova, formaggio ed interiora);
– I turcenélle arrestùte (speciali fagottini preparati con le interiora dell’agnello o capretto: il fegato con formaggio, prezzemolo, sale, aglio e peperoncino viene avvolto nella rézze con le budelline);
– I brascijole (involtini di manzo, di vitello o anche di cavallo al sugo (con peperoncino piccante) con il quale vengono conditi i piatti di pasta fatta in casa;
– U rote de patàne a u furne (la classica teglia pugliese al forno: agnello o capretto, patate, lampascioni, aglio, olio e sale);
– Sausicchije e fedacàccie (salsiccia con semi di finocchio e salsiccia di fegato preparati alla brace o anche al sugo per condire i primi piatti);
– I cardarélle (i funghi cardoncelli locali preparati con aglio, prezzemolo, olio, sale e peperoncino, alla griglia, o anche in umido o semplicemente fritti indorati;
– I cucuccèlle fritte ‘ndurate (zucchine tagliate a rondelle fritte indorate);
– I nèvele (dolci natalizi: rosette di pasta fritte o al forno e condite con mosto cotto locale);
– I cavezune (dolci natalizi: calzoni di pasta al forno con ripieno di ceci passati, mosto cotto, mandorle e cioccolato);
– I scarpélle (pasta lievitata e fritta a forma di bastoncini irregolari);
– I taralluccije (i classici tarallucci con i semi di finocchio che si consumano al naturale o bagnati nel vino rosso locale);
– I puperate (dolci di pasta lievitata al forno a forma di ciambelle; alcune varietà “puperate selvaggije” vengono preparate con l’aggiunta di cacao, cioccolato, mosto cotto, mandorle, arancia grattugiata e cannella);
– I puccellàte (dolci a forma di treccia con superfice lucida di colore simile al mogano ottenuta con lo spennellamento del tuorlo d’uovo sbattuto prima di infornarli).
I tradizionali falò dell’Immacolata a Poggio Imperiale.
Continua ancora oggi, a Poggio Imperiale, la tradizione dei falò accesi in occasione della ricorrenza dell’Immacolata, la cui origine si perde nella notte dei tempi.
L’usanza di accendere la sera della vigilia dell’Immacolata grandi falò in onore della Madonna è legata alle tradizioni popolari di un tempo quando, nei vari rioni del paese in competizione tra loro per fare il fuoco più grande, già dal pomeriggio si accumulavano e accatastavano frasche e ceppi da ardere, raccolti appositamente per l’occasione, per formarne cumuli sempre più alti, che dopo la cerimonia religiosa in chiesa venivano incendiati.
Una sorta di gara che si traduceva in uno spettacolo scintillante di luci che illuminavano l’incantevole e festosa serata che vedeva radunati intorno ai fuochi tutti gli abitanti dei vari rioni.
Prima di rincasare qualcuno ne approfittava per riempire di brace il proprio braciere da portare a casa per scaldarsi o semplicemente in segno di devozione.
I fuochi dell’Immacolata simboleggiavano, secondo alcuni, la distruzione del peccato originale ed il simbolico consumarsi del vecchio anno, con tutto il male che vi si era accumulato, ma voleva forse rappresentare anche un rito propiziatorio legato all’abbondanza della terra.
In diverse zone d’Italia la festa più importante dell’Avvento, l’Immacolata Concezione, è ricordata con l’accensione di fuochi, accompagnata in molti casi da degustazioni gastronomiche.
In Umbria, la sera dell’8 dicembre le campagne si illuminano della luce dei “focaracci”, covoni di legna ed arbusti, dati alle fiamme verso sera, per celebrare la traslazione della Casa della Vergine Maria da Nazareth a Loreto. Per questa ragione i fuochi dell’Immacolata sono detti anche “fuochi della Venuta”.
Nella tradizione popolare pugliese, invece, i falò dell’Immacolata avrebbero la funzione di asciugare i panni del Bambin Gesù. Nel barese e nel leccese, la gente assiepata intorno ai fuochi usa mangiare delle frittelle devozionali, le “pettole”, preparate con pasta di pane fritta e intinta nel miele.
A Maglie, in provincia di Lecce, l’8 di dicembre è tradizione osservare il digiuno e l’unico cibo ammesso è la “puccia”, piccola forma di pane condito con formaggio, pomodoro e olive nere, importato dai coloni greci.
Ancora il fuoco è protagonista della processione che va in scena nella notte tra il 7 e l’8 dicembre ad Atri nel teramano. I fedeli, muniti di grosse torce di canne, i cosiddetti “faugni”, raggiungono in processione la cattedrale, dove si celebra la santa messa in onore dell’Immacolata Concezione.
Il termine “faugni” è una chiara volgarizzazione di quel “fauni ignis” che ci riconduce al cuore più oscuro del paganesimo.
E, a proposito del Caravaggio, c’è la prova che Michelangelo Merisi era milanese!
Per chi avrà l’opportunità di ammirare fino al prossimo 14 dicembre a Milano la «Conversione di Saulo», l’opera del Caravaggio prestata dalla principessa Odescalchi ai milanesi ed esposta nella splendida Sala Alessi di Palazzo Marino, c’è un’interessante sorpresa: la prova che Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio è di Milano e non di Caravaggio in provincia di Bergamo.
È infatti esposto accanto al quadro (nella parte retrostante, per essere più precisi) il certificato di battesimo datato 30 settembre 1571, trovato per caso nell’Archivio Storico Diocesano di Milano da Vittorio Pirami, ex manager della Fininvest, attualmente pensionato ed appassionato di archivistica.
La scoperta risalirebbe al febbraio scorso quando, nel mentre il Pirami era intento a ricercare documenti sulla pittura fiamminga, la sua attenzione cadde su quel “Merixio”, ossia Merisi.
E, quello che gli storici hanno cercato invano per secoli, è balzato immediatamente agli occhi del Pirami, proprio come il fulmine del dipinto che ha “folgorato” Saulo (San Paolo) sulla via di Damasco.
Il battesimo sarebbe avvenuto nella parrocchia milanese di Santo Stefano in Brolo, come si evince dall’antico registro esposto, sul quale risulta annotato che «oggi 30 fu battezzato Michel Angelo, figlio del signor Fermo Merisi e della signora Lucia Aratori».
Che il Caravaggio fosse nato a Milano e non nella cittadina bergamasca, lo si sospettava già da decenni basandosi sul fatto che il padre, Fermo, era maestro di casa e architetto del marchese di Caravaggio, che abitava, per l’appunto, a Milano.
Peraltro, nel registro dei battesimi della parrocchia di Caravaggio non figura tra il 1569 e il 1585 alcun Michelangelo Merisi.
Tuttavia, una certa prudenza è naturalmente d’obbligo.
E, dunque, da parte dell’ Archivio Storico Diocesano di Milano il “documento” sarà comunque sottoposto allo studio di esperti per gli opportuni accertamenti e le verifiche necessarie. E solo a conclusione di tale verifica verranno resi noti i risultati.
Ma, nel caso in cui fosse confermata la nuova versione sul suo luogo di nascita, come si spiegherebbe il nome “Caravaggio” con cui egli è universalmente noto?
Forse, molto semplicemente con l’identificazione del luogo originario di provenienza della sua famiglia, per indicare, tra i tanti Merisi (o Morigi) lombardi, un particolare e specifico ramo.
A Milano “folgorati” dalla “Conversione di Saulo” del Caravaggio.
In mostra a Milano in questi giorni, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, la “Conversione di Saulo” (San Paolo) di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio della Collezione Odescalchi; un evento straordinario e di sicuro interesse culturale per la portata storica che esso rappresenta.
Ho avuto ieri mattina l’opportunità di ammirare, nello splendore dei magnifici affreschi della storica Sala Alessi di Palazzo Marino (sede del Comune di Milano dal 1861), l’opera del Caravaggio protetta da una particolare capsula di cristallo che ne garantisce l’«habitat» ideale e la perfetta illuminazione.
Una vera “folgorazione” trovarsi faccia a faccia con il capolavoro, unico esempio rilevante di pittura su tavola del grande maestro, che è approdata per un mese – dal 16 novembre e fino al prossimo 14 dicembre – a Milano.
E’possibile poter osservare ed ammirare da vicino non solo tutti i particolari del prezioso dipinto, tornati alla luce dopo il recente restauro di Valeria Merlini e Daniela Storti, ma vedere anche il retro della tavola in cipresso.
L’opera, di proprietà della famiglia Odescalchi, grazie al Comune di Milano e a Eni, fa così la sua seconda uscita ufficiale; la prima, nel 2006, fu a Roma in Santa Maria del Popolo, il luogo di originaria destinazione sin dalla sua nascita, ma dove non arrivò mai.
L’avventura di questo capolavoro comincia l’8 luglio 1600 quando il cardinale Tiberio Cerasi, Tesoriere Generale della Camera Apostolica, chiede a Michelangelo Merisi, arrivato da Milano a Roma otto anni prima e già artista riconosciuto, di decorare la cappella di famiglia appena acquistata in Santa Maria del Popolo. La cappella è dedicata a San Pietro e San Paolo e, su esplicita richiesta del committente, Caravaggio realizza due dipinti su tavole di cipresso che riprendono i temi dei due santi: «La Conversione di Saulo» (San Paolo ) e «La Crocifissione di Pietro».
Pochi mesi dopo, nel maggio del 1601, il cardinale Cerasi muore ed il Caravaggio completa il lavoro tenendo tuttavia i dipinti nel suo studio in attesa della fine della ristrutturazione architettonica della cappella.
Nel maggio 1605 un dipinto di San Pietro ed uno di San Paolo firmati dal Caravaggio appaiono in Santa Maria del Popolo, ma non sono quelli commissionati e neanche più dipinti su tavola, bensì su tela.
Cos’era mai successo?
Probabilmente – secondo alcuni – ci fu un ripensamento dell’artista, che dopo aver visto la cappella e l’«Assunzione» del Carracci posta sopra l’altare, decide di realizzare due opere diverse, più consone allo spazio ridotto e più in relazione con la Vergine.
Secondo altri, invece, la “Conversione di Saulo” (San Paolo) della collezione Odescalchi è stata, per anni, letta come iconografia rifiutata perché contraria agli Atti degli Apostoli che parlano di grande luce e non di apparizione di Cristo a Saulo (San Paolo).
Ebbene, nel mentre la tavola di Pietro finisce dispersa (qualcuno ha ipotizzato che una sua copia sarebbe quella del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo), la «Conversione di Saulo» (San Paolo) comincia una lunga peregrinazione che, attraverso acquisizioni e assi ereditari, la porta in Spagna, a Genova e infine nuovamente a Roma.
Se il dipinto conteneva già elementi di grande interesse formale (dalla composizione non perfettamente in linea con gli Atti degli Apostoli, agli espliciti riferimenti all’epilessia di cui Saulo (San Paolo) soffriva, la bava del cavallo, le piante medicinali), è col restauro che questo capolavoro ha svelato tutta la sua forza.
La ripulitura del dipinto ha portato alla luce l’intensità dei chiaro – scuri e soprattutto la ricchezza dei colori. L’infinita varietà dei verdi della vegetazione, dello scudo, della cintura, le piume di struzzo rosa e arancio sull’elmo del soldato, la manica di Cristo che svela riflessi violacei, l’oro nello scudo. E poi la luce quasi apocalittica che dall’alto inonda il dipinto rimbalzando sull’occhio del cavallo, sul dente appena accennato dell’angelo, sul naso del Cristo, sulla manica del soldato. Sono tornati alla luce i muscoli del braccio che impugna la lancia, i particolari del soldato in secondo piano, e il corpo di Saulo (San Paolo) che traspare perfettamente sotto la maglia.
E’ quanto ho potuto ammirare di persona in questo straordinario “incontro ravvicinato”.
L’opera, attualmente di proprietà della famiglia Odescalchi, è poco conosciuta perché è sempre stata conservata in diverse collezioni private. Si conosce di più la seconda opera, “La Conversione di San Paolo”, dipinta come si è detto dal Caravaggio nello stesso periodo e visibile a Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo.
La tavola non fu mai esposta perché era, con molta probabilità, considerata un’opera imbarazzante ai tempi dell’Inquisizione; Saulo (San Paolo) rappresentato a terra, coperto da una corazza aderente e trasparente da farlo sembrare nudo, sopra di lui il cavallo imbizzarrito trattenuto a fatica dal vecchio soldato. Ha la barba lunga e si copre gli occhi con le mani, per difendersi dalla luce emanata da Dio e, in alto, un angelo sembra che trattenga a fatica l’impeto del Cristo.
Saulo di Tarso (San Paolo), prima della conversione, era un delatore dei Romani, ma poi redento (folgorato) sulla via di Damasco, diventa personaggio chiave del Cristianesimo e pertanto è illuminato da Dio. Il gesto di coprirsi gli occhi era interpretato come un rifiuto. Per questi motivi, forse, i committenti censurarono il quadro.
E al Caravaggio non restò che ridipingere una seconda versione completamente diversa dalla prima.
Ma vi è anche una via Francigena del Sud?
La via Francigena è un itinerario che appartiene alla storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma.
Si sviluppa su di un percorso di 1.600 chilometri e a partire dal 1994 è stata dichiarata “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” assumendo, alla pari del “Camino de Santiago”, una dignità sovranazionale.
La storia narra che fu Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, recandosi a Roma in visita al Papa Giovanni XV, a segnare l’inizio del cammino, noto come Via Francigena, determinando la nascita di uno dei più importanti itinerari di pellegrinaggio.
Il pellegrinaggio a Roma, in visita alla tomba dell’apostolo Pietro, era nel Medioevo una delle tre “peregrinationes maiores” insieme a Gerusalemme in Terra Santa e a Santiago di Compostela in Spagna, al sepolcro dell’Apostolo Santiago (San Giacomo Maggiore).
I pellegrini provenienti soprattutto dalla Francia cominciarono ad entrare in Italia dal passo del Monginevro, dando così alla strada che conduceva a Roma il nome di Francigena, cioè dei francesi.
All’inizio del secondo millenio l’Europa fu particolarmente percorsa da una moltitudine di pellegrini diretti ai Luoghi Santi della religione cristiana per motivi devozionali.
Il pellegrinaggio in epoca medioevale doveva compiersi, a scopo penitenziale, prevalentemente a piedi con un tragitto di 20-25 chilometri al giorno e gli ultimi tratti venivano solitamente percorsi in ginocchio; in taluni particolari casi con il fardello di un macigno sulle spalle.
Riguardo alla via Francigena, la relazione di viaggio più antica risale al 990 ed è compiuta, come si è detto, da Sigerico – arcivescovo di Canterbury – di ritorno da Roma dove aveva ricevuto il “Pallio” dalle mani del Papa (“Pallio” derivato dal latino “pallium”, mantello di lana, è un paramento liturgico usato nella Chiesa cattolica, originariamente riservato al Papa, ma per molti secoli concesso da lui agli arcivescovi metropoliti e ai primati come simbolo della giurisdizione loro delegata dalla Santa Sede).
L’arcivescovo inglese descrisse le 79 tappe del suo itinerario verso Canterbury, annotandole in un diario dal quale si evince che la Francigena non era propriamente una via ma piuttosto un sistema viario con molte alternative.
La via Francigena rappresentava dunque la strada o meglio il fascio dei percorsi che dai paesi d’oltrelpe portava i pellegrini a Roma.
Ma sicuramente delle tre grandi direttrici del pellegrinaggio medioevale, il “pasagium ultramarinum” per raggiungere la Terra Santa rappresentava il viaggio più avventuroso e pericoloso, forse anche rispetto al “Camino de Santiago” che dai Pirenei conduceva alla punta più avanzata della penisola Iberica.
Per andare in Terra Santa bisognava percorrere in senso trasversale l’Italia a sud di Roma fino ai porti pugliesi di Brindisi e di Otranto, ma anche a quelli di Manfredonia e di Bari, che consentivano l’imbarco per il Libano e per la Palestina.
I pellegrini, usciti da Roma, si incamminavano quindi lungo percorsi che conducevano verso la Puglia ed il Gargano in particolare.
Di queste strade ci parla il libro “Roma-Gerusalemme. Lungo le Vie Francigene del Sud” recentemente pubblicato dall’Associazione “Civita”.
La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto promosso dalla medesima Associazione “Civita” e reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno finanziario di Banco di Napoli e Finmeccanica.
L’opera, presentata in occasione di uno specifico convegno svoltosi a Napoli il 4 luglio 2008, offre una ricostruzione storica, artistica e religiosa degli itinerari di pellegrinaggio nel Meridione che conducevano nel Medioevo i pellegrini verso i porti pugliesi di imbarco per la Terra Santa.
Capua era per tutti il punto di raccolta e da qui ci si immetteva nella via Appia Traiana, la grande strada imperiale che portava a Benevento.
Dopo Benevento la direttrice si divideva in tre direzioni.
Sono le cosiddette vie dell’Angelo, i percorsi che, attraverso i valichi dell’Appennino, conducono tutti al Santuario di San Michele Arcangelo.
Oggi si va nel Gargano per pregare sulla tomba di San Pio da Pietrelcina, mentre nel Medioevo ci si andava per sostare nel luogo dell’Arcangelo.
Tanto i Crociati prima di salire sulle navi che da Manfredonia e da Bari, da Brindisi e da Otranto li avrebbero portati in Terra Santa, quanto i pellegrini che si preparavano al “pasagium ultramarinum”, si fermavano in vetta al Gargano.
Fin quassù salivano in preghiera, prima della guerra, i duchi lombardi, gli strateghi bizantini, i conti franchi ed i baroni tedeschi. Perché tutta la Cristianità sapeva che al termine dell’Italia, in cima a una montagna alta sul mare come la prua di una nave gigantesca, c’era il tempio dell’Angelo Guerriero.
Il Santuario di San Michele Arcangelo di fondazione antichissima (fra V e VI secolo) esiste ancora ed è la principale attrattiva della cittadina che da lui prende il nome (Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia).
Entrando in chiesa, una porta in bronzo divisa in dodici pannelli intarsiati e decorati d’argento e di rame lascia il visitatore stupito e ammirato. Detta porta, commissionata nel 1076 a una bottega di Costantinopoli, è uno dei capolavori assoluti dell’arte bizantina nel suo momento più alto.
Qualcosa di emozionante prova il turista di oggi quando scende nella grotta dell’Arcangelo che si trova nel cuore della basilica.
Fuori dal Santuario, in cima al promontorio roccioso del Gargano, con il verde Adriatico di fronte e tutto intorno un deserto aspro e bellissimo di rocce, di pascoli, di boschi, il viaggiatore di oggi come il viandante di un tempo capisce che questo è veramente “finis terrae”, l’ultimo avamposto dell’Europa cristiana.
Questa è la via Francigena del sud: la strada dei pellegrini, la via della fede e della speranza.
Note:
– Le foto (l.b.) riguardano due vedute di Monte Sant’Angelo scattate lo scorso mese di ottobre;
– Alcuni spunti sono tratti dall’articolo di Antonio Paolucci pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 31 agosto 2008, Arte/Itinerari d’arte “Via Francigena del Sud”.
Rassegna della MicroEditoria Italiana
Nello splendido scenario della Villa Mazzotti di Chiari in provincia di Brescia, si è svolta nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2008 la sesta edizione della Rassegna della “MicroEditoria Italiana”.
100 gli editori presenti con i loro “stand” alla manifestazione, tra cui le EDIZIONI DEL POGGIO www.edizionidelpoggio.it del Dott. Giuseppe Tozzi di Poggio Imperiale (Foggia), già presente anche al PISA BOOK FESTIVAL di Pisa ed all’ESPONILIBRO di Reggio Calabria dello scorso mese di ottobre.
Tanti i libri esposti e numerosa la partecipazione del pubblico nelle tre giornate dense di convegni, dibattiti ed eventi culturali connessi alla manifestazione, alla presenza di editori, autori e vari distributori.

L’associazione culturale "L’Impronta" e il Comune di Chiari, con il patrocinio della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia e del Senato della Repubblica, hanno voluto promuovere la rassegna per valorizzare la produzione della piccola editoria italiana e perche’ il pubblico abbia l’opportunita’ di conoscere questa realta’ attraverso i volti dei suoi protagonisti.

Per gli organizzatori della rassegna, giunta alla sua sesta edizione, “MicroEditoria Italiana” identifica quel mondo vivace e stimolante di chi fa l’editore per passione, dedicando ad ogni edizione impegno e tempo senza misura. Editori micro, ovvero piccoli, per l’entita’ della loro produzione, ma grandi per la qualita’ dei loro prodotti e per l’entusiasmo del loro lavoro.