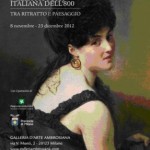Category Archives: Blog
Gruppo “Amici di Tarranòve” della Lombardia, Natale 2012

Il Gruppo “Amici di Tarranòve” della Lombardia si è incontrato anche quest’anno, nell’imminenza delle Festività Natalizie, per trascorrere insieme, come di consueto, una festosa giornata in compagnia e, come sempre, all’insegna dell’amicizia.
Il “motto” di questa tornata, coniato liberamente dagli organizzatori (gli straordinari coniugi Angela Fusco e Giuseppe Castellano) è stato il seguente: “Tutt(e) quill(e) d(e) Tarranòv(e): Chiù sim(e) e megl’ijè” che, tradotto in lingua italiana, significa semplicemente: “Sono invitati al nostro incontro tutti i poggioimperialesi che gravitano nei dintorni (siamo in Lombardia), per stare insieme in piacevole compagnia e, dunque, più persone aderiranno all’invito e più gioiosa sarà l’atmosfera”.
E, senza alcuna retorica … veramente gioiosa si è poi rivelata l’atmosfera della giornata di domenica 2 dicembre 2012 trascorsa insieme, nel mentre echeggiavano ricordi, proverbi, modi di dire, usi, costumi e tradizioni della nostra terra di origine.
Poggio Imperiale, la nostra cara “Tarranòve”!
E, anche quest’anno, la grande tavolata al Ristorante dell’Agriturismo “Molino di Santa Marta” di Casterno, nei pressi di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano.
Alcune coppie sono state impossibilitate a partecipare (assenti giustificate!), ma con – sommo piacere – si è registrata la presenza di qualche nuova coppia, che si è aggiunta al gruppo.
Molto bene, soprattutto se si considera che si tratta di coppie giovani e con bambini in tenera età.
Il pranzo è durato fino a sera e, dopo le foto di gruppo, i saluti, gli abbracci e gli Auguri di Buon Natale …. tutti a casa, con un arrivederci …. alla prossima!
Qualche cenno sulla località dell’incontro.
Agriturismo Molino Santa Marta
Casterno di Robecco Sul Naviglio (Milano)
L’Agriturismo Molino Santa Marta, immerso nel Parco del Ticino, offre, in un ambiente tranquillo e rilassante, piatti tipici della tradizione culinaria locale. La cucina dell’Agriturismo Molino Santa Marta utilizza ingredienti genuini di provenienza aziendale della famiglia Cairati, che da sempre opera con passione nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento e della ristorazione. Le ricette classiche, le carni dei loro allevamenti, la selvaggina, i dolci, vengono proposti dallo Chef con creatività e fantasia. Le sale ristorante sono particolarmente adatte per banchetti, matrimoni, e cerimonie in genere.
Il Ristorante si compone di due sale, al piano terra la sala “Il Molino”, al piano superiore la sala “Panoramica”.
Riassunto della puntata precedente (9 dicembre 2011)
L’articolo integrale, con relative foto a colori, è visibile su questo stesso sito www.paginedipoggio.com (mese: dicembre 2011).
Il Gruppo “Amici di Tarranòve” della Lombardia
9 dicembre 2011 Lorenzo Blog Edit
Sito/Blog www.paginedipoggio.com pagina https://www.paginedipoggio.com/?p=3020
Abbiamo cominciato qualche anno fa con la promessa di vederci … su a Milano … al rientro dopo le vacanze, magari per una pizza, e pian piano, con il passare del tempo, gli incontri sono divenuti un appuntamento rituale ed il gruppo diventa sempre più numeroso.
Anche quest’anno ci siamo incontrati per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia.
Domenica scorsa 4 dicembre 2011, appuntamento alle ore 12,30 davanti casa del nostro carissimo compaesano Giuseppe Castellano che, unitamente alla gentile consorte Angela Fusco, rappresentano il punto di riferimento organizzativo degli incontri.
Sono loro che mantengono i contatti e si incaricano delle prenotazioni e di quant’altro necessario per la buona riuscita degli appuntamenti.
E poi, una bella colonna di macchine verso l’Agriturismo “Molino di Santa Marta” di Casterno, nei pressi di Robecco sul Naviglio, per il pranzo.
Chi siamo?
Siamo un gruppo di poggioimperialesi (in stretto dialetto: “tarnuise”) residenti in Lombardia.
Non abbiamo ancora uno “statuto” formale, ma possono far parte del Gruppo “Amici di Tarranòve” soggetti rigorosamente nativi di Poggio Imperiale (“Tarranove”) con rispettive/vi consorti ed eventuale prole, anche se di altra provenienza.
Negli incontri si deve parlare prevalentemente in dialetto poggioimperialese (“tarnuese”) e mettere a fattor comune, per quanto possibile, storie, usanze, proverbi, modi di dire, ricette di piatti tipici e di dolci del nostro paese di origine.
Il pranzo è durato fino a sera e, dopo le foto di gruppo, tutti in macchina per Magenta per finire con un giro fra le bancarelle del “Mercatino di Natale” e con un … arrivederci alla prossima!!!!
Nota: nel dialetto di Poggio Imperiale la vocale “e” finale di sillaba o di parola è muta, se non accentata.
“Poggio Imperiale Anno 1759”

Antonietta Zangardi risponde ad alcune domande sul suo ultimo libro.
La foto storica riportata a fianco, risalente all’anno 1930, ritrae il vecchio monumento dedicato al Principe Placido Imperiale, un tempo collocato al centro della piazza Imperiale del comune di Poggio Imperiale.
Sotto il busto del Principe è ben visibile una lapide commemorativa, di cui si è oggi persa ogni traccia.
“Ogni pensiero o atto di cui s’è persa la traccia, è perduto per la storia, come se non fosse mai esistito”.
Personalmente, trovo questo aforisma di Charles Seignobos (storico francese, 1854 -1942) di una profondità immensa, soprattutto se lo si coniuga con un altro interessante e significativo aforisma del medesimo storico, del seguente tenore: “Non vi è nulla che possa surrogare i documenti: niente documenti, niente storia”.
E , da ciò, ritengo possibile poter agevolmente dedurre che, nella ricerca storica, non vi è nulla di più importante dei documenti … e della memoria.
Buona lettura!
(l.b.)
INTERVISTA
Riportiamo un’intervista fatta alla prof.ssa Antonietta Zangardi autrice del libro: Poggio Imperiale Anno 1759, pubblicato nel mese di maggio 2012 per i tipi delle Edizioni del Poggio. Dopo una attenta lettura le ha rivolto alcune domande un suo ex alunno, il dott. Pasquale Guidone, laureato ed abilitato in Psicologia clinica alla Sapienza di Roma, ha conseguito alla Pontificia Università Gregoriana la Licenza in Filosofia e la Laurea in Teologia morale. Attualmente sta conseguendo il dottorato in Teologia presso l’Università Pontificia “Regina Angelorum” di Roma ed è 1° Maresciallo presso il Ministero della Difesa.
My Prof. Le voglio rivolgere alcune domande sul suo libro.
1. Cosa l’ha spinta, Professoressa Zangardi, a scrivere questo libro su Poggio Imperiale? D’altronde già ne avevamo altri in cartolibreria? (Così credo pensano in molti, anche se la cosa non centra niente)
Nella pagina 92 del libro non capisco bene se dall’articolo di quel giornalista Ella avesse già appreso la notizia di una nuova data o altro.
R. Non avevo intenzione di scrivere un libro su Poggio Imperiale, anche perché vi sono altre pubblicazioni, che conosco molto bene in quanto in alcune ho collaborato alla stesura e sono stata relatrice nelle presentazioni. Però, nel 2011 si organizzarono a Poggio Imperiale i festeggiamenti per i 250 anni, partendo dal 1761, una data di fondazione superata già dal 1979, quando l’archivista Beniamino Gabriele pubblicò sul giornale “Gargano nuovo” (alle pagine 92 e 96 del mio libro si può vedere una copia del giornale) un articolo su di un documento particolare: la visita pastorale che il vescovo di Lucera, mons. Giuseppe Maria Foschi fece alla chiesa di Poggio Imperiale nella primavera del 1761. Nella copia di questa relazione apprendiamo molte notizie sul nostro paese, anche sugli albanesi che, come meteore passarono nel nostro territorio. Sarebbe bastato far riferimento solo a questo documento e la fantomatica festa poteva essere fatta come anniversario del Patto del Principe con gli albanesi, singolare perché ritroviamo un principe illuminato benevolo e generoso. Avendo insegnato Storia per un trentennio nel nostro paese, sono intervenuta nel dibattito che si era stabilito, facendo riferimento ad un mio articolo sui documenti della nostra storia, pubblicato su “Capitanata.it”il 3 gennaio 2011. Non potevo farmi fermare dalla scortesia, che è sempre di casa in chi vuole avere ragione a tutti i costi, e dall’arroganza di chi crede di “fare Storia” pur non possedendone le dovute qualifiche, scambiando la” verità dei documenti” per “zizzania”. Chi mi conosce sa che nelle cose in cui credo sono sempre stata tenace e combattiva, ecco perché ci ho tenuto a precisare che alcuni studi o tesi di laurea erano stati fatti in quanto io personalmente avevo passato l’articolo del dott. Gabriele a don Nannino, nostro compianto Parroco. Malgrado studi e tesi di laurea il documento fu declassato ed ignorato.
Per avvalorare la tesi della fondazione nell’anno 1759, iniziammo la ricerca di altri documenti ma, non potevo assolutamente nascondermi dietro nessuno: toccava a me rispondere agli attacchi del chiacchiericcio pseudo politico di chi pretendeva di sapere tutto e toccava a me quindi scrivere il libro su documenti vecchi e nuovi. Le fruttuose ricerche hanno avvalorato la tesi che gli albanesi, arrivati col famoso patto del Principe Placido Imperiale del 1761, avevano trovato già impiantato un nucleo urbano e che, quindi non sono stati gli artefici della fondazione.
Cosa singolare è che nei documenti da me pubblicati ritroviamo non solo “il principe illuminato, benefattore, nato per il bene del genere umano” ma anche “il feudatario” che doveva trarre profitti dalle sue terre. Non era mia intenzione fare l’apologia del Principe o continuare a scrivere la solita “favola del principe”, ma dovevo descrivere territorio e società dell’epoca attraverso i documenti ricercati negli Archivi. Molto particolari ed interessanti sono i nuovi documenti sulla vicina Lesina.
In quanto poi al fatto che vi sono altre pubblicazioni, è giusto che sia così e penso che bisogna continuare a scrivere in quanto la storia non finisce con gli ultimi documenti studiati. Se ne troviamo altri, utili a modificare o ampliare le nostre conoscenze, ben vengano! Tutti possiamo scrivere e, vista da più angolazioni, la storia si arricchisce a seconda della nostra cultura e della nostra conoscenza, perché quando noi scriviamo vengono fuori subito le nostre abilità costruite con lo studio e l’impegno. Essere appassionati significa innanzitutto studiare. E tu che lavori e studi sai quanti sacrifici comporta questa scelta. In fondo sappiamo che la memoria è una dote, prima di essere il nostro futuro noi siamo il nostro passato, sia come persone che come società.
2. Qual è stato quindi l’obbiettivo prioritario del suo lavoro?
R. Obiettivo prioritario del mio lavoro è stato quello di individuare la data di fondazione di Poggio Imperiale, partendo dalle origini, quindi dall’acquisto del feudo di Lesina nel 1751. Ho riportato il contesto storico in cui si inseriva la fondazione del nostro paese ed ho descritto come era il territorio in quell’anno:
– a Napoli, Carlo III di Borbone e il suo riformismo illuminato;
– a Foggia la ripresa economica e il fervore di ricostruzione nelle attività dopo il terremoto del 1731.
All’atto di compravendita con cui il Ceto dei Creditori dell’A.G.P. cedeva il feudo di Lesina, nell’ambito del quale sorgerà Poggio Imperiale, era allegata la splendida relazione, un apprezzo compilato dal tavolario Donato Gallarano, il 4 ottobre 1730. In essa viene descritto il territorio del feudo e gli abitanti.
Nei nuovi documenti da me pubblicati, il territorio è descritto dal notaio Giuseppe Nicola Ricci di Torremaggiore quando riporta la presa di possesso del feudo da parte di don Baldassarre Stabile, governatore generale rappresentante del Principe. Partire da due documenti che descrivono il territorio, uno già conosciuto e studiato (la perizia Gallarano), l’altro un nuovo documento (la presa di possesso del Governatore Generale) significa immettersi nel vivo della storia. E poi sappiamo che nella Storia un anno non vale l’altro e anche solo due anni sono importanti, e gli albanesi non c’entrano nulla con la fondazione di Poggio Imperiale, non lo dico io, ma i documenti. Nel 1759 Carlo III di Borbone lasciò Napoli per la Spagna ed il potere passò al figlio, troppo piccolo per governare. Quante cose cambiarono in due anni!!! Bisognerebbe armarsi di umiltà e saper dire di aver preso un abbaglio e farsi promotore di una rettifica!
3. Mi incuriosisce, Professoressa, il fatto che in merito al cognome Imperiale lei abbia optato per Imperiale in luogo di Imperiali …, lo ha dedotto in base al numero di volte in cui compare maggiormente Imperiale rispetto ad Imperiali?
E che dire, come Lei sostiene, che dalla firma dello stesso principe compare “i”? Non è forse più rilevante la “i”?
R. I documenti riportano indifferentemente sia Imperiale che Imperiali. Nella firma del Principe leggiamo “Imperiali”, ma il nostro paese è “Poggio Imperiale”, quindi ho concluso con un discorso grammaticale, in quanto essendo il sostantivo “poggio” maschile singolare, era ovvio concordarlo con “ Imperiale”.
4. Cosa emerge dunque dai settantadue nuovi documenti?
R. Secondo i settantadue nuovi documenti d’archivio studiati nella pubblicazione si ribadisce l’anno fondamentale per la storia di Poggio Imperiale, il 1759, quando, insieme alle “caselle” si costruì la Chiesa ad opera dei mastri foggiani Leonardo e Francesco Saverio Romito, famosi per aver ricostruito Palazzo Dogana a Foggia, oggi sede della Provincia.
Avevo già da parecchi anni una copia del documento di Antonio Scarella richiesta all’Archivio di Stato di Napoli, secondo il quale il Principe era nel nostro territorio nella S. Pasqua del 1759. Poi la ricerca di archivio ha fatto il resto. Ci si fa prendere dalla novità dei documenti e ci si “ammala” di ricerca. Auguro a tutti i giovani di essere infettati da questa “malattia” della ricerca storica. Ti puoi spiegare anche il perché ho voluto inserire nella pubblicazione la tecnica che ho seguito nel “fare ricerca”. Invito i giovani ad amare gli Archivi e a rispettarli, perché non si deve mai fare ricerca saccheggiando la memoria storica.
5. Il libro, nella sua esposizione, e nel primo impatto di lettura sembra avere un carattere esortativo a prendere coscienza della correttezza delle informazioni. Ritengo la cosa utile e doverosa giacché si tratta del nostro paese ed anche per un atto di carità nei confronti del pubblico, dei posteri e in onore della storia. Ma Ella cosa si aspetterebbe dai lettori del nostro amato paese?
Prima di tutto mi aspetterei che prendessero coscienza del nostro passato e si organizzassero a ripulire il paese dai “falsi della storia”, cioè da quei messaggi fuorvianti come:
– il cartellone nella Chiesa che illustra la storia, scritta da chi non ha avuto l’umiltà di chiederne le vere notizie o di leggere le pubblicazioni scientifiche;
– rimuovere il cippo in via Foggia, o almeno modificarlo sottolineando che la data del 18 gennaio 1761 si riferisce al Patto che il Principe stipulò con gli Albanesi ed i 250 anni si riferiscono a questo avvenimento storico, che poche ripercussioni ebbe per la storia della nostra comunità ;
– aggiungere alla via 18 gennaio la dicitura “patto con gli albanesi”;
– ricordare le date fondamentali della nostra storia nella toponomastica;
– dedicare una via, perché no, al Principe Placido Imperiale.
Devi sapere che alcune vie storiche sono state ripristinate nel 1993 dietro mia specifica sollecitazione.
I documenti studiati nel mio lavoro ci descrivono come e chi eravamo e noi dobbiamo avere il coraggio di ricordarlo per non perdere di vista le qualità dei nostri antenati e bisogna farlo ora, proprio in questo momento storico che vive di rimozioni, perché non possiamo sederci sul nostro passato senza comprenderlo e senza ritrovare le giuste motivazioni per organizzare il nostro futuro.
Nel mio libro rendo protagonisti assieme al Principe anche tutte le maestranze, che, con le loro opere e la loro attività, hanno permesso la formazione della colonia agricola.
Il personaggio – chiave del nostro lavoro è senz’altro il principe di Sant’Angelo, che con la sua formazione umana e culturale ed il suo spirito pragmatico ha voluto mettere in atto ciò che a Napoli era in teoria, cioè la formazione di una colonia agricola che rispecchiasse i canoni e le teorie economiche proprie dell’illuminismo.
Ma ho voluto presentare tutti i protagonisti della piramide feudale formata da pochi patrizi, agenti feudali, notai, governatori generali ( i documenti ci presentano le nomine di quattro governatori dal 1751 al 1765, anni della nostra ricerca, aventi facoltà di amministrare la giustizia col potere di vita e di morte sui sudditi, “mero mixtoque imperio et potestate gladii” ).
Alla base della piramide la massa di lavoratori che chiedevano lavoro ed elemosinavano diritti, una microstoria silenziosa, artefice della fondazione di Poggio Imperiale e che nella foga del racconto storico spesso dimentichiamo di presentare.
6. Mi incuriosisce anche sapere come ha fatto a raccogliere così tante notizie quali fonti dirette delle fasi di inizio della fondazione. Credo sia stato “un lavorone”. Sarebbe gratificante sapere quali azioni ha compiuto, dove si è recata, come si è mossa, insomma. Perché ritengo che solo un atto di amore verso il suo paese, di carità verso i suoi compaesani e di precisione verso i dati storici la possano aver stimolata! Insomma io ritengo che Ella vada ringraziata giacché ha fornito a tutti la possibilità di avere sottomano le citazioni sulle nostre origini e non è poco e credo che anche altri dovrebbero ringraziarla. La cosa andrebbe “immortalata” istituzionalmente dal Comune del paese e non so come … e resa pubblica ad ogni costo.
Ti ringrazio per la comprensione. Il lavoro è stato oneroso, pensa che non ho pubblicato tutti i documenti in mio possesso. La ricerca è stata effettuata negli archivi di Stato: nell’Archivio di Stato di Napoli, in quello Notarile e in quello Storico del Banco di Napoli. Poi nella sezione dell’archivio di Stato a Lucera. Nel mio libro faccio riferimento a tutti gli archivi visitati e nelle prime pagine ringrazio i miei collaboratori, anche perché non potevo affrontare da sola una ricerca così variegata. I documenti sono stati da me trascritti e commentati uno per uno in uno studio analitico e di comparazione. Il lavoro di ricerca è durato un anno e mezzo, senza contare i documenti che avevo studiato in precedenza, per passione.
Sono stati preferiti i documenti d’archivio, anche se non disdegno le biblioteche che sono luoghi di ricerca e di cultura di cui non possiamo fare a meno. Ho voluto pubblicare la trascrizione dei documenti perché il lettore potesse leggere gli avvenimenti dalle fonti dirette e nello stesso tempo fornire ai giovani ricercatori il materiale per le loro ricerche.
Conoscere da dove veniamo e chi eravamo è un modo per migliorare la nostra vita.
Questa pubblicazione, non mi vergogno di dire, è un atto d’amore verso un paese che sta andando alla deriva ed è votato al degrado. Ecco perché gli Archivi storici ci sono serviti per sottolineare l’importanza di essere cittadini di un paese le cui origini e la cui storia è legata a quella di tanti paesi del circondario e i cui primi abitanti portavano cultura, modi di pensare e di agire diversi, eppure stavano insieme, si aiutavano e si organizzavano. La maggior parte delle maestranze e degli affittuari per “disboscare e smacchiare” il territorio erano di S. Severo, e la “Valle di S. Severo” nella posta di “tre valli” era il luogo dove poi sarebbe sorta Poggio Imperiale.
Ricordare le qualità dei nostri antenati significa ripartire e riacquistare ciò che abbiamo perduto col passare del tempo.
Il suo lavoro, prof.ssa Zangardi, è diventato punto di partenza imprescindibile per ogni futura ricerca su Poggio Imperiale e modello da imitare per fare ricerca storica. In realtà anche io sono appassionato di storia ed ho in mente un metodo – per ora tutto mio – con cui procedere che non trascura ovviamente le fonti ma che tiene anche conto della centralità dell’uomo con tutte le sue dimensioni, opportunità questa che anche la S.V. ha ribadito a pag. 34 del suo testo.
Infatti Ella ha accennato oltre alle vicende storiche, anche alla possibile personalità del principe Imperiale come si andava esprimendo negli affari amministrativi della nostra terra e non ha dimenticato neppure la popolazione generale, i campagnoli che si rivolgevano al principe con “suppliche” per ottenere favori economici. Questo mi fa pensare a un collegamento con le nostre abitudini ormai tramontate di rivolgerci a signori benestanti o laureati di Poggio Imperiale anteponendo il “don” davanti al nome. Oggi un medico non è più un giudice insindacabile che cura poveri ignoranti; egli invece è uno dei tanti professionisti; oggi il medico o l’avvocato o il professore sono contestati nelle loro decisioni se non trasparenti con l’appellarsi ai propri diritti da parte del paziente, del cliente o dello studente, e, con le conoscenze adeguate anche di altre discipline, si può controllare/criticare la posizione e l’operato del medico o di altre persone un tempo considerate “signori” verso le quali ci si rivolgeva con il “don”.
Tra i vari interessi che coltivo da anni, mi è sempre piaciuto studiare tutto quanto è occorso da Adamo ed Eva (o dalla preistoria), ai giorni nostri, fino alle origini di Poggio Imperiale. Come lei dice, noi siamo prima di tutto il nostro passato. Io considero infatti la conoscenza storica e quella del mio paese in particolare quasi un altro tipo di “utero materno” in cui sono stato concepito, che mi restituisce la conoscenza delle mie radici e pertanto parte della mia identità.
In questo senso il suo libro rappresenta per me un primo “anello” di concatenazione tra il passato e il mio presente, giacché ho in mente di coltivare proprio l’acquisizione di una conoscenza storica di questo tipo cioè di una conoscenza che tenga conto non solo ad esempio di avvenimenti come le guerre mondiali ma anche del modo in cui tra le due grandi guerre si è sviluppata la filosofia dell’esistenzialismo con grandi personaggi quali Heideger, Sartre, ecc. Per cui è necessario dare uno sguardo all’arte del tempo, alle opere letterarie, ai monumenti, alle testimonianze di ogni genere. Cercare anche per esempio di inquadrare il temperamento di Hitler attraverso le fasi decisionali che determinarono lo scatenamento della seconda guerra, ecc. ecc..
Ella con il suo libro mi è venuta incontro donandomi un anello mancante al processo di ricostruzione storica che sto tentando più prossimo al mio ambiente, quello del mio paese, per questo la ringrazio.
La studio della storia non deve essere per così dire “statico” cioè mera ripetizione di eventi, di date senza poi avere la capacità e la gioia di intuire i collegamenti con le opere letterarie, il pensiero, le ideologie e perfino fare una critica storica. Credo.
Ti devo ringraziare per la passione che hai profuso nella lettura della mia pubblicazione: “Poggio Imperiale Anno 1759”. Voglio ricordare la casa editrice “Edizioni del Poggio”, sita a Poggio Imperiale e voglio ringraziare anche l’editore Giuseppe Tozzi che ha creduto nel lavoro svolto e mi ha incoraggiato nei momenti più faticosi. Voglio ribadire che bisogna sempre mettere a disposizione della comunità i propri studi. Nel mio libro invito i giovani a studiare e sono contenta che persone come te che con tenacia si impegnano e mettono in atto questo consiglio. In trentotto anni di insegnamento, di cui trenta nel mio paese, posso orgogliosamente affermare che ho tanti ex alunni lettori e studiosi che lavorano e sono ben inseriti nella nostra società, (certo qualcuno mi sarà pur “venuto male”, purtroppo). A questo proposito voglio ringraziare anche il giovane professore, mio ex alunno, esperto e studioso della storia del nostro territorio, Salvatore Primiano Cavallo, il quale vanta numerose pubblicazioni specialmente sulla sua Lesina, che in una sua mail mi ringrazia per aver posto fine “alla bagarre piena di insipienti toni campanilistici”, lo ringrazio per aver apprezzato il mio lavoro d’archivio, (e lui è un esperto di archivi) dove i documenti fanno la storia e non le opinioni. Il guaio del nostro paese è che abbiamo ipotecato il futuro permettendo a tanti giovani di andar via, ma è il destino di tutti i piccoli paesi del sud Italia. Le nuove tecnologie ci permettono di restare in contatto e comunicare le nostre conoscenze e i nostri studi.
A te Lino, auguro di attuare i tuoi progetti di vita e di essere sempre orgoglioso delle tue radici. Ho risposto con piacere alle tue domande. Spero d’essere stata esaustiva. Sentirsi “terranovesi” deve essere sempre un onore, pur riconoscendo i limiti e gli errori che, come persone umane possiamo commettere. Ritrovare le proprie radici significa, però rispettare sempre quelle degli altri.
Dopo il dottorato, ad maiora nunc et semper!!!
A Pasquale Guidone da Antonietta Zangardi
A Milano, la donna nella pittura italiana dell’800

Il capoluogo lombardo dedica una mostra alla “donna” nella pittura italiana dell’Ottocento.
Il percorso dell’interessante rassegna allestita a Milano, dall’8 novembre al 23 dicembre 2012, si snoda in due distinti ambiti, il primo riferito al periodo che va “Dalla Scapigliatura alla Belle Epoque” e l’altro che riguarda aspetti pittorici che si profilano “Tra ritratto e paesaggio”, con la “donna” sempre in primo piano.
La centralità della rassegna è dunque la “donna”; un omaggio all’universo femminile e alla sua rappresentazione da parte dei principali artisti italiani del secondo Ottocento, quali Giovanni Boldini, Mosè Bianchi, Pellizza da Volpedo, Domenico Induno, Giuseppe De Nittis (il nostro corregionale pugliese, nato a Barletta il 25 febbraio 1846 e morto a Saint-Germain-en-Laye – Francia – il 21 agosto 1884, un pittore italiano vicino alla corrente artistica del Verismo e dell’Impressionismo), Vincenzo Irolli, Alessandro Milesi, Stefano Noto, Ettore Tito e tanti altri ancora.
Location della rassegna:
La sezione “Dalla Scapigliatura alla Belle Epoque” è stata allestita alla Galleria “Bottegantica” di Milano, via Alessandro Manzoni 45;
La sezione ”Tra ritratto e paesaggio” è stata allestita alla Galleria d’Arte “Ambrosiana” di Milano, via Vincenzo Monti 2.
Qualche assaggio delle opera esposte:
“Prega il suo innamorato di perdonarla con mani incrociate e posizione di supplica”
(Titolo del quadro: “Litigio amoroso” di Vincenzo Irolli);
“Sospira accostando il suo volto a quello di un piccolo figlio da accudire e amare”
(Titolo del quadro: “Maternità” di Alessandro Milesi);
“Dipinge incurante di tutto, affondando il suo sguardo in una tela”
(Titolo del quadro: “La pittrice” di Mosè Bianchi).
Queste sono solo alcune delle figure femminili che compongono la galleria di volti, sguardi ed espressioni raccolti per la a mostra ed esposti nelle due sedi espositive.
“La donna nella pittura italiana dell’800” è un progetto ideato e firmato da Enzo Savoia e Francesco Luigi Maspes, che vuole documentare, in un percorso che collega la Galleria Bottegantica e la Galleria d’Arte Ambrosiana di Milano, il ruolo di protagonista che la donna ebbe nella seconda metà dell’Ottocento nelle opere dei grandi artisti di quel periodo. Un percorso con cinquanta opere suddivise nelle due sedi (rispettivamente, 30 e 20), che offre l’opportunità di ammirare quadri di intensa suggestione, tra i quali – ad esempio – i lavori del pittore Giovanni Boldini, straordinario interprete della bellezza femminile e protagonista assoluto della Belle Epoque parigina, attraverso una preziosa selezione di dipinti, tra cui Nudo di donna con calze nere, Donna in riposo, Giovane signora nell’atelier e le figure di Madame Lantelme e Irene Catlin: opere in cui la “donna” è rappresentata in sfolgoranti ritratti ufficiali, a volte in pose ardite e sofisticate, quasi teatrali.
Così come ci si può soffermare sul paesaggio bucolico di Ettore Tito in Prato in fiore (Bambini sull’altopiano di Asiago), dove donne e bambini sono immersi nel verde dell’altopiano, per l’appunto, di Asiago; un quadro che riesce letteralmente a far inchiodare l’occhio del visitatore sul dipinto.
E che dire dell’olio su tavoletta, dal titolo Ora del pasto, di Giuseppe De Nittis, raffigurante una gentile fanciulla intenta a lanciare pezzetti di cibo ad alcune anatre, ai bordi di un laghetto.
Le venti opere esposte presso la sezione della Galleria d’Arte Ambrosiana documentano, nello specifico, l’evoluzione dell’immagine femminile, sempre nella seconda metà dell’Ottocento, nei generi del ritratto e del paesaggio, in particolare, con artisti quali Mosè Bianchi, Enrico Crespi, Giuseppe De Nittis, Domenico Induno, Gaetano Previati, Daniele Ranzoni ed altri.
In estrema sintesi, la mostra si è prefissato – a quanto pare – l’obiettivo di intercettare e mettere in risalto un fenomeno che, nel periodo temporale cui si fa riferimento, aveva assunto grande risalto per quanto attiene alla posizione della “donna” nella pittura. Infatti, i movimenti intellettuali, i mutamenti politici, sociali e culturali che hanno investito l’Italia, particolarmente tra il 1800 e il 1900, hanno portato le donne (aristocratiche, nobili o popolane che fossero) ad assumere ruoli di primo piano nella nascente nuova società italiana, cambiamento che si è riflesso anche nell’arte.
Quindi, non più (solo) donne raffigurate con abiti sfarzosi, ingioiellate e colte nel momento migliore della loro bellezza, ma (pure) donne raffigurate in ogni occasione della vita, in ogni attimo della quotidianità e inserite nella vita del tempo, che testimoniano i cambiamenti dei tempi. Donne scoperte nei loro momenti più personali ed intimi, nella maternità, a volte anche nel lavoro umile; donne che assumono anche un ruolo ed una posizione diversa nei confronti dell’uomo.
“Charleston”, una city car da collezione …davvero speciale!

Alla stessa stregua della 2CV (la mitica due cavalli) che, in versione moderna, aveva brillantemente rimpiazzato, anche la C3 Pluriel della Citroën è stata da qualche tempo affidata alla storia e sostituita dalla nuova “cabrio” DS3.
Ma il pezzo forte della C3 Pluriel è rappresentato dalla versione “Charleston”, davvero unica e seducente.
La Citroën Special Edition C3 Pluriel Charleston, una versione speciale della city car francese (ved. foto a lato), venne presentata al Salone Mondiale di Parigi nel 2008, per celebrare i sessant’anni dalla nascita della 2CV, anch’essa a lungo prodotta nella versione Charleston con gli stessi colori, già a partire dal 1980. E le vendite di questa serie speciale iniziarono verso la fine dello stesso anno 2008 in Francia e all’inizio del 2009 in altri Paesi europei.
Passati 28 anni esatti dal suo debutto mondiale, la 2 cavalli Charleston saliva sulla macchina del tempo e riappariva al pubblico travestita da C3 Pluriel Charleston. Dal salone di Parigi del 1980 a quello del 2008, quasi per magia.
Alla sua uscita di scena, la C3 Pluriel risultava essere stata prodotta in soli 109.682 esemplari, di cui 30.000 in Italia e con un limitatissimo numero di pezzi in versione “Charleston”, il che può rilevarsi interessante per gli intenditori ed appassionati di “pezzi unici … e rari”.
Il binomio C3 Pluriel – 2CV in versione Charleston volle essere un omaggio a un mito, voluto da Citroën e reso possibile dalla somiglianza fra i due modelli.
2cv (due cavalli) Charleston
Così come la Citroën 2CV Charleston, anche la C3 Pluriel Charleston ha mantenuto la colorazione bicolore nero e bordeaux, sebbene con nuovi e più confortevoli interni, dai sedili in pelle alle finiture, commisurati al top della gamma di riferimento.
Seducente e complice, grazie al suo stile, al tetto apribile elettrico, ai quattro posti effettivi e alla versatilità d’uso, C3 Pluriel Charleston ha giocato apertamente la carta della seduzione, incurante del tempo che, inesorabilmente trascorre: la storia Citroën riscritta in chiave moderna.
Dal suo lancio è diventata un oggetto del desiderio, che ha catturato lo sguardo e suscitato emozioni.
C3 Pluriel ha colto l’occasione del Salone Mondiale di Parigi 2008 per sorprendere e guadagnare le luci della ribalta, vestendo la livrea Charleston, versione storica della 2CV.
C3 Pluriel ha ereditato dalla illustre sorella maggiore i valori di creatività, ottimismo, design, versatilità e differenziazione, e si è permessa di strizzarle l’occhio per celebrarne i 60 anni.
Perché “Pluriel”?
Alla lettera, tradotto dal francese, significa “plurale, ma più semplicemente perché si tratta di un’autovettura che si trasforma in quattro modelli, con piccole e semplici operazioni manuali:
- Una Berlina;
- Una Cabriolet;
- Uno Spider;
- Un Pickup.
Capito bene! Proprio così : quattro macchine in una sola autovettura!
Sin dal lancio, C3 Pluriel Charleston ha toccato un registro emotivo forte, identico a quello della sua illustre sorella maggiore, la 2CV, con la quale condivide i geni di creatività, ottimismo, design, versatilità e distinzione.
C3 Pluriel Charleston, in effetti, strizza l’occhio alla storia e fa un viaggio nel tempo, riscrivendo con modernità e qualità la storia Citroën e, per le sue caratteristiche che hanno attratto più generazioni nel tempo è riuscita a conquistare una buona fascia di amatori. Dal nostalgico della 2CV all’appassionato di design, che vuole viaggiare in un veicolo particolare, C3 Pluriel Charleston ha saputo attrarre e sedurre.
In verità, si tratta in genere di autovetture – quelle della Citroën – che non ammettono mezze misure, nel senso che, sul piano del gradimento, o piacciono da impazzire o non piacciono affatto e quindi non se le fila nessuno.
Ma, un fatto è certo: in Italia e all’estero proliferano “Fans Club Citroën” che organizzano raduni di auto d’epoca e che mantengono assidui rapporti tra loro.
E, dunque, come recita il vecchio andante, … non è bello quel che è bello, è bello quel piace!
Giovanni Saitto presenta a Poggio Imperiale il suo nuovo libro

“La rivoluzione agraria di Placido Imperiale e la fondazione di Poggio Imperiale”.
Questo il titolo dell’ultimo libro scritto dal nostro compaesano Giovanni Saitto, la cui presentazione avrà luogo domenica prossima 11 novembre presso i locali della Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale, sita nella locale Via Cavour, con inizio alle ore 17,30.
Relatori:
– prof. Francesco Barra, Ordinario di storia moderna presso l’Università di Salerno;
– prof. Michele Vespasiano, Storico di Sant’Angelo dei Lombardi;
– prof. Pasquale D’Avolio, Presidente Associazione “Amici della Laguna” di Lesina.
Moderatore: Loris Castriota Skandenberg, giornalista
Nel corso dell’evento sarà altresì celebrato, nel nome del comune “padre fondatore” Placido Imperiale, il gemellaggio tra l’Associazione Culturale Terra Nostra Onlus di Poggio Imperiale e la Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, attraverso la formale sottoscrizione, da parte dei due rispettivi Presidenti, della “Magna Carta” che ne stabilisce le finalità e gli intenti reciproci.
Nell’occasione verrà donata alla Pro Loco Alta Irpinia una stupenda tela raffigurante il Principe Imperiale.
E’ vero che l’anguria protegge il nostro cuore?
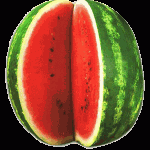
In questi giorni sta circolando, a livello mondiale, una notizia a dir poco strabiliante: l’anguria o cocomero che dir si voglia possiede proprietà protettive per il nostro cuore.
Pare che l’umile “cucurbitaceo” sia da considerare il nuovo salva-vita in quanto benefico per cuore, colesterolo e sovrappeso.
Che sia poi vero o meno, o che si tratti invece della solita bufala, non fa differenza, certo però che le argomentazioni addotte dagli esperti sembrerebbero davvero convincenti.
La rivista “Journal of Nutritional Biochemistry” ha recentemente pubblicato uno studio condotto da un team della Purdue University, nello stato americano dell’Indiana e della University del Kentucky, dal quale si apprende che i ricercatori hanno alimentato due gruppi di topi con una dieta ricca di acidi grassi e di colesterolo, dando al primo dei due gruppi acqua contenente il due per cento di succo di anguria, con i seguenti sorprendenti risultati: le cavie del primo gruppo hanno visto lievitare il loro peso del 30 per cento in meno rispetto agli altri topi, per effetto di una sostanza detta “citrullina” presente nel succo dell’anguria.
E .. pensare che solitamente in tono scherzoso (o a volte anche offensivo) il termine “citrullo” viene utilizzato per identificare una persona stupida, sciocca, facilmente raggirabile e poco furba!
Invece no, questa volta è proprio la “citrullina” a farla da padrona, come sostengono gli esperti delle due citate Università americane, i quali sostengono che essa potrebbe svolgere un ruolo importante anche nel sistema cardiovascolare dell’individuo.
Va detto, infatti, che, ad oggi, lo studio risulta essere stato eseguito solamente sui ratti, con la conseguenza che quelli nutriti con una dieta a base di succo di anguria presentavano un peso inferiore, meno colesterolo (il 50 per cento in meno di colesterolo LDL – il cosiddetto colesterolo cattivo) e meno placche aterosclerotiche (una riduzione del 50 per cento di placche nelle arterie) rispetto al relativo gruppo di controllo.
Ma, al di là di questo aspetto, è risaputo sin dall’antichità (pare che già gli antichi Egizi ne facessero grande uso) che l’anguria può essere consumata con assoluta tranquillità perché ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo, ma soprattutto perchè è il frutto che contiene in assoluto la maggiore quantità di acqua: circa il 95%; e si tratta, peraltro, di acqua biologica, purissima.
Sappiamo che, in passato, l’anguria ha anche rappresentato una sorta di protezione per la salute dei contadini del Sud i quali, durante le torridi stagioni estive nei campi, potevano dissetarsi, evitando così di bere l’acqua dei pozzi o cisterne, uniche fonti idriche nei periodi di siccità. Ma si trattava spesso di acque inquinate e dunque poco salubri. L’anguria, con i suoi dieci litri circa di acqua contenuti in un frutto rappresentava un vero e proprio salva-vita.
Si tratta di un frutto ricco di carotenoidi, vitamina A, antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle esposta al sole.
Inoltre è ricchissimo di fibre e di steroli vegetali, sostanze che vengono assorbite dall’intestino invece del colesterolo alimentare, abbassando così la colesterolemia.
Alcune delle informazioni contenute nell’articolo sono desunte da siti internet,
tra cui www.Italiasalute.it/ e http://gaianews.it/salute/
Presentato a Poggio Imperiale il libro di don Luca De Rosa
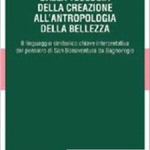
Ho il piacere di ospitare sul mio Sito/Blog www.paginedipoggio.com un nuovo articolo che l’amica Antonietta Zangardi ha scritto in occasione della presentazione del libro di don Luca De Rosa, parroco di Poggio Imperiale.
Questo, il titolo del libro:
De Rosa Luca
DALLA TEOLOGIA DELLA CREAZIONE
ALL’ANTROPOLOGIA DELLA BELLEZZA
Il linguaggio simbolico chiave interpretativa
del pensiero di san Bonaventura da Bagnoregio
Cittadella
Data di pubblicazione: marzo 2011
EAN: 9788830811272
E colgo l’occasione per formulare a don Luca le più vive congratulazioni per la pubblicazione di questa sua opera letteraria.
Buona lettura!
« Il 2 ottobre 2012 nella palestra comunale di Poggio Imperiale è stato presentato il libro del parroco don Luca De Rosa, “Dalla teologia della creazione all’antropologia della bellezza” il linguaggio simbolico chiave interpretativa del pensiero d San Bonaventura da Bagnoregio.
Un pubblico attento ed interessato ha seguito le esposizioni dei relatori, la prof.ssa Concetta Pacentra , docente di Filosofia, coordinatrice della serata, il prof. Michele Illiceto, docente di Filosofia e don Francesco Armenti, scrittore e giornalista.
San Bonaventura ed il suo umanesimo cristiano sono attualissimi.
Si hanno troppi preconcetti sul Medioevo e ci sono tanti luoghi comuni da sfatare, ma leggendo il libro di don Luca ed addentrandoci nel pensiero di San Bonaventura scopriamo come possa essere inserito a pieno titolo nel contesto storico in cui viviamo.
Ciascuno di noi è uscito dall’amore eterno e creativo di Dio e a Lui si dovrà tornare aderendo al Suo Mistero, un exitus ed un reditus , un’origine ed ritorno che dovrebbe farci pensare di essere imago Dei , pertanto attraverso Cristo dovremmo ritrovare la forza di ricercare la nostra origine, il senso della nostra esistenza e il nostro fine che è in Dio.
L’uomo, aperto all’infinito, sperimenta nella vita terrena un tendere continuo che nasce con la creazione a immagine di Dio. L’Assoluto è il fine, perché è l’origine.
Il concetto di “grazia” è ben presentato dall’autore perché in esso si compie la similitudine dell’uomo in Dio, che riunifica l’atto creativo e quello redentivo nello stesso Suo progetto salvifico.
In San Bonaventura non v’è dualismo e divisione in due mondi separati, corpo e anima, mondo materiale naturale e quello spirituale intellettuale, ma ogni uomo, pur vivendo nella natura, non si limita né si chiude in quest’unica dimensione. Emerge, quindi in sé con forza un desiderio di andare oltre il mondo, un bisogno, cioè di trascendersi e, con la grazia divina, di raggiungere lo status termini dell’eternità di Dio. La sete d’infinito che è in noi si placa solo in Dio.
Continui sono nella pubblicazione i riferimenti e le comparazioni con Sant’Agostino; anch’egli affermava che cercava Dio fuori di sé mentre Egli era dentro di lui.
Siamo nel mondo, ma non apparteniamo ad esso, viviamo nel tempo ma siamo protesi verso l’eterno, perché come immagine di Dio, portiamo in noi il sigillo di Dio. In questo si manifesta la nostra libertà: tendere a vivere la spiritualità senza farci condizionare dalla materia.
Chi è l’uomo libero? In che cosa consiste la libertà? Sono domande che sempre attanagliano l’uomo. Questi ricerca Dio come un pellegrino, un povero che cammina nel deserto, ma che sceglie la libertà, la vera libertà, che per San Bonaventura è rispondere alla chiamata di Dio, che è in noi sin dall’origine. La libertà dell’uomo è autentica quando risponde al progetto divino.
Tutti i beni del mondo sono per loro natura buoni, ma è l’uomo che deve decidere per quei beni che devono permettergli di raggiungere il fine supremo che è Dio. Finché l’uomo vive nel mondo, la sua libertà è sempre tentata dal peccato.
Le due facoltà, intellettiva ed affettiva, ragione e volontà costituiscono per l’uomo la partecipazione al mondo spirituale e a quello materiale che hanno in lui la loro unificazione. Questo concetto è stato ben attualizzato dal prof. Illiceto perché l’anima si mostra a immagine di Dio costituendo la base della dignità della persona. Per San Bonaventura il libero arbitrio è il fondamento della fede.
Altro tema di riflessione sulla pubblicazione è la conoscenza.
Scientia e sapientia sono le due possibilità di conoscenza dell’uomo. L’una riferita alla conoscenza umana e l’altra si colloca oltre la dimensione terrena, perché l’oggetto è Dio. Il vero sapere non può limitarsi solo alla scienza, perché risulterebbe limitante ed insufficiente, rispetto “all’anelito del cuore umano nella tensione verso l’infinito e l’assoluto”.
Ricercare la verità che è in noi, significa mettersi in ascolto e capire che solo Dio è l’unico che può dare risposte a quella sete di infinito che abbiamo dentro di noi. L’uomo centro dell’universo si distingue dagli altri esseri che abitano il nostro mondo per il sapere, che è conoscenza ed amore.
Il mondo soprannaturale è in continuità con quello naturale e San Bonaventura riconosce nell’uomo la capacità di vivere secondo un suo libero progetto in risposta all’iniziativa gratuita di Dio, che non contrasta con la libertà umana, ma aiuta a realizzare le più alte ispirazioni dello spirito umano.
Il peccato rompe quel rapporto di equilibrio che l’uomo aveva con il suo corpo e con il mondo, ma la redenzione operata da Cristo restituisce all’uomo la funzione di guida e di responsabilità nei confronti del mondo, affidatagli da Dio all’atto della creazione.
Punto centrale del libro è: l’idea della bellezza, nella quale confluiscono filosofia, teologia e mistica.
Possiamo notare come il simbolismo di San Bonaventura si riferisca a tre temi fondamentali: il sole è la Trinità, la luna è la chiesa e la stella è l’anima. Quando il credente vive in una unione profonda con Dio è necessaria la contemplazione.
Ecco la parte più attuale del pensiero bonaventuriano quando parla dell’uomo contemplativo che vive la mira pulchritudo.
L’uomo contemplativo
-stabilisce un rapporto di gioia con Dio, con sé stesso e con il prossimo;
-coglie la bellezza del creato nel suo ordine e nella sua armonia;
-sperimenta un senso di pace e di serenità interiore;
-sopporta le avversità;
-perdona le offese ricevute;
-vive nella pace con tutti;
-gioisce nella sobrietà e nella castità;
-vive una vera maturità umana;
-possiede un profondo senso dell’equilibrio;
-prende decisioni in maniera ponderata;
-giudica con giustizia ed animo retto;
-nel conversare con gli altri mostra gentilezza, discrezione e carità;
-possiede grande umiltà dovuta all’armonia raggiunta con Dio e con sé stesso.
Difficilissimo per l’uomo di oggi aspirare al possesso di tutte queste qualità, perché la possibilità di peccare è sempre in agguato.
Ecco perché l’uomo riconosce con umiltà il bisogno costante dell’aiuto divino. Abbiamo bisogno di fermarci e riflettere per evitare l’abuso della libertà, recuperando il valore della trascendenza. In un mondo secolarizzato non riusciamo più a capire che tutto è guidato dal Signore della storia che è Dio.
Il vero cristiano deve sapersi identificare con l’uomo contemplativo e tutta la comunità cristiana deve farsi guidare dalla carità, per la quale, secondo San Bonaventura, “ … gli altri non sono mai ridotti e considerati come ostacoli e come rivali, ma sempre come persone umane, che, aprendosi al Tu assoluto, formano comunità umane autentiche, caratterizzate dall’amore per l’altro e la solidarietà fraterna”.
Occorre, quindi superare a tutti i costi la categoria dell’antagonismo, perché il vero cristiano è l’uomo dell’incontro, della concordia, della pace e dell’armonia.
La teologia bonaventuriana ci propone un umanesimo integrale ed interpersonale sul quale riflettere per cambiare rotta alla nostra esistenza. Credo che tali riflessioni possono senz’altro servirci, per riacquistare una visione positiva del mondo, come dono dell’amore di Dio per noi, per allontanarci dai peccati tutti moderni e sempre in agguato, dal desiderio di sopraffazione dell’altro, dall’arrivismo, dal presenzialismo vano e dannoso, dal latrocinio, dalla cupidigia, dall’avidità, dalla pirateria informatica, dalla falsa testimonianza. In fondo basterebbe ogni tanto andare a rivederci i Comandamenti della Legge di Dio e fare vera penitenza, divenendo uomini religiosi mossi dal rispetto per le cose del creato e per i nostri fratelli ».
di Antonietta Zangardi
Il presente articolo è pubblicato anche su www.gazzettaweb.net
Per districarci tra i tanti termini economici!

Si fa oggi molta fatica, tra la gente, soprattutto tra la gente comune, a raccapezzarsi tra una miriade di termini di natura economica, che sistematicamente vengono “sparati a raffica” dagli schermi televisivi e sulla carta stampata. Termini che imbarazzano e al tempo stesso disorientano il cittadino, specialmente in questo periodo di grave crisi che sta attraversando il nostro Paese insieme ai nostri confratelli europei.
Proviamo quindi a stilare un elenco dei termini più ricorrenti, cercando di attribuire a ciascuno di essi il significato più appropriato.
L’esercitazione non servirà certamente a risolvere i problemi relativi alla crisi in atto ma, se non altro, ci aiuterà almeno a capire meglio di cosa i nostri economisti e politici stanno parlando!
ACCISA – Imposta indiretta sulla fabbricazione o vendita di alcuni beni, ad esempio la benzina.
ASSET – Termine inglese che si può tradurre con beni materiali o immateriali di un’impresa.
AVANZO PRIMARIO – Può essere definito come la differenza tra le spese pubbliche, escluse le spese per interessi, e il totale delle entrate.
AZIONI – Sono titoli che rappresentano una quota della proprietà di una società.
BENI RIFUGIO – Si intende un bene che ha un valore intrinseco, reale, e che tende a non perdere valore a seguito di un incremento del livello generale dei prezzi. L’esempio per eccellenza è l’oro, ma in generale costituiscono un bene rifugio tutte le materie prime preziose.
BOLLA IMMOBILIARE – E’ una bolla speculativa che si presenta periodicamente nei mercati immobiliari. E’ caratterizzata da un rapido aumento dei prezzi degli immobili che raggiungono livelli insostenibili in rapporto ai redditi medi o ad altri parametri economici.
BOND – Detti anche obbligazioni sono prestiti concessi dall’investitore a un emittente che può essere lo Stato, un ente pubblico o una società privata. L’obbligazione garantisce un rendimento a chi lo acquista e la restituzione della somma alla scadenza.
BTP – I Buoni del Tesoro Pluriennali sono titoli a medio-lungo termine emessi dal Tesoro con una scadenza che va fino ai 30 anni.
BUND – Sono i titoli di stato a medio-lungo termine emessi dal governo tedesco.
CLASS ACTION – E’ un’azione legale condotta da più soggetti che chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe.
DEBITO PUBBLICO – Per debito pubblico si intende il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti, individui, imprese, banche o stati esteri, che hanno sottoscritto un credito allo Stato sotto forma di obbligazioni o titoli di stato (in Italia: BOT, BTP, CCT) destinati a coprire il disavanzo del fabbisogno finanziario statale oppure coprire l’eventuale deficit pubblico nel bilancio dello Stato.
DEFAULT – Il termine indica l’insolvenza, l’incapacità di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento. Di default si parla anche nel caso di Paesi che non riescono a far fronte ai propri debiti.
DEFICIT – E’ la differenza negativa tra le entrate e le uscite del settore della pubblica amministrazione.
DEFLAZIONE – Opposto dell’inflazione, è la situazione economica in cui si registra una diminuzione del livello generale dei prezzi.
DIVIDENDO – La parte di utile che viene distribuito da una società ai suoi azionisti.
DOWNGRADE – Cambiamento negativo nel rating. Avviene quando un’agenzia detta appunto di rating abbassa il giudizio su un emittente.
EURIBOR – E’ il tasso medio con cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee. È stato creato contestualmente all’euro il primo gennaio 1999.
EUROBOND – Il termine indica obbligazioni del debito pubblico dei Paesi facenti parte dell’eurozona, emesse da un’apposita agenzia dell’Unione Europea e garantite congiuntamente dagli stessi Paesi dell’eurozona.
FISCAL COMPACT – Si tratta del patto fiscale europeo derivante dal “Trattato sulla stabilita’, sul coordinamento e sulla governance nell’Ue” nonché dal “Meccanismo Europeo di Stabilità – Mes” – al secolo “fondo salva stati”, finalizzato a vincolare i governi della cosiddetta “zona euro”.
FUTURE – I futures sono contratti a termine standardizzati con i quali una parte acquista o vende a un prezzo prestabilito una determinata quantità di beni o attività finanziarie, con consegna a una data futura.
HOLDING – Società finanziaria che ha quote di partecipazione in altre società in misura tale da poterne controllare la gestione.
OUTLOOK – Termine inglese con cui si indicano le prospettive dell’andamento di un titolo o di un Paese nel medio periodo.
PIL – Il prodotto interno lordo esprime il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti all’interno di un Paese in un certo intervallo di tempo (di solito un anno) e destinati ad usi finali.
PRESSIONE FISCALE – Indica il rapporto tra l’ammontare delle imposte e Pil.
PROFIT WARNING – Letteralmente ‘allarme sugli utili’, indica l’annuncio di una società quotata con il quale la stessa comunica che i suoi risultati saranno inferiori alle attese.
RATING – Operazione di valutazione, espressa tramite un voto in lettere, che sintetizza la situazione finanziaria di un’impresa o un Paese e ne misura il grado di solvibilità. Le più conosciute agenzie di rating sono S&P, Moody’s e Fitch. La tripla A è il massimo livello di affidabilità di un soggetto, con elevata capacità di ripagare il debito.
ROBIN TAX – E’ una maggiorazione dell’aliquota Ires introdotta da Giulio Tremonti con l’intento di tassare gli extra profitti delle società petrolifere quando i prezzi di petrolio e carburanti sembravano inarrestabili; una tassa che porta il nome dell’eroe leggendario Robin Hood che … “rubava ai ricchi per dare ai poveri”.
SPENDING REVIEW – La revisione (riduzione) della spesa pubblica da parte del Governo (decreto “Salva Italia”) per stimolare la crescita e la competitività, attraverso provvedimenti legislativi finalizzati ad eliminare sprechi e inefficienze, garantire il controllo dei conti pubblici, liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo, ridare efficienza al settore pubblico allo scopo di concentrare l’azione su chi ne ha bisogno.
SPREAD – Nel caso dei titoli di Stato rappresenta la differenza tra il tasso di rendimento di un’obbligazione governativa italiana, come il Btp, e il corrispettivo tedesco, il cosiddetto Bund.
STAGFLAZIONE – Indica la situazione nella quale sono contemporaneamente presenti un generale aumento dei prezzi (inflazione) e assenza di crescita dell’economia in termini reali (stagnazione).
STRESS TEST – Sono esami che consentono di verificare la tenuta del sistema bancario e la sua capacità di reggere l’impatto di uno scenario negativo.
SUBPRIME – I mutui subprime sono i prestiti concessi a soggetti meno facoltosi che non possono avere accesso ai tassi di interesse di mercato, in quanto hanno una storia pregressa di cattivi pagatori. I tassi più elevati rappresentano una condizione di rischio sia per i creditori sia per i debitori.
TOBIN TAX – La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l’economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa sulle transazioni finanziarie per stabilizzare i mercati valutari.
TRACCIABILITA’ – Sistema che consente di risalire alle somme pagate o incassate attraverso l’identificazione di ordinanti, beneficiari, date e importi.
VENDITE ALLO SCOPERTO – Chiamata anche short shelling, è un’operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non direttamente posseduti dal venditore allo scopo di riacquistarli in seguito ad un prezzo inferiore. La vendita allo scoperto viene perciò considerata un’operazione finanziaria di tipo prettamente speculativo.
VOLATILITA’ – Misura il grado di variabilità dei prezzi dei titoli azionari ed esprime l’ampiezza delle variazioni subite.
ZONA EURO – Viene informalmente detta zona euro o, altrettanto frequentemente, eurozona o eurolandia, l’insieme degli stati membri dell’Unione europea che adotta l’euro come valuta ufficiale. Attualmente (2012) la zona euro è composta da diciassette stati, tra cui l’Italia.
A Ripalta (di Lesina) un piccolo gioiello gotico, tutto da scoprire!

Una Chiesa-Abbazia di stile gotico, di cui ancora ben conservato l’elegante rosone e le monofore sulla facciata absidale.
Santa Maria di Ripalta è un complesso “cistercense” di origine medievale (XIII sec) di indubbio interesse che merita veramente di essere visitato, anche se risulta poco noto ai più, forse perché scarsamente pubblicizzato o fors’anche perché gli attuali eredi degli antichi proprietari del sito desiderano mantenere segretamente intatto il luogo, nella sua particolare autenticità.
E’ infatti accessibile solo la domenica mattina in occasione della celebrazione della Santa Messa, alle ore 9, a meno che non si riesca ad avere la fortuna di incontrare gli attuali proprietari di questo significativo monumento, gli eredi della famiglia Galante di Napoli, che saltuariamente dimorano in loco, nei loro possedimenti di Ripalta. Ed è proprio quello che è capitato a me e mia moglie nel corso delle recenti vacanze estive trascorse a Poggio Imperiale.
Un caloroso ringraziamento, dunque, non solo per la visita che ci è stata consentita di effettuare ma anche per la dovizia di particolari che ci sono stati forniti, nell’occasione, dai cortesi discendenti.
L’Abbazia è situata, come si è detto, in località Ripalta, una frazione di Lesina, in provincia di Foggia.
Si narra che qui si insediò ai primi del 1200 una comunità di Monaci Cistercensi provenienti dall’Abruzzo e, nel 1255, la favorevole situazione economica permise la costruzione di una “grangia”, in linea con le consuetudini dei complessi abbaziali cistercensi, come voluti da Bernardo, abate di Clairvaux, il quale, aspramente in disaccordo con il lusso delle chiese, si fece fautore di una sorta di Abbazia-Città, ove i monaci potevano lavorare i campi, pregare, scrivere manoscritti e produrre musica. Bernardo di Chiaravalle, in francese Bernard de Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon, 1090 – Ville-sous-la-Ferté, 20 agosto 1153), fu un monaco e abate francese, fondatore della celebre Abbazia di Clairvaux e di altri monasteri.
Nell’architettura cistercense, con il termine “grangia” si intendeva una costruzione chiusa, un capannone in cui si conservava il raccolto ma nello stesso tempo indicava pure un’azienda agricola comprendente oltre alla grangia propriamente detta, case, terreni e pascoli. Il termine grangia deriva dal francese e designa una fattoria, un ambiente più o meno grande con annesso un podere. L’ubicazione delle grangie era variabile, ciascuna abbazia ne aveva almeno una nelle vicinanze.
Le grangie cistercensi erano poste sotto la direzione di un converso detto “magister granciae”, assistito da alcuni altri conversi, e si componevano di braccianti agricoli salariati, mentre i mercenari in genere abitavano nelle immediate vicinanze della stessa grangia. È vero che le grangie non erano monasteri in senso stretto ma, come nei monasteri si praticava molto l’ospitalità, tanto che spesso nei documenti ad esse relativi si parla di un “frater hospitalarius”.
Santa Maria di Ripalta sorge a pochi chilometri dal lago di Lesina, sulla sponda del fiume Fortore, alla sommità di una rupe (e, da ciò, forse, “ Ripa alta”), in una località dove presumibilmente esisteva già un monastero benedettino dedicato alla Madonna. Fu per l’appunto una comunità di cistercensi provenienti da Casanova d’Abruzzo che nel 1201 vi si insediò, costruendovi una nuova chiesa o riadattando quella già presente, che venne ricompresa nella piccola Diocesi di Civitate (corrispondente all’attuale vicino comune di San Paolo Civitate) ed in seguito incorporata a quella di San Severo, presumibilmente nel 1580. Caduta in commenda e abbandonata in data imprecisata, probabilmente all’inizio del XVIII secolo fu affidata ai Celestini, dato che nel 1719 risultava aggregata ad una chiesa di San Severo, convento di questi ultimi. In commenda, “in commendam”, alla lettera significa “in affidamento”, che sta ad indicare essenzialmente un “beneficio” derivante da una rendita annessa ad un grado ecclesiastico o cavalleresco. Il cavaliere che ne era principale beneficiario veniva denotato con il termine di “commendatore”. Egli amministrava i beni costituenti la commenda che erano di proprietà dell’Ordine, trattenendo una parte delle rendite quale compenso del suo servizio.
Del complesso abbaziale rimane, seppure incompleta, soltanto la chiesa di Santa Maria, la cui pianta originaria era probabilmente a croce latina. Il corpo centrale sarebbe stato costituito da tre navate di cinque campate mentre ancora riconoscibili sono transetto e abside. Quest’ultima è a forma quadrata, affiancata a destra e a sinistra da due coppie di cappelle rettangolari che si aprono sul transetto, costituito da cinque campate.
Il villaggio di Ripalta costituisce uno dei pochi villaggi agricoli antichi del Tavoliere delle Puglie ancora esistente, nato a ridosso delle sponde del fiume Fortore, probabilmente anche in funzione dello scalo fluviale di Teanum Apulum (l’attuale vicino e già citato comune di San Paolo Civitate), qui esistente sin dall’ epoca romana.
Intorno alla Chiesa si svolgevano attività agricole e di allevamento, senza dimenticare il ruolo importante che il borgo ha assunto durante i secoli per l’attività della transumanza (la mena delle pecore attraverso cui le greggi venivano portate a svernare dall’Abruzzo alla Puglia), poichè Ripalta è situata proprio sul “Tratturo Magno”, che un tempo collegava la città di L’Aquila con quella di Foggia. Per tale motivo la Chiesa di Santa Maria viene altresì definita una “Masseria-Abbazia”.
Il disastroso terremoto del 1627 fece crollare una parte della Chiesa, che fu poi ricostruita per mano dei Celestini agli inizi del XVIII secolo. Nel 1806, quando l’Ordine dei Celestini fu soppresso, Gioacchino Murat donò Ripalta al suo Ministro di Polizia, che a sua volta la passò in dote alle sue figlie.
Gianfranco Piemontese, Docente di Storia dell’Arte, in “Segni lapicidi nell’Abbazia di Càlena (Peschici – Fg)”, www.reciproca.it, rinviene delle similitudini architettoniche e costruttive tra il complesso di Santa Maria di Ripalta e l’Abbazia di Càlena di Peschici, costruita presumibilmente intorno all’anno 872 e, quindi, tra le più antiche abbazie d’Italia, all’interno della quale era peraltro conservata un’antichissima statuetta lignea di Madonna con il Bambino di origine incerta. Per lungo tempo fu sede di un convento di monaci, mentre oggi è stata trasformata in una villa privata. Similitudini vengono altresì riscontrate con l’Abazia della Santissima Trinità di Venosa (Pz), la cosiddetta “Incompiunta”, che io e mia moglie abbiamo avuto il piacere di visitare due anni orsono, oltre che con l’Abbazia di Santa Maria delle Tremiti (Isola di San Domino, Tremiti, Fg), che abbiamo visitato lo scorso anno, e con ulteriori complessi monumentali pugliesi. E, questo, soprattutto in relazione all’opera di maestri scalpellini provenienti dal Nord Europa.
Il Piemontese sostiene, tra l’altro, che “Il complesso benedettino di Santa Maria di Càlena di Peschici (Foggia) contiene nelle sue strutture murarie la testimonianza di presenza e attività di maestranze lapicide [scalpellini, tagliapietre]. Una presenza dovuta sia alle dominazioni provenienti dal Nord Europa che alla circolazione degli stessi maestri scalpellini. Questi giunsero nel Meridione d’Italia sia come artigiani specializzati che nelle vesti di componenti gli ordini monastici. E’ noto a tutti quanto la regola benedettina recitasse in materia di lavoro. Attività pratiche che coinvolgevano il campo strettamente produttivo, dall’agricolo a quello dell’acquacoltura. Attività quest’ultima fortemente legata a una dieta alimentare priva di carni ma ricca di pesce, che vedeva la presenza, in quasi tutti i maggiori complessi monastici, di impianti adatti all’allevamento ittico in terraferma, le cosiddette peschiere. Tra le attività prettamente manuali vi era quella legata all’arte del costruire, e quindi ecco fiorire negli insediamenti monastici gruppi di monaci esperti scalpellini e muratori. Maestranze non prive di conoscenze legate alle tecniche e tecnologie costruttive. Un modo di costruire che si riscontra anche in un altro complesso monastico qual è l’ex abbazia di Santa Maria di Ripalta, nei pressi di Lesina (Foggia). La possibilità che le maestranze operanti a Càlena abbiano direttamente partecipato alla costruzione o abbiano influenzato quelle operanti in Santa Maria di Ripalta, si evince sia dal modo in cui i conci lapidei sono squadrati e posti in opera, che dalle soluzioni formali e tecnologiche impiegate nelle finestre e nelle arcate. Vi sono similitudini non solo nell’apparecchiatura muraria, ma anche negli elementi floreali scolpiti e posti a coronamento di capitelli o di semplici elementi di decoro della facciata, che rimandano a quegli stilemi dell’architettura cistercense di cui Santa Maria di Ripalta e la stessa Chiesa Nuova di Càlena sono testimonianza. Una struttura architettonica, quella di Càlena, passata dalla floridezza derivatagli dai numerosi e sparsi possedimenti (terreni ed immobili accumulatisi tra l’XI e il XIV secolo), all’abbandono ed alla sua attuale riduzione quasi a rudere. L’insediamento religioso benedettino, il cui impianto rimanda ad un’epoca precedente l’XI secolo, presenta una chiesa più antica ad impianto basilicale a tre navate, suddivisa da pilastri compositi a sezione rettangolare con presenza di cupole in asse nella nave centrale. La cosiddetta “chiesa nuova”, invece, presenta anch’essa tre navate, di cui due sono oggi praticabili mentre la terza, quella centrale, risulta scoperchiata. L’interno della navata presenta i pilastri delle campate con i tipici segni della predisposizione della copertura con volte a crociera: ovvero conci predisposti per i pennacchi d’imposta della volta di partenza. Allo stato dei fatti, la chiesa sembrerebbe avere avuto sempre una copertura a falde, sostenuta da capriate lignee e copertura con manto di tegole. Questa tesi troverebbe supporto nel fatto che, nonostante l’abbandono in cui versa attualmente la chiesa, all’interno, in situ, non si ha presenza dei conci e dei relativi pezzi di costoloni che una copertura a crociera per due campate di quelle dimensioni avrebbe sicuramente lasciato a terra in forma abbondante, né vi sono tracce di reimpieghi di conci sagomati provenienti da volte a crociera nelle opere murarie circostanti. Una possibile crisi economica dell’Abbazia avrebbe causato un fermo dei lavori che si è protratto nel tempo, sino a far optare, successivamente, per una copertura degli ambienti centrali con strutture lignee. Tesi, questa, che si avvale del confronto con due altre importanti chiese: quella della Santissima Trinità di Venosa (Pz) e quella di Santa Maria di Ripalta, entrambe rimaste incompiute, e che, seppur di dimensioni maggiori di quella di Càlena, presentano forti similitudini negli elementi architettonici strutturali e negli stessi segni lapidei. Come accennavamo sopra, le strutture murarie sono a paramento liscio, con le eccezioni dei capitelli su cui s’impostano gli archi ogivali che presentano lavorazioni simili agli ornamenti di tipo cistercense presenti anche nell’Abbazia di Santa Maria delle Tremiti, da cui peraltro Càlena dipendeva. Sono numerosi gli studiosi che hanno collegato la “chiesa nuova” di Càlena all’arte francese borgognona. Noi qui rileviamo che la similitudine di lavorazione della pietra e del disegno delle due finestre trilobate, presente sul lato sud, ricorda fabbriche presenti in Puglia, non solo di tipo religioso come Santa Maria di Ripalta o la cappella della Maddalena in San Domenico a Manfredonia, ma anche civili come testimoniano i capitelli presenti in Castel del Monte (Andria, Ba). L’attenzione di chi ha potuto visitare e studiare gli spazi di questa architettura, fra l’incompiuta e l’abbandonata, è rapita da una serie di segni incisi sui conci di archi e pilastri della struttura. Tipici segni, appunto, dei maestri muratori lapicidi, ovvero di coloro che del cantiere medievale erano i veri artefici. Si va da semplici monogrammi a composizioni geometriche dove al cerchio si unisce la retta o un archetto. Si riscontrano forti similitudini tra questi segni lapidei e quelli che si trovano sui conci di pietra della fabbrica delle mura angioine della fortezza di Lucera (Fg). Nell’ambito delle architetture religiose, ricordiamo anche Sant’Antuono, in territorio di Sant’Agata di Puglia (Fg). Qui si hanno finestre simili e identica lavorazione della pietra, conci perfettamente squadrati ed apparecchiati, anche se ad oggi non è stato rilevato alcun tipo di segno lapideo come a Càlena e a Ripalta. L’ulteriore conferma dell’origine d’oltralpe di parte dei “magistri” che hanno realizzato la chiesa nuova può essere attestata dalla presenza, oltre ai segni usuali in Francia e nel resto dell’Europa centro settentrionale, di un segno simile a quello riscontrato a Notre-Dame d’Orcival. Si tratta di una lettera, una ‹A› carattere capitale, con la linea orizzontale piegata a mo’ di cuneo verso il basso, e con un tratto orizzontale sulla punta. Lo stesso segno è presente sulla navata laterale destra di Càlena. La chiesa francese, al pari di quella di Càlena, risulta essere «…letteralmente coperta di marchi di costruzione», come scrive lo storico dell’arte Raymond Oursel a proposito di Notre-Dame d’Orcival”.
Per concludere, infine, l’Abbazia di Santa Maria di Ripalta potrebbe peraltro, a parere di chi scrive, considerarsi, a buona ragione, anche un sito localizzabile sull’antico “Cammino dell’Angelo”, un viaggio (a piedi) di 2859 km tra la Francia e l’Italia, un percorso che congiungeva spiritualmente, in passato, l’Adriatico alla Manica e che collegava idealmente la Puglia alla Normandia. Uno dei più antichi pellegrinaggi dell’Europa cristiana, un camminare verso Cristo sotto la guida di San Michele Arcangelo, un vivere l’esperienza dell’abbandono e dell’accoglienza, un pellegrinare verso orizzonti interiori, un incontrare migliaia di volti nuovi, da “Mont Saint Michel” in Normandia alla “Grotta dell’Apparizione di San Michele Arcangelo”, presso Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia, alla scoperta dei grandi Santuari dedicati a San Michele : Monte Sant’Angelo (Foggia); Castel Sant’Angelo (Roma); San Michele di Lucca; San Michele di Pavia; Sacra di San Michele (Monte Pirchiriano, Val di Susa, in Piemonte); Saint-Michel d’Aiguilhe e Mont Saint Michel, in Francia.
Il santuario di Monte Sant’Angelo ebbe così grande importanza nel medioevo da rappresentare una tappa obbligata dei pellegrini che andavano in Terra Santa (vi fece sosta anche San Francesco d’Assisi nel 1216). La lunga strada che partiva da Santiago di Compostela e giungeva a Monte Sant’Angelo prendeva nel suo tratto terminale il nome di “Via Sacra Longobardorum” (variante della “Via Francigena”). Durante il periodo delle Crociate, il Gargano con i suoi santuari era uno dei luoghi dove si potevano incontrare più frequentemente guerrieri, pellegrini e religiosi.
Il Santuario di Monte Sant’Angelo, in particolare, è uno dei tre maggiori luoghi di culto europei intitolati a San Michele, insieme alla “Sacra di San Michele” in Val di Susa, e a “Mont Saint-Michel” in Normandia. I tre luoghi sacri si trovano a 1000 chilometri di distanza l’uno dall’altro, allineati lungo una retta che, prolungata in linea d’aria, conduce a Gerusalemme.
Molto complessa è la storia delle vie di pellegrinaggio verso la grotta garganica di San Michele durante i 15 secoli della sua frequentazione. Nel medioevo il santuario garganico era anche uno dei quattro più frequentati luoghi di pellegrinaggio della cristianità, secondo l’itinerario di redenzione spirituale, noto come “Homo, Angelus, Deus”, che prevedeva la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo a Roma e di San Giacomo di Compostela in Spagna (Homo), all’Angelo della Grotta di Monte Sant’Angelo (Angelus), infine ai luoghi della Terra Santa (Deus).
Risulta che anche San Bernardo (quel “Bernard de Clairvaux”, riformatore dell’ordine cistercense, di cui si è parlato prima), in una sua visita in Puglia per far riappacificare Ruggiero II, re delle due Sicilie, con la Chiesa, volle venerare San Michele nella sua Grotta. Appare dunque logico e naturale pensare che l’abate francese abbia fatto sosta anche in un’abbazia cistercense ubicata a pochi chilometri di distanza da Monte Sant’Angelo, e cioè quella di Santa Maria di Ripalta.
A proposito della fondazione di Poggio Imperiale ….
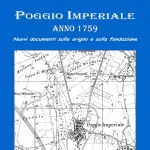
La storia delle origini di Poggio Imperiale ha destato – soprattutto negli ultimi decenni, a partire da “Poggio Imperiale, Noterelle paesane” di Alfonso De Palma, Edizione “ il Richiamo” del settembre 1984 – l’interesse da parte di alcuni nostri insigni concittadini, in particolare Alfonso Chiaromonte e Giovanni Saitto, che hanno sapientemente effettuato al riguardo approfondite ricerche, consentendoci così di poter allargare i nostri orizzonti conoscitivi rispetto alle scarne e superficiali notizie tramandateci dai nostri avi.
Ora, Antonietta Zangardi (1) aggiunge un nuovo tassello al mosaico che nel tempo si è andato componendo, con l’apporto di ulteriori ed inedite informazioni sulla base di ben settantadue nuovi documenti che riguardano il periodo temporale che va dal 1751, anno dell’acquisto del feudo di Lesina da parte del Principe Placido Imperiale, al 1765, anno di sviluppo economico ed incremento demografico di Poggio Imperiale, colonia agricola fondata verosimilmente nel 1759.
Poggio Imperiale
Anno 1759
Nuovi documenti sulle origini e sulla fondazione
Edizioni del Poggio, maggio 2012
Questo è il titolo del nuovo ed interessante libro di Antonietta Zangardi.
A quanto pare, l’Autrice si è posta l’obiettivo di penetrare più efficacemente nella fitta coltre di nebbia che per anni aveva offuscato la storia delle origini di Poggio Imperiale, anche se, in verità, tanto è stato già fatto dai nostri studiosi e ricercatori di storia patria poggioimperialesi.
E la lettura, l’analisi e il confronto degli ultimi documenti rinvenuti dalla Zangardi nella sua opera di ricerca, porterebbero ad intravedere nuovi spiragli di considerazione rispetto alla data effettiva della fondazione di Poggio Imperiale, che verrebbe fatta risalire al maggio del 1759 e non al cosiddetto “patto degli albanesi del 18 gennaio 1761”.
Tesi, quest’ultima, suffragata anche dalla copia della relazione per la visita pastorale del vescovo di Lucera, Mons. Giuseppe Maria Foschi, dalla quale risulterebbe che, “al loro arrivo”, vi era impiantato un nucleo di abitanti cosiddetti regnicoli, cioè italiani, già dal maggio del 1759.
In via prudenziale, il condizionale è d’obbligo, anche se la documentazione reperita, analizzata e resa pubblica porta a ritenere attendibili sia le considerazioni svolte, sia le conclusioni alle quali l’Autrice è pervenuta.
Attendibilità avvalorata, peraltro, anche dall’autorevolezza del noto studioso e scrittore dauno Mario A. Fiore che ha curato la Prefazione del libro citato.
Orbene, alla luce di quest’ultimo contributo della Zangardi, la data di fondazione di Poggio Imperiale parrebbe ora risalire al 1759, risultando all’epoca già “impiantato il primo agglomerato urbano”, piuttosto che al 1761, con ciò sfatando il mito secondo cui furono gli albanesi, arrivati in quell’anno, a fondare la “nuova terra”, denominata per l’appunto “terranova” (in dialetto “tarranòve”).
Non v’è dubbio sul fatto che i recenti documenti portati alla luce dalla Zangardi siano meritevoli di considerazione per quanto attiene alla loro attendibilità e, non di meno, anche della dovuta attenzione per le novità addotte.
Ma, ad onore del vero, queste ultime novità denotano un fatto molto importante, che non può di certo sfuggire all’osservatore più attento, e cioè che la storia delle origini del nostro giovane paese è ancora “in fieri” e cioè in via di formazione, in divenire.
Risulta di indubbio pregio la portata delle informazioni reperite e rese pubbliche dagli odierni studiosi poggioimperialesi nel corso delle ricerche e degli studi sinora eseguiti, ma vi è ragione di ritenere che esistano ancora ampi margini di esplorazione possibili.
Ritengo, personalmente, che il culto delle tradizioni poggioimperialesi e l’amore della storia del nostro paese debbano prevalere, sempre, su qualsiasi posizione preconcetta e rappresentare il vero collante nella ricerca delle nostre comuni radici.
E, dunque, in proposito … perché non avviare, ad esempio, un dibattito costruttivo tra studiosi della materia al fine di individuare un percorso comune per “scrivere” insieme la storia delle origini di Poggio Imperiale?
(1) Antonietta Zangardi, laureata in materie letterarie, vive a Poggio Imperiale dove ha insegnato nella locale Scuola Secondaria di I grado per trent’anni ed è stata fiduciaria e responsabile per più di quindici anni. E’ abilitata all’insegnamento di Italiano e Storia negli Istituti Superiori. Ha diretto la collana di narrativa “il piacere di leggere”. Ha pubblicato “Federico II, Terzo Vento di Soave” per adolescenti e la silloge “Sottovoce, parole e versi in libertà”. Si è sempre attivamente interessata alla storia di Poggio Imperiale ed allo studio dei documenti.